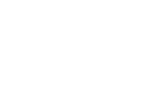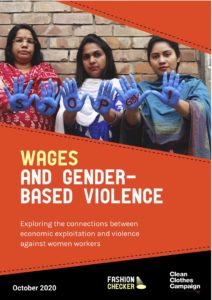 Pubblichiamo oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ultimo position paper internazionale della Clean Clothes Campaign che descrive le condizioni delle lavoratrici tessili nel mondo, formula richieste ai brand e promuove raccomandazioni ai governi.
Pubblichiamo oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ultimo position paper internazionale della Clean Clothes Campaign che descrive le condizioni delle lavoratrici tessili nel mondo, formula richieste ai brand e promuove raccomandazioni ai governi.
La violenza sulle donne nel mondo è strutturale, e non si esprime soltanto nella violenza fisica e nelle minacce alla sicurezza personale delle donne. Com’è noto, anche aspetti di carattere economico, quali ad esempio il secolare divario salariale fra uomini e donne, incidono sulla mancata emancipazione delle donne e sulla loro costante dipendenza, intrisa di violenza, da un sistema retto dal potere maschile. Se questo è vero, com’è vero, nei nostri paesi occidentali (inclusa l’Italia), nei paesi il cui sistema economico si basa sulla produzione ed esportazione tessile (a cominciare da quelli del Sud Est asiatico) il fenomeno della violenza di genere sul luogo di lavoro assume dimensioni paurose e inaccettabili. Ciò fa rabbia, se consideriamo che le donne costituiscono la maggioranza della forza lavoro nel tessile, dunque di fatto reggono e sostengono l’economia e il relativo benessere degli Stati a cui appartengono, nonostante siano tenute in una condizione di costante sottomissione.
Infatti, non troviamo quasi mai le donne al vertice delle fabbriche tessili. L’industria tessile, di fatto, facilita strutturalmente la violenza e le molestie contro le lavoratrici: la maggioranza della forza lavoro è femminile, e comprende spesso donne molto giovani e migranti; i salari sono estremamente bassi, la pressione sulla produzione è alta e le lavoratrici spesso non sono rappresentate, poiché i sindacati esistenti non hanno quasi mai donne al vertice.
Non solo, ma le condizioni di lavoro in cui versano le operaie tessili nei paesi di produzione sono precarie, con contratti a breve termine (il cui potere di rinnovo è in mano ai proprietari delle fabbriche) oppure addirittura a cottimo. E’ molto difficile far emergere il clima di violenza attorno al lavoro nelle fabbriche tessili: le donne non ammettono di subire violenze (fisiche, verbali, psicologiche) proprio perché dipendono dal proprio lavoro in modo vitale. Se chi ti molesta sessualmente è il tuo capo, e temi di essere licenziata se resisti, o se quel salario irrisorio ti serve a nutrire i tuoi figli, di certo non denuncerai lo stato di violenza in cui vivi.
Quanto sopra è confermato da un recente studio condotto da Femnet (organizzazione che fa parte della CCC) con il Bangladesh Center for Workers Solidarity e che rivela che il 75% delle 642 persone intervistate (può sembrare un campione ridotto, ma va considerato che condurre studi siffatti non è certamente una passeggiata, proprio a causa della violenza strutturale del contesto) ha avuto esperienze di violenza di genere sul luogo di lavoro, incluse molestie e violenza sessuale.
Lo ripetiamo: la violenza di genere è anche economica. Le donne ricevono meno soldi per un lavoro di pari valore, sono più spesso oberate di lavoro, sono sottopagate. Ciò implica che molte donne non sono solo costrette a fare gli straordinari, ma hanno anche bisogno di svolgere altri lavori retribuiti (compreso la confezione di capi a cottimo, da casa) per sbarcare il lunario. In molte famiglie, la donna è l’unica che guadagna, e tuttavia, poiché è una donna, ci si aspetta che svolga anche lavori domestici e di cura oltre al lavoro retribuito, comportando un doppio onere.
I salari di povertà mettono le donne in una situazione così drastica che fa sì che spesso sono costrette a subire altre forme di sfruttamento e violenza, compreso il rischio di sfruttamento sessuale, lavoro minorile e tratta.
La pandemia di Covid19 ha aggravato in modo evidente la situazione di violenza di genere sistematica che caratterizza la vita dentro e fuori la fabbrica. Come sappiamo, molti brand hanno sospeso ordini e pagamenti in corso, e ciò ha creato la perdita del lavoro per molti lavoratori e lavoratrici della filiera tessile. La quarantena ha aumentato i casi di la violenza domestica e la povertà assoluta. Infine, molti lavori essenziali, e cioè di cura e assistenza, per esempio sanitaria, sono svolti da donne, che si sono pertanto trovate più esposte al contagio.
Cosa possono fare i brand committenti, di solito occidentali, per superare la violenza di genere nelle fabbriche tessili? Innanzitutto, potrebbero rivedere le proprie pratiche di acquisto dai propri fornitori. Il capitalismo impazzito della fast fashion, con le sue cinquanta collezioni all’anno per brand, si sfoga proprio sulla forza lavoro (femminile, appunto). E’ indubbio che le pratiche di acquisto di aziende di marchi internazionali contribuiscono direttamente alla violenza e molestie nelle fabbriche tessili: la direzione spesso minaccia di licenziare se certi gli obiettivi non sono raggiunti e non esita a imporre turni doppi e straordinari, e non è raro che venga usata la violenza fisica per far lavorare le operaie sempre di più. Inoltre, la pressione sui prezzi da parte dei brand che piazzano gli ordini riduce la capacità dei fornitori di pagare adeguatamente la propria forza lavoro, che come sappiamo è principalmente femminile, aumentando la dipendenza economica strutturale delle donne lavoratrici, cosa che rende loro sempre più difficile ribellarsi, in un circolo vizioso che non fa altro che mantenere le lavoratrici soggiogate.
I brand dovrebbero pagare di più per i loro ordini, non stressare le fabbriche con tempi di consegna e commesse inumani, condurre specifiche due diligence di genere dei propri fornitori così come audit specifici, ed offrire alle operaie delle loro filiere canali e reti appositi perché possano difendersi dalla violenza sul luogo di lavoro.
Ma i comportamenti volontari, per quanto virtuosi, non bastano. I governi, a partire da quelli dell’Unione europea, dovrebbero unirsi in una sola voce contro la violenza di genere sul luogo di lavoro, a cominciare dalla ratifica della Convezione 190 dell’Organizzazione mondiale del lavoro approvata nel 2019 e non ancora ratificata da alcuno stato europeo (gli unici paesi che hanno già ratificato questa Convenzione sono le isole Fiji e l’Uruguay). Il tempo è poco, perché c’è tempo solo fino al 25 giugno 2021. Cosa stiamo aspettando?