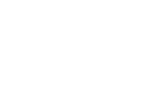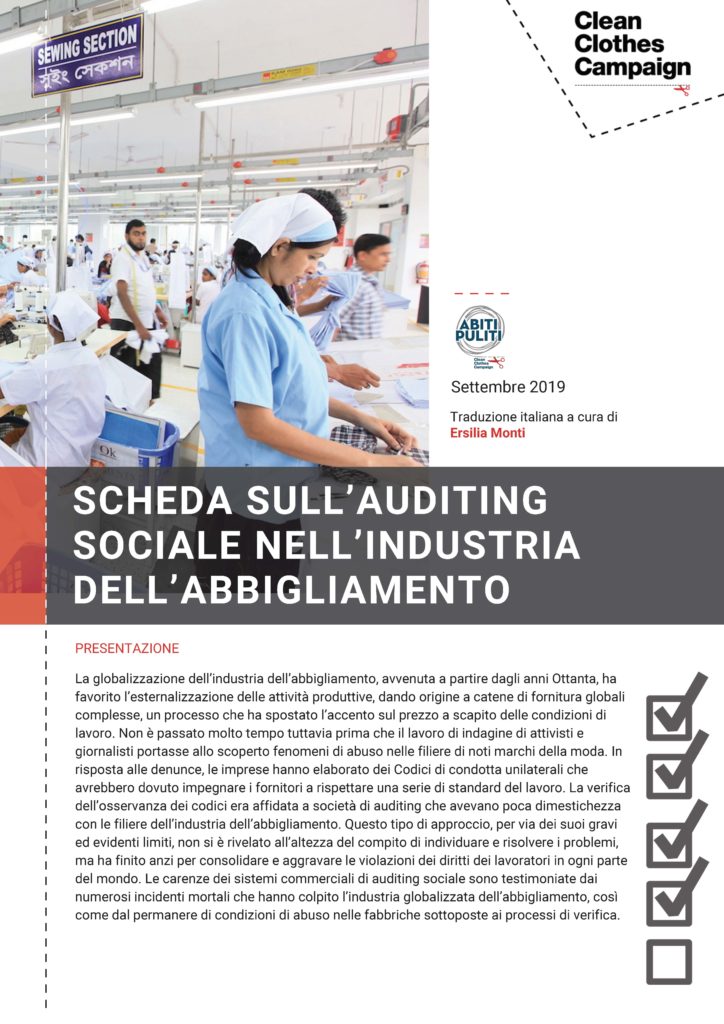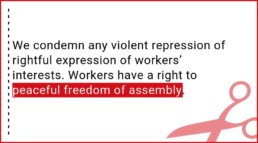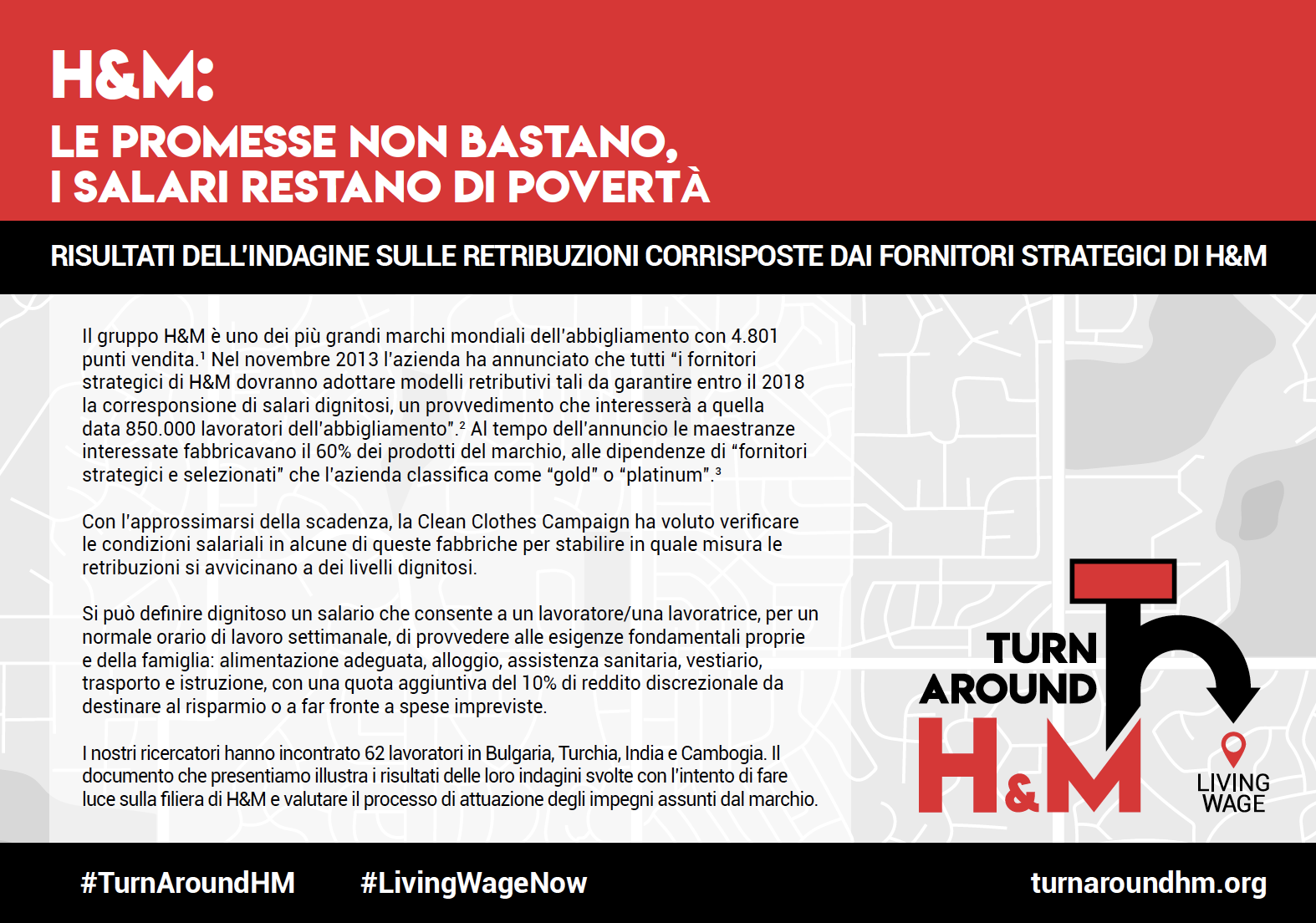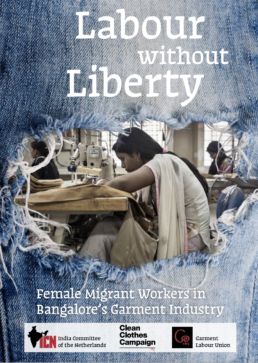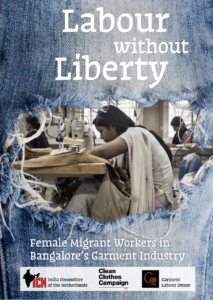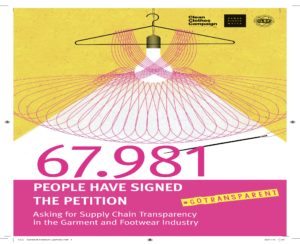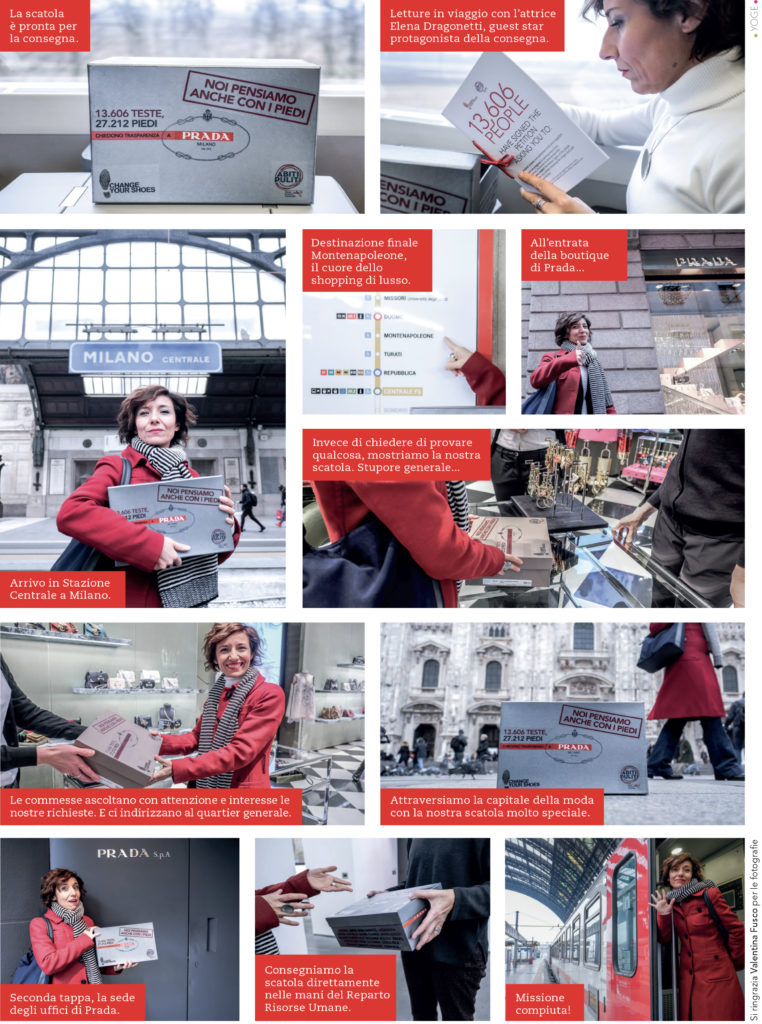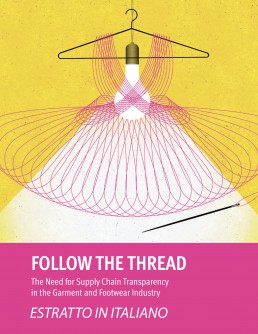Chi salverà i lavoratori che producono i nostri vestiti?

di Deborah Lucchetti, coordinatrice della Campagna Abiti Puliti
Un documento del Worker Rights Consortium, redatto in collaborazione con la Clean Clothes Campaign, propone un primo ragionamento sugli impatti che l’attuale pandemia da coronavirus avrà sui lavoratori del settore moda. I Paesi ricchi metteranno a disposizione misure economiche mai viste per fronteggiare la crisi, proteggere le loro imprese e i lavoratori. Ma cosa succederà agli operai del tessile-abbigliamento, addensati in Paesi a basso reddito dove le infrastrutture sociali per tutelare i lavoratori dalle crisi spesso non esistono o sono fragili?
Parliamo di 150 milioni di persone che producono beni per l’America del Nord, l’Europa e il Giappone e altre decine di milioni impiegati nei servizi. Nel solo settore tessile-abbigliamento sono almeno 50 milioni di operai, quasi tutte donne, con stipendi di povertà senza alcuna possibilità di accumulare risparmio.
Il documento prova a identificare i fattori che stanno esacerbando la crisi per quei settori, come la moda, basati su un modello produttivo insostenibile (la fast fashion) e su filiere globali che hanno deliberatamente prodotto una limitazione delle responsabilità dei marchi committenti verso i fornitori, terminali ultimi delle conseguenze della crisi. Il rischio, che in alcuni casi è già una realtà, è che i grandi player del mercato utilizzino la pandemia per giustificare pratiche commerciali piratesche (cancellazione degli ordini in corso o addirittura già in consegna, rifiuto di pagare per merce già prodotta, etc..). Le imprese fornitrici, prive della forza economica necessaria, non potranno difendersi legalmente e, operando con margini bassissimi, non avranno le riserve finanziarie, né l’accesso al credito, per resistere allo shock prodotto dal blocco globale delle vendite.
In molti Paesi produttori i governi non finanziano direttamente le misure legali di protezione sociale per chi perde il lavoro: impongono di farlo ai datori di lavoro. Il problema è, come sempre, l’applicazione di tali obblighi: le imprese, in assenza di continuità produttiva per la cessazione degli ordini per il mercato estero, potranno sottrarsi con facilità alle loro responsabilità. Milioni di lavoratori informali o precari saranno comunque esclusi dai benefit. Inoltre, per i lavoratori che saranno costretti a recarsi in fabbrica si fa scottante il tema della sicurezza: è molto improbabile che siano messe in atto misure e protezioni individuali adeguate a garantire il distanziamento sociale in strutture normalmente sovraffollate.
E’ chiaro che sarà necessario un massiccio intervento pubblico per prevenire la catastrofe economica e sociale. Ed è altrettanto chiaro che i Paesi a basso reddito, con finanze scarse e infrastrutture di protezione sociale deboli o inesistenti, non saranno in grado di fronteggiare le conseguenze strutturali della crisi a medio e lungo termine. Ma i pacchetti finanziari messi in campo dai governi a capitalismo maturo non paiono mettere in conto misure di sostegno a favore di coloro che hanno prodotto in larga parte la ricchezza delle loro multinazionali: i milioni di lavoratori del Sud e dell’Est globale sono i grandi esclusi dai salvataggi in epoca di pandemia.
Per affrontare questa drammatica crisi e dare risposte ai lavoratori più vulnerabili delle catene di fornitura globali, occorre uno sforzo congiunto che veda da una parte i grandi marchi assumere condotte responsabili nella gestione dei rapporti commerciali con i fornitori per consentire loro di onorare gli obblighi verso i dipendenti; dall’altra la necessità di una risposta collettiva da parte di tutti i governi, delle istituzioni finanziarie e degli organismi internazionali affinché sia possibile mantenere un reddito a tutti lavoratori nel mondo oggi sull’orlo del baratro. I marchi, invece di spostare tutto il peso sulla filiera, devono condividere la responsabilità e i costi finanziari della crisi, mettendo al centro delle loro priorità il rispetto degli obblighi verso i fornitori e verso tutti i lavoratori. Queste risorse non saranno comunque sufficienti: perciò è necessario che i piani di salvataggio multimilionari predisposti dalle istituzioni internazionali e dai governi ricchi guardino anche ai destini dei soggetti più vulnerabili dispersi nelle catene globali di fornitura.
Gli aiuti futuri destinati ai Paesi produttori per far fronte alla crisi Covid-19 dovranno essere condizionati da una parte all’impegno dei loro governi a creare, nel medio periodo, robusti sistemi nazionali di protezione sociale; dall’altra all’impegno delle imprese multinazionali a siglare accordi vincolanti di filiera che riflettano prezzi di acquisto sufficienti a garantire il finanziamento ordinario di tali sistemi di protezione.
L’attuale pandemia svela definitivamente l’estrema insostenibilità di un modello di business basato sullo sfruttamento endemico di milioni di lavoratori che ricevono salari di povertà, su una forte asimmetria di potere tra marchi e fornitori che permette ai primi di addossare tutte le responsabilità alle parti deboli della filiera, su una totale assenza di accountability da parte delle imprese committenti che dovrebbero invece essere obbligate per legge alla dovuta diligenza sui diritti umani per identificare, prevenire, mitigare e riparare i danni derivanti dagli impatti delle loro attività economiche sulle comunità e sui lavoratori.
Una cosa è certa. Questa crisi offre l’opportunità di ripensare il modello di produzione e consumo patologico che ha inasprito l’attuale catastrofe economica perché non si torni al passato. E’ imperativo usare questo tempo drammatico e fecondo per gettare le basi per una industria più equa, sostenibile e resiliente nei fatti, non solo nelle pagine patinate dei rapporti di sostenibilità o dei codici di condotta unilaterali che popolano i siti delle imprese.
Coronavirus: i marchi tutelino i lavoratori del tessile
I marchi devono assumere misure immediate per minimizzare l’impatto del coronavirus sulla salute e la vita dei lavoratori del settore moda.
Il nuovo coronavirus ha raggiunto livelli di pandemia globale e sta colpendo le persone in tutto il mondo, compresi i lavoratori dell'abbigliamento nelle catene di fornitura globali. Proteggerli significa prendere misure per limitare la loro esposizione e garantire che chi lotta quotidianamente per la sopravvivenza non sia spinto sotto la soglia di povertà.
A causa infatti dei bassi salari e della diffusa repressione della libertà di associazione, i lavoratori tessili vivono già in situazioni precarie e le ricadute economiche della pandemia stanno avendo conseguenze di vasta portata.
Esortiamo tutti i marchi dell’abbigliamento ad adottare immediatamente misure proattive di due diligence per proteggere i lavoratori che producono le loro merci: i marchi devono assumersi le loro responsabilità e garantire che coloro che hanno reso possibili i loro profitti non si facciano carico dell'onere finanziario di questa pandemia.
Molte fabbriche nei paesi produttori stanno chiudendo o sono a rischio di chiusura a causa della scarsità di materie prime, della riduzione degli ordini e delle preoccupazioni per la salute pubblica. I lavoratori dell'abbigliamento guadagnano già uno stipendio da fame, con salari che coprono a malapena le loro esigenze di base, senza lasciare nulla in più per gestire le emergenze o i periodi di assenza dal lavoro. Queste chiusure, sia temporanee che permanenti, li stanno spingendo verso il baratro - soprattutto i lavoratori migranti che potrebbero non avere reti sociali locali su cui fare affidamento e potrebbero dover affrontare ulteriori restrizioni o attacchi xenofobi.
Secondo le inchieste dei media e le informazioni che abbiamo raccolto attraverso la nostra rete di partner, i Paesi più colpiti sono lo Sri Lanka, il Bangladesh, l'Indonesia, l'Albania e gli stati dell'America centrale.
“I lavoratori tessili vivono alla giornata. Se perdono il lavoro, perderanno il loro salario mensile che gli permette di mettere in tavola il cibo per loro e per le loro famiglie", ha detto Kalpona Akter, presidente del Bangladesh Garment & Industrial Workers Federation. "In caso di licenziamento dei lavoratori, i marchi dovrebbero garantire pagamenti immediati ai fornitori, in modo che i lavoratori possano ricevere piena indennità di licenziamento come previsto dalla legge".
Già da alcune settimane la situazione è particolarmente grave in Cambogia e in Myanmar. Circa il 10% delle fabbriche di abbigliamento nella regione di Yangon in Myanmar è temporaneamente chiuso e i lavoratori non ricevono il loro stipendio. Il trattamento di fine rapporto, che spetta se la chiusura della fabbrica dura più di tre mesi, ammonta solo alla metà dello stipendio mensile per ciascun anno di lavoro, dopo un periodo iniziale di prova di sei mesi. Molte fabbriche in Myanmar hanno aperto solo negli ultimi cinque anni, il turnover dei lavoratori è molto alto e quindi molti di essi rimarranno senza nulla. Secondo i nostri contatti le chiusure delle fabbriche sono utilizzate anche per reprimere la libertà di organizzazione dei lavoratori in tutto il Paese.
I lavoratori temono inoltre che il coronavirus abbia un impatto sul loro diritto alle festività pubbliche pagate. Il Festival dell'acqua, il Capodanno del Myanmar, si svolge in aprile e viene celebrato ogni anno con congedo pagato di dieci giorni. Quest'anno i festeggiamenti pubblici sono stati cancellati a causa dei timori di infezione e i lavoratori temono che le fabbriche non permettano loro di prendere il congedo, contando invece ogni assenza come malattia non retribuita.
Il quadro in Cambogia è altrettanto preoccupante: decine di migliaia di lavoratori dell'abbigliamento potrebbero perdere il lavoro nelle prossime settimane, se la situazione delle materie prime non migliora. Secondo la legge nazionale, i datori di lavoro devono richiedere l’autorizzazione per sospendere i lavoratori, cui devono corrispondere il 40% dei 190 dollari di salario minimo mensile e dare la possibilità di seguire corsi di formazione, per guadagnare un ulteriore 20%. Tuttavia i rapporti governativi ora suggeriscono che i lavoratori potrebbero ricevere il 60% del salario minimo per soli sei mesi e diverse imprese hanno già sospeso i lavoratori senza autorizzazione. Molti di essi vivono già indebitati, chiedendo prestiti per compensare le carenze del loro misero salario, ora si trovano in una situazione in cui non possono permettersi di pagare le rate mensili, rischiando anche di perdere eventuali terreni di famiglia messi a garanzia.
"I marchi di abbigliamento hanno tratto profitto dal lavoro degli operai cambogiani. Ora devono fare un passo avanti in questo periodo di crisi e garantire la protezione della loro vita e dei loro mezzi di sussistenza. I lavoratori dovrebbero poter rimanere a casa fino a quando la situazione non sarà gestibile e i marchi devono garantire che ricevano il loro stipendio regolare, bonus di presenza e indennità di trasporto e alloggio durante tutto il periodo", ha dichiarato Tola Moeun, Direttore Esecutivo del Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL).
I brand devono stare al fianco dei lavoratori che confezionano i loro abiti e attivarsi immediatamente per garantire che continuino a ricevere il loro salario durante le chiusure delle fabbriche o le assenze per malattia. Chiediamo ai marchi di impegnarsi pubblicamente a svolgere un'adeguata due diligence per quanto riguarda gli eventi che si verificheranno in seguito alla diffusione del COVID-19.
In particolare, nel momento di una crisi pandemica, i marchi devono:
- Garantire che le fabbriche fornitrici rispettino gli obblighi o le raccomandazioni governative sulla sospensione dei grandi raduni e se necessario la chiusura delle fabbriche per la durata appropriata a proteggere la salute dei lavoratori e delle loro comunità, mantenendo in essere al tempo stesso i contratti di tutti i lavoratori e il pagamento regolare di tutti i loro salari;
- Garantire che i lavoratori che vengono mandati a casa per mancanza di lavoro siano coperti con il loro pieno e regolare salario;
- Garantire che i lavoratori che contraggano il virus, o che sospettino di averlo, possano prendere un congedo per malattia senza ripercussioni negative e siano retribuiti con il loro pieno e regolare salario durante tutto il periodo di recupero e di autoisolamento;
- Garantire che, alla riapertura delle fabbriche, le scadenze degli ordini siano rivalutate per evitare che i lavoratori facciano gli straordinari obbligatori per recuperare i ritardi;
- Garantire che le misure di lotta contro il virus non limitino indebitamente la libertà di movimento dei lavoratori o la loro libertà di organizzazione.
In tempi di paura e disinformazione è di vitale importanza astenersi dal diffondere informazioni non verificate e assicurarsi che tutte le comunicazioni sul virus e le sue conseguenze si basino su fonti affidabili. I marchi devono garantire che i lavoratori delle fabbriche fornitrici ricevano informazioni accurate e aggiornate dai loro datori di lavoro.
In un periodo di crisi, la forza si trova nella solidarietà e siamo orgogliosi di far parte di una comunità globale. Ci schieriamo con i lavoratori i cui diritti sono violati ogni giorno e che stanno affrontando battaglie economiche ancora più grandi a causa di questa pandemia. La necessità di lottare per i diritti dei lavoratori continua oggi più che mai e all’ombra di questa crisi la necessità di un salario dignitoso si fa sempre più incombente.
La risposta congiunta della società civile allo studio della Commissione Europea sul dovere di vigilanza nella catena di fornitura
Nove organizzazioni e reti della società civile - inclusa la Clean Clothes Campaign - accolgono molto positivamente i risultati dello studio della Commissione Europea sui requisiti di due diligence per la catena di fornitura pubblicato a Febbraio 2020.
EVENTO: Facciamo luce sul lato oscuro della moda
3 VIDEO-DOC E 1 GRANDE EVENTO PER SVELARE LE TRAME DELLA FAST FASHION
18 marzo | 23 aprile | 27 maggio 2020
Preparatevi! #cambiamoda #trasparenza #nomoreranaplaza

Photo © Edu Lauton
(2019) REPORT: Impegno per la trasparenza: scopri come si comportano i marchi della moda
Nel 2016, una coalizione di sindacati e organizzazioni della società civile impegnate nella difesa dei diritti umani e dei lavoratori ha dato vita all’Impegno per la Trasparenza (Transparency Pledge), un insieme di requisiti minimi per rendere trasparenti le catene di fornitura dei brand e permettere ad attivisti, lavoratori e consumatori di ricostruire la provenienza dei beni prodotti.
Il rapporto “La prossima tendenza della moda: accelerare la trasparenza di filiera nell’industria dell’abbigliamento e calzature” mostra come, da allora, decine di marchi della moda abbiano deciso di aderire a questa iniziativa, divulgando un numero sempre maggiore di informazioni sulle loro filiere.
La trasparenza è ormai largamente riconosciuta come un passo importante per favorire l’identificazione e la gestione degli abusi sui lavoratori nelle catene di approvvigionamento del settore tessile.
“Non è una panacea, ma è fondamentale per un’azienda che si definisce etica e sostenibile“, ha affermato Aruna Kashyap, consulente senior per i diritti delle donne di Human Rights Watch. “Tutti i marchi dovrebbero essere trasparenti: per questo sono necessarie leggi che impongano la trasparenza insieme a pratiche che garantiscano il rispetto dei diritti umani“
La coalizione ha finora contattato 74 aziende1chiedendogli di pubblicare le informazioni richieste dal Transparency Pledge: di queste 22 hanno aderito pienamente2, 31 solo in parte, 21 quasi per nulla3. Alle 22 virtuose, se ne sono aggiunte altre 17 di loro spontanea iniziativa4.
La trasparenza è importante per costringere le aziende ad assumersi le proprie responsabilità. È la garanzia che il marchio è a conoscenza di tutte le fasi di produzione dei suoi beni, consentendo ai lavoratori e agli attivisti da una parte di allertarlo in caso di violazioni, dall’altro di accedere rapidamente a tutti gli strumenti di rivalsa per gli abusi subiti.
Non possiamo però affidarci solo alla buona volontà delle imprese. Più efficaci sarebbero norme nazionali specifiche per imporre alle aziende la due diligence in tema di diritti umani lungo le loro catene di fornitura, obbligandole innanzitutto alla pubblicazione delle informazioni relative alle fabbriche in cui si riforniscono.
Dalla metà del 2018, la stessa coalizione è impegnata con sette Iniziative per il business responsabile (Responsible Business Initiatives – RBIs), per cercare di indirizzare le loro pratiche di business verso modelli etici e promuovere la trasparenza delle filiere tra i loro membri. Ma non essendoci obbligatorietà nella pubblicazione delle fabbriche fornitrici, i comportamenti degli aderenti a questi gruppi variano molto: per questo la coalizione ha chiesto a queste Iniziative di giocare un ruolo determinante, imponendo a chi volesse diventare loro membro, come condizione vincolante per l’adesione, almeno la pubblicazione delle informazioni richieste dall’Impegno per la trasparenza.
“Non è più accettabile che iniziative volte a promuovere un business responsabile e pratiche aziendali più etiche non impongano la trasparenza alle aziende quale requisito minimo di affiliazione” ha dichiarato Deborah Lucchetti, coordinatrice delle Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign. “L’accesso pubblico alle informazioni minime sulle catene di fornitura previste dall’Impegno per la Trasparenza è vitale per consentire ai lavoratori e agli attivisti di identificare e contrastare gli abusi nelle fabbriche”.
Così ad esempio ha fatto l’iniziativa americana Fair Labor Association. A novembre ha annunciato l’obbligo per tutti i suoi aderenti di pubblicare le informazioni sulle loro catene di fornitura in linea con lo standard del Transparency Pledge e renderle disponibili in un formato aperto e accessibile entro il 31 marzo 2020. L’organizzazione ha stimato che più di 50 marchi e distributori dovranno adeguarsi a questo obbligo e che da aprile 2020 potrebbero essere soggetti a una speciale revisione in caso di inadempienza.
Il Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textiles (AGT) non ha reso l’obbligo di trasparenza un requisito di adesione ma ha chiesto ai suoi membri di fornire le informazioni al suo segretariato che a sua volta le pubblicherà attraverso l’Open Apparel Registry, un database facilmente accessibile che fornisce informazioni sull’affiliazione delle fabbriche ai marchi e alle Iniziative per il business responsabile.
La United Kingdom Ethical Trading Initiative e la Fair Wear Foundation hanno adottato misure incrementali per migliorare la trasparenza dei loro membri. La Sustainable Apparel Coalition, amfori, e la German Partnership on Sustainable Textiles non hanno invece fatto nulla per legare la trasparenza ai requisiti di affiliazione.
“I governi possono giocare un ruolo fondamentale emanando la legislazione necessaria ad imporre alle aziende la due diligence in materia di diritti umani lungo le loro catene globali di fornitura e la trasparenza su dove vengono realizzati i loro prodotti“, ha affermato Bob Jeffcott, analista politico presso il Maquila Solidarity Network. “Tali norme sono fondamentali per creare condizioni di parità tra le imprese e per proteggere i diritti dei lavoratori“.
——-
1 Per maggiori informazioni sulle 74 aziende contattate dalla coalizione e le altre aziende che hanno aderito al Pledge o si sono impegnata a farlo: https://airtable.com/shrycG3Ylj9wFY2lH/tbljLFp4O3qk0dmVN/viwqDL8ndd3XgcpyK?blocks=bipTM9f7Xn4HdfnXs
2 adidas, ASICS, ASOS, Benetton, C&A, Clarks, Cotton On, Esprit, G-Star RAW, H&M, Hanesbrands, Levi Strauss, Lindex, Mountain Equipment Co-op, New Balance, New Look, Next, Nike, Patagonia, Pentland Brands, PVH Corporation, and VF Corporation.
31 imprese si sono impegnate a pubblicare almeno la lista e l’indirizzo dei loro fornitori ma sono ancora lontane dallo standard previsto dall’Iniziativa per la Trasparenza. Si tratta di: ALDI North, ALDI South, Amazon, Arcadia Group, Bestseller, Coles, Columbia, Debenhams, Disney, Fast Retailing, Gap, Hudson’s Bay Company, Hugo Boss, John Lewis, Kmart Australia, Lidl, Marks and Spencer, Matalan, Mizuno, Morrisons, Primark, Puma, Rip Curl, Sainsbury, Shop Direct, Target Australia, Target USA, Tchibo, Tesco, Under Armour, Woolworths, e Zalando.
3 Di queste:
- 18 aziende non hanno ancora pubblicato alcuna informazione
American Eagle Outfitters, Armani, Canadian Tire, Carrefour, Carter’s, Decathlon, Dicks’ Sporting Goods, Foot Locker, Forever 21, Inditex, KiK, Mango, Ralph Lauren, River Island, Sports Direct, The Children’s Place, Urban Outfitters, e Walmart. - 2 aziende hanno pubblicato solo i nomi delle aziende e i Paesi in cui operano:
Abercrombie & Fitch e Loblaws - 1 azienda si è impegnata a pubblicare i nomi e i Paesi nel 2020:Desigual
4Alchemist, Dare to Be, Eileen Fisher, Fanatics, Fruit of the Loom, HEMA, KappAhl, Kings of Indigo, Kontoor Brands, Kuyichi, Lacoste, Lululemon Athletica, Okimono, Schijvens, Toms, We Fashion e Zeeman. Gildan ha cominciato a pubblicare dei dati ma è ancora lontana dallo standard previsto dall’Iniziativa per la Trasparenza
Incendio in una fabbrica in India: oltre 40 persone morte. Giustizia per le vittime
 Domenica scorsa, oltre 40 persone sono morte in un incendio in una fabbrica tessile a Delhi, in India. Ancora una volta ci troviamo a dover denunciare l’esigenza di norme trasparenti ed efficaci per la sicurezza degli edifici e le pratiche antincendio. Il governo ha annunciato alcune misure di risarcimento, ma bisogna subito lavorare per garantire pieno accesso alla giustizia per le vittime e i loro familiari.
Domenica scorsa, oltre 40 persone sono morte in un incendio in una fabbrica tessile a Delhi, in India. Ancora una volta ci troviamo a dover denunciare l’esigenza di norme trasparenti ed efficaci per la sicurezza degli edifici e le pratiche antincendio. Il governo ha annunciato alcune misure di risarcimento, ma bisogna subito lavorare per garantire pieno accesso alla giustizia per le vittime e i loro familiari.
Secondo i media locali, l'incendio è divampato domenica mattina presto in una fabbrica situata in un’area residenziale di Delhi, all’interno di un edificio che ospita anche altre produzioni, non solo tessili. Molti degli operai, in gran parte migranti e alcuni di loro minorenni, stavano dormendo all’interno dello stabile. Il nostro pensiero va innanzitutto alle famiglie che hanno perso i loro cari e a tutte le persone colpite da questa orribile tragedia.
Palesi violazioni della sicurezza hanno impedito alle persone di fuggire e mettersi in salvo. Secondo quanto riferito, una delle due scale dell'edificio era bloccata dai prodotti accatastati, le finestre erano sbarrate e l'unica uscita accessibile era bloccata. Funzionari hanno riferito che lo stabilimento non disponeva di alcuna licenza di sicurezza e molte fonti sostengono che operasse nella completa illegalità. Per di più, le strette vie in cui si trova l’edificio hanno ulteriormente ostacolato le operazioni di salvataggio.
Disastri come questo mostrano l'urgente necessità di applicare norme antincendio e di sicurezza degli edifici in maniera trasparente e credibile. I sistemi di ispezione esistenti, compreso l’utilizzo di società di certificazione sociale, pagate dalle multinazionali per controllare le fabbriche di loro fornitori, finora non sono riusciti a migliorare strutturalmente la sicurezza degli stabilimenti.
Il governo di Delhi ha annunciato lo stanziamento di 10.000,00 INR (circa 12.700 EUR) a titolo di risarcimento per i defunti e 100.000 INR (circa 1.270 EUR) per le spese mediche per i lavoratori feriti. Inoltre si è impegnato a pagare 200.000 INR (circa 2.500 EUR) alle famiglie dei defunti e 50.000 INR (circa 635 EUR) a quelle dei feriti. Un’iniziativa lodevole ma non sufficiente. Le misure di indennizzo, almeno per la perdita di reddito e le spese mediche, dovrebbero coprire le esigenze a lungo termine delle famiglie, come stabilito nella Convenzione ILO 121 per i risarcimenti in caso di infortuni sul lavoro. Inoltre, gli accordi dovrebbero tenere conto del dolore e della sofferenza subita dai lavoratori e dai loro familiari.
Non è ancora chiaro se la fabbrica stesse producendo per l'esportazione o per il crescente mercato interno. In ogni caso, chiunque abbia effettuato degli ordini in quella fabbrica dovrebbe assumersi la responsabilità di risarcire le vittime che stavano realizzando i loro prodotti.
Ci chiediamo inoltre perché quelle persone stessero dormendo nella fabbrica, per di più durante il fine settimana e con la produzione ferma. Non potevano permettersi i costi di un alloggio o del trasporto? È chiaro che si apre anche una questione relativa ai salari dignitosi dei lavoratori, in particolare di quelli più vulnerabili come i migranti.
Sono necessari ulteriori passi per garantire giustizia ai lavoratori e qualcosa sembra essersi già messo in moto. Il governo di Delhi ha ordinato un'inchiesta giudiziaria e sono state presentate accuse contro il proprietario dell'edificio. Questa tragedia dovrebbe essere un’occasione per porre fine all'impunità di chi gioca con la vita dei lavoratori, gestendo luoghi di lavoro illegali e insicuri.
Amazon fa un passo verso la trasparenza. Ma potrebbe fare di più.
Il 15 novembre Amazon ha compiuto un primo passo verso la trasparenza pubblicando i nomi, gli indirizzi e altri dettagli di oltre 1000 “strutture che producono beni a marchio Amazon”. Ma se l’azienda ha davvero a cuore la trasparenza, allora deve fare di più.
Secondo gli standard previsti dal “Transparency Pledge”, un’iniziativa realizzata da una coalizione internazionale*, tra cui figura anche la Campagna Abiti Puliti, che fissa le informazioni minime necessarie a rendere un’azienda trasparente nei confronti dei suoi lavoratori e consumatori, l’elenco pubblicato dal colosso dell’e-commerce non è abbastanza specifico per sapere cosa o dove i prodotti vengono realizzati e non è in un formato facilmente accessibile o filtrabile.
“Una multinazionale così grande non può sottrarsi al dovere di essere quanto più trasparente possibile. Non è una questione di dettagli: i requisiti del Transaperncy Pledge sono il minimo indispensabile per mettere nelle condizioni lavoratori e attivisti di poter allertare i marchi in caso di violazioni lungo la catena di fornitura. Pur apprezzando questo primo passo, ancora molta strada resta da percorrere.” dichiara Deborah Lucchetti portavoce della Campagna Abiti Puliti
Il settore dell’e-commerce è in rapida espansione in tutto il mondo. Anche in Italia il fatturato è in crescita costante. Le risorse da investire nella tutela dei lavoratori e delle lavoratrici della propria catena di produzione non mancano di certo.
“Ci auguriamo che anche Amazon decida di seguire il percorso già tracciato da oltre 70 aziende contattate dalla coalizione, allineando le sue pratiche di trasparenza con lo standard minimo del Transparency Pledge” ha concluso Lucchetti.
*La coalizione sul Transparency Pledge è stata costituita nel 2016 con l'obiettivo di rendere la trasparenza della catena di fornitura una norma nell'industria dell'abbigliamento e delle calzature. È composta da nove membri: sei organizzazioni non governative internazionali - Clean Clothes Campaign, Human Rights Watch, International Corporate Accountability Roundtable, International Labor Rights Forum, Maquila Solidarity Network, and Worker Rights Consortium – e tre sindacati globali - IndustriALL, International Trade Union Confederation e UNI Global Union.
Quanto costa produrre un maglione di Zara? Come Inditex usurpa la parola Rispetto

Un’indagine esclusiva di Public Eye mostra l’ipocrisia che si nasconde dietro la produzione tessile del marchio Zara, di proprietà del colosso Inditex. L’organizzazione ha ripercorso a ritroso la produzione di un maglione della collezione “Join Life” di Zara, la linea modello per la sostenibilità dell’azienda, mettendo in luce la realtà che vivono i lavoratori e le lavoratrici lungo la catena di fornitura.
Inditex si presenta al pubblico come un’azienda trasparente che attribuisce la massima importanza alle persone che realizzano i suoi capi. Lo slogan della sua campagna di comunicazione, “R-E-S-P-E-C-T: find out what it means to me” (RISPETTO: scopri cosa significa per me), in riferimento alla canzone di Aretha Franklin, sottintende la cura che l’azienda avrebbe verso le lavoratrici e i lavoratori della sua filiera.
I risultati dell’inchiesta restituiscono un’altra impressione: operai soffocati dall’enorme compressione dei prezzi esercitata da Inditex sui suoi fornitoricon conseguenti salari di povertà, orari di lavoro eccessivi, contratti precari, a fronte di profitti milionari per il brand. Secondo la stima di Public Eye, realizzata in collaborazione con alcuni partner della Clean Clothes Campaign e BASIC, l’azienda guadagna per ogni maglione venduto il doppio di tutte le persone impegnate nella sua produzione.
Risalendo la catena di produzione di questo articolo, l’inchiesta è arrivata agli stabilimenti di Smirne, in Turchia. La fabbrica incaricata della realizzazione dei 20mila maglioni, venduti in Svizzera al prezzo di 39,67 euro cadauno, ha ricevuto soltanto 1,53 euro al pezzo e la tipografia che ha apposto lo slogan solo nove centesimi a stampa. Per garantire la produzione è evidente che i proprietari siano stati costretti a sotto pagare i dipendenti o a farli lavorare più del consentito.
I lavoratori avrebbero guadagnato tra i 310 e i 390 euro al mese, circa un terzo del salario stimato dalla Clean Clothes Campaign come dignitoso. Nonostante il codice di condotta di Inditex affermi testualmente che i suoi fornitori dovrebbero sempre pagare salari “sufficienti a coprire almeno le esigenze di base dei lavoratori e delle loro famiglie, nonché ogni altra ragionevole necessità“. Inoltre, in uno degli stabilimenti la produzione sarebbe continuativa per 24 ore al giorno, divisa in due soli turni da 12 ore: pratica contraria al codice di condotta e alla legge turca, che impone turni massimi di lavoro notturno di sette ore e mezza. Peraltro, in una delle fabbriche buona parte dei lavoratori sarebbero assunti con contratti giornalieri, senza alcuna garanzia di impiego il giorno successivo.
“La ricerca condotta sulla popolare felpa di Zara conferma ciò che affermiamo da tempo. Le pratiche d’acquisto capestro esercitate dai marchi committenti sono la prima causa strutturale della compressione dei costi verso i fornitori e del conseguente impoverimento cronico di milioni di lavoratori nel mondo.” dichiara Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti. “È sempre più urgente e necessario affrontare il tema della redistribuzione della ricchezza nelle catene produttive globali della moda a favore dei lavoratori, spesso donne, che ne sono le principali artefici. Per questo sono necessari accordi vincolanti che obblighino i marchi committenti a pagare prezzi adeguati a garantire il riconoscimento di salari dignitosi a tutti i lavoratori della filiera“
Inditex non pubblica nessun dato concreto sui livelli salariali dei suoi fornitori e sui prezzi di acquisto dei suoi articoli: Public Eye, allora, in collaborazione con il collettivo Éthique sur l’étiquette, la Schone Kleren Campagne e l’ufficio di analisi francese BASIC ha fatto una stima dettagliata della composizione del prezzo di questo maglione. Secondo i calcoli l’azienda guadagna 4,20 euro al pezzo, circa il doppio rispetto a tutte le persone impegnate nella sua produzione (2,08 euro), dai campi di cotone in India alla filanda di Kayseri, nella Turchia centrale, fino alle fabbriche di Smirne. Una scelta precisa quindi, non una fatalità: basterebbe destinare 3,62 euro in più a maglione alla mano d’opera per garantire un salario dignitoso a tutti i lavoratori.
Inditex, che ha registrato un utile netto record di 3,44 miliardi di euro nel 2018, deve rispettare i diritti di coloro che contribuiscono al suo successo, cominciando a pagare dei prezzi di acquisto sufficienti a garantire loro un salario dignitoso.
Lettera alle istituzioni in materia di Impresa e Diritti Umani
Lettera inviata alle principali istituzioni italiane in materia di Impresa e Diritti Umani su iniziativa dei Direttori Scientifici della "Business and Human Rights" Summer School. La Campagna Abiti Puliti ha sottoscritto la lettera, firmata da più di 50 accademici ed esperti italiani e stranieri. La lettera è disponibile anche in inglese.
EVENTO: Human Rights Due Diligence
HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE
PRINCIPI E PRATICHE EMERGENTI IN EUROPA:
QUALE RUOLO PER L’ITALIA?
13 novembre 2019 dalle 10.00 alle 18.00
Sala Vitman dell’Acquario Civico di Milano, viale Gadio 2
Per poter identificare, prevenire e mitigare i propri impatti negativi su ambiente e società, le imprese, multinazionali in primis, sono sempre più chiamate a fare uso di due diligence con riguardo ai diritti umani (HRDD).
Si tratta di un processo che consiste nel valutare gli impatti effettivi e potenziali delle attività produttive su tali diritti, nel dotarsi di politiche aziendali che tengano conto di tali valutazioni, nel monitoraggio delle misure adottate e nel dotarsi di meccanismi di rimedio a favore delle persone e delle comunità che effettivamente subiscono abusi. Nonostante il concetto sembra essere ormai di uso corrente tra gli addetti ai lavori, gli esempi di legislazione oggi in vigore in Europa presentano caratteristiche disomogenee e lacune.
Nel corso del seminario internazionale ragioneremo insieme su quali siano gli elementi fondamentali che dovrebbero essere presenti in una legge nazionale, una direttiva o un regolamento comunitario sulla HRDD; condivideremo le lezioni apprese dai Paesi UE che stanno sperimentando le prime legislazioni sul tema; faremo un approfondimento sul panorama italiano e sulle potenzialità della legge 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
L’evento è promosso da Mani Tese, FIDH, HRIC, Fair e Campagna Abiti Puliti e si inserisce all’interno del progetto “New Business for Good. Educare, informare e collaborare per un nuovo modo di fare impresa”, co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
La partecipazione al seminario è gratuita. Per registrarsi: https://forms.gle/UCuGeUUdiDEp7XVP6


Caso UNIQLO: presentata denuncia alla Fair Labor Association
I lavoratori indonesiani chiedono di intervenire per risolvere definitivamente la disputa sui salari con Uniqlo
Dopo che per anni Uniqlo si è rifiutata di prendere parte seriamente a qualsiasi processo di mediazione, la Clean Clothes Campaign, insieme ai lavoratori indonesiani della fabbrica Jaba Garmindo, ha presentato una denuncia alla Fair Labor Association (FLA).L’atto, indirizzato a Fast Retailing, società madre del marchio Uniqlo, e al marchio tedesco s. Oliver, contesta la violazione del “Codice di Condotta” della FLA e i suoi “Principi del lavoro equo e della fornitura responsabile”, concepito per garantire “un trattamento rispettoso ed etico dei lavoratori” e per “promuovere condizioni sostenibili” nell’industria tessile.
Nell’aprile 2015, due stabilimenti indonesiani a Cikupa e Majalengka chiudono i battenti dalla sera alla mattina senza pagare ai loro operai, per lo più donne, le indennità di licenziamento obbligatorie per legge e diversi mesi di salario. Le chiusure sono avvenute dopo la bancarotta causata dal ritiro delle commesse da parte dei principali acquirenti, in particolare Uniqlo. Le migliaia di lavoratrici e lavoratori della Jaba Garmindo non sapevano nemmeno ci fossero dei problemi. Hanno scoperto della bancarotta e della chiusura soltanto attraverso le inchieste della stampa.
I documenti ottenuti dai lavoratori dimostrano come Uniqlo e s. Oliver fossero gli acquirenti più significativi negli anni precedenti alla chiusura: oltre il 50% del volume di produzione della fabbrica nel 2014 era su loro commissione. I lavoratori hanno visto con i loro occhi l’influenza che Uniqlo ha esercitato sulla produzione della fabbrica e di conseguenza sulle condizioni di lavoro: l’arrivo del marchio ha portato con sé obiettivi esorbitanti, straordinari forzati e pressione sui lavoratori. Gli atti giudiziari della procedura fallimentare citano le pratiche commerciali degli acquirenti come un fattore significativo per la chiusura degli stabilimenti.
Nurhayat, Vice Presidente del sindacato FSPMI presente presso la PT Jaba Garmindo, ha dichiarato: “È profondamente ingiusto che i lavoratori e le lavoratrici che hanno realizzato gli abiti di Uniqlo debbano soffrire una tale ingiustizia, mentre il marchio continua a crescere e prosperare, generando miliardi di profitti. Abbiamo il diritto ad avere quanto ci è dovuto, dopo anni di duro lavoro per realizzare i capi Uniqlo. Il rifiuto di pagarci è paragonabile a un furto e questo dovrebbe essere motivo sufficiente perché la FLA prenda provvedimenti immediati”.
Come marchi affiliati alla FLA, Uniqlo e s. Oliver sono tenute ad aderire al “Codice di Condotta” che stabilisce chiaramente che essi debbano garantire che i loro fornitori salvaguardino i diritti dei lavoratori ai sensi delle leggi nazionali e internazionali sul lavoro e sulla sicurezza sociale. Ciò include il fatto che i lavoratori ricevano tutti gli indennizzi previsti dalle normative. Dalla chiusura dello stabilimento, 2.000 lavoratori e lavoratrici della Jaba Garmindo hanno chiesto a Uniqlo e s. Oliver di assumersi le proprie responsabilità e di pagare i 5,5 milioni di dollari dovuti a titolo di indennità di licenziamento. Poiché i procedimenti legali sono chiusi, i lavoratori ora si rivolgono alla FLA come uno degli ultimi meccanismi di accesso ai risarcimenti.
Molte donne hanno lavorato in quegli stabilimenti per moltissimi anni e, in un mercato che preferisce assumere giovani, per loro sarà molto difficile trovare altre occupazioni. Quasi 600 lavoratrici vivono in condizioni di indigenza, costrette ad accettare lavori con paghe ben al di sotto del salario minimo.
Deborah Lucchetti, coordinatrice della Campagna Abiti Puliti, ha dichiarato: “Uniqlo continua a sostenere di non aver alcun obbligo legale di pagare ciò che spetta ai lavoratori della Jaba Garmindo. Questo è esattamente il problema, cioè l’assenza di norme legalmente vincolanti nell’industria dell’abbigliamento. I codici di condotta cui molti marchi fanno riferimento sono volontari lasciando la responsabilità di rispettare di diritti fondamentali sanciti da norme e standard internazionali in balia della buona volontà degli stessi marchi che concorrono a violarli. Ora ci aspettiamo che FLA intervenga, in coerenza con quanto previsto dal suo codice di condotta e si adoperi concretamente per garantire un pieno risarcimento per i lavoratori della Jaba Garmindo“.
Molte delle aziende concorrenti di Uniqlo, alcuni anche membri della FLA, hanno accettato di contribuire al pagamento delle indennità di licenziamento in caso di fallimento di un loro fornitore. Ad esempio Nike, Adidas, Disney, Fruit of the Loom, Hanesbrands, H&M e Walmart hanno pagato direttamente i fondi dovuti ai lavoratori o hanno sollecitato i loro partner della catena di fornitura a farlo.
Negli ultimi anni, la campagna #PayUpUniqlo ha ricevuto un significativo sostegno pubblico globale portando all’avvio di un processo di mediazione tra Uniqlo e i lavoratori della Jaba Garmindo con incontri nel luglio 2017 e novembre 2018. Tuttavia, Uniqlo ha poi rifiutato di impegnarsi in maniera significativa e di partecipare ad ulteriori incontri, nonostante gli appelli della FLA alla Fast Retailing per “cercare una soluzione adeguata per i lavoratori e le lavoratrici della fabbrica”.
Risulta oltremodo stridente osservare che mentre Uniqlo ignora le richieste di migliaia di lavoratrici che l’hanno reso uno dei brand più redditizi al mondo, il marchio acquisisce credibilità attraverso le recenti partnership con l’OIL e UN Women
- La denuncia dei lavoratori della Jaba Garmindo alla FLA arriva poche settimane dopo che Uniqlo ha annunciato la sua partnership con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel più grande progetto mai finanziato dal settore privato, per un valore di 1,8 milioni di dollari, volto a promuovere la protezione sociale, lo sviluppo delle competenze e il sostegno all’occupazione in Indonesia. Inoltre a giugno di quest’anno, Fast Retailing ha annunciato la sua partnership globale con UN Women per “difendere i diritti delle donne e il loro rafforzamento nel settore dell’abbigliamento”. Otto su dieci degli ex lavoratori della Jaba Garmindo sono donne e almeno 600 di loro versano in gravi difficoltà finanziarie.
- Nel 2016, la Fair Wear Foundation ha risposto al reclamo di un lavoratore predisponendo un accordo con il marchio, suo socio e acquirente della Jaba Garmindo, Jack Wolfskin affinché pagasse un importo molto limitato a titolo di indennizzo ai lavoratori. Il sindacato di fabbrica FMPSI ha ritenuto che questa cifra fosse una “miseria”. Sentendosi scoraggiati e delusi dal processo di reclamo della FWF, i lavoratori della Jaba Garmindo hanno cercato il sostegno della Clean Clothes Campaign.
- La Clean Clothes Campaign, composta da oltre 200 organizzazioni in tutto il mondo, ha lanciato la campagna #PayUpUniqlo nel 2016, prendendo di mira l’apertura di nuovi negozi Uniqlo in tutta Europa e i lavoratori che visitano la sede centrale di Uniqlo a Tokyo. Questo mese, gli attivisti si concentreranno sull’apertura di negozi a Madrid e Barcellona.
- Uniqlo ha precedenti in materia di violazioni del diritto del lavoro. Nel 2016, la Students and Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM) a Hong Kong ha condotto indagini sotto copertura in quattro fabbriche che producono per Uniqlo in Cina per mostrare le condizioni di lavoro della catena di fornitura. In Cambogia, Human Rights Now (HRN), una ONG internazionale per i diritti umani con sede a Tokyo, ha scoperto che centinaia di lavoratori sono stati ingiustamente licenziati semplicemente per aver lottato per i loro diritti. Anche S. Oliver si è macchiato di violazioni dei diritti dei lavoratori, tra cui salari da fame e cattive condizioni in Ucraina, Serbia e Ungheria.
- Dal 2010 i principali marchi globali hanno pagato oltre 10 milioni di dollari di indennità di licenziamento previste per legge a più di 6.000 ex dipendenti di fabbriche chiuse in tutto il mondo. Più recentemente, lo scorso agosto, è stato firmato un accordo che garantisce che migliaia di lavoratori in Indonesia riceveranno 4,5 milioni di dollari a titolo di indennità di licenziamento obbligatoria per legge.







Fai come noi! Scarica l’immagine, stampala, scatta un selfie e postala sui social network con l’hashtag #PayUpUNIQLO

(2019) REPORT - La foglia di fico della moda: come l’auditing sociale protegge i marchi a danno dei lavoratori
“Ci spingiamo fin dove i marchi committenti ci fanno arrivare”
Un nuovo rapporto mostra come l’industria multimiliardaria dell’auditing sociale sia utilizzata come strumento di responsabilità sociale di impresa (RSI) per proteggere la reputazione dei marchi e i loro profitti a danno della sicurezza dei lavoratori della moda.
Il rapporto “La foglia di fico della moda: come l’auditing sociale protegge i marchi a danno dei lavoratori” pubblicato oggi dalla Clean Clothes Campaign offre un’analisi approfondita dell’industria della certificazione, mostrando i collegamenti tra le più famose iniziative commerciali di conformità sociale (come Social Accountability International, WRAP, FLA, e amfori BSCI), le più grandi imprese di auditing (come Bureau Veritas, TÜV Rheinland, UL, RINA e ELEVATE) e i marchi interessati da queste certificazioni.
Le prove mostrate nel rapporto evidenziano chiaramente come l’industria dell’auditing sociale abbia platealmente fallito nel raggiungimento del suo obiettivo primario: proteggere la sicurezza dei lavoratori e migliorare le loro condizioni. Al contrario è stata molto attiva nel proteggere l’immagine e la reputazione dei marchi e dei loro modelli di business, ostacolando al tempo stesso modelli più efficaci che comprendono l'obbligo di trasparenza e impegni vincolanti in materia di accesso alla giustizia.
Il rapporto offre esempi specifici di negligenza citando alcuni casi molto noti accaduti negli scorsi anni: l’incendio della Ali Enterprises in Pakistan del settembre 2012, in cui oltre 250 lavoratori persero la vita perché impossibilitati a scappare a causa delle porte e delle finestre sbarrate; il crollo del Rana Plaza in Bangladesh nell’aprile 2013, con la morte di 1.134 lavoratori e il ferimento di migliaia di persone; l’esplosione del boiler nella fabbrica Multifabs sempre in Bangladesh nel luglio 2017, con decine di morti e feriti. Ciascuna di queste fabbriche era stata certificata come sicura da diverse aziende di auditing - tra cui TÜV Rheinland, Bureau Veritas e RINA - utilizzando gli standard, la metodologia e la guida di importanti iniziative di conformità come la amfori BSCI e la SAI. Nei casi della Ali Enterprises e del Rana Plaza inoltre, le certificazioni erano avvenute solo poche settimane o mesi prima dei disastri: per la Ali, secondo quanto riferito, addirittura senza che gli auditor avessero visitato la fabbrica.
Questi casi, prevedibili ed evitabili, dimostrano il fallimento del sistema di auditing sociale controllato dalle aziende. Si tratta di un’industria che, per usare le parole di un’auditor, si spinge “fin dove i marchi committenti ci fanno arrivare”*. Un’industria che opera impunemente: ci sono state poche, se non nessuna, ripercussioni negative per le aziende e le iniziative di certificazione coinvolte in quei disastri. Queste continuano a crescere così come crescono i loro profitti e ricavi, man mano che aumentano le fabbriche controllate. Un settore che è riuscito a mantenere nascosti i suoi fallimenti grazie alla notoria assenza di trasparenza e all’opacità della sua catena di responsabilità che gli permette di non condividere alcun risultato con il mondo esterno, compresi quei lavoratori i cui diritti, vite e salute sono in gioco. Il rapporto si concentra sulle cause strutturali di questi fallimenti, suggerendo ai diversi soggetti coinvolti numerose raccomandazioni per cambiare il sistema, a partire dall’esigenza di maggiore trasparenza, responsabilità e coinvolgimento reale dei lavoratori.
Deborah Lucchetti, coordinatrice della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign, ha dichiarato: “20 anni di responsabilità sociale d’impresa non sono riusciti a migliorare le condizioni di lavoro e si continuerà in questo modo fino a quando non ci sarà una revisione strutturale del sistema di auditing sociale. Non possiamo lasciare che le imprese si autoregolino. Normative vincolanti con la minaccia di sanzioni e il rafforzamento dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze sono gli unici meccanismi che possano garantire una seria presa in carico delle proprie responsabilità, l’esercizio della due diligence sui diritti umani e la protezione delle vite dei lavoratori”.
Kalpona Atker, del Bangladesh Centre for Worker Solidarity, particolarmente coinvolta nella battaglia per ottenere giustizia per le famiglie colpite dal crollo del Rana Plaza, ha dichiarato: “È fondamentale capire che il sistema di auditing sociale è fallimentare a partire dalla sua progettazione. I certificatori non hanno le competenze, il tempo o gli incentivi per rilevare correttamente gli edifici non sicuri e rilasciano rapporti che dicono in modo rassicurante ai marchi che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Il crollo del Rana Plaza è stato un disastro causato dalla negligenza umana e del tutto prevedibile. I marchi non hanno voluto vedere le condizioni in cui versavano le fabbriche, condizioni non rilevate o ignorate negli audit da loro stessi commissionati. È sorprendente che nessuno - non un marchio o una società di auditing - sia stato ritenuto responsabile dell'enorme perdita di vite. Abbiamo bisogno di leggi che costringano queste imprese a render conto della loro negligenza."
Garrett Brown, coordinatore del Maquiladora Health & Safety Support Network, fondato nel 1993 attraverso progetti di sicurezza sul lavoro in Messico, America Centrale, Indonesia, Cina, Vietnam e Bangladesh, ha dichiarato: “Questo rapporto esaustivo e ben documentato mostra chiaramente come e perché i programmi di responsabilità sociale di impresa (RSI) non siano riusciti a proteggere la salute, la sicurezza e i diritti legali dei lavoratori in tutta la catena globale di fornitura. Ciò che manca nell'auditing sociale sono auditor competenti e non corrotti; rapporti di ispezione accurati e integrali; coinvolgimento reale dei lavoratori, la parte più informata e più interessata al processo di monitoraggio. Il punto della questione è che lo scopo reale della Responsabilità Sociale di Impresa non è proteggere i lavoratori ma l’immagine e la reputazione dei marchi, continuando ad ottenere il massimo profitto dalle catene globali di approvvigionamento”.
*La citazione originale è “We go as far as brands want us to go” in LeBaron, G., and Lister, J. 2016. Ethical Audits and the Supply Chains of Global Corporations. SPERI Sheffield Political Economy Research Institute. Brief 1. Sheffield. http://eprints.whiterose.ac.uk/96303/.
UNIQLO: paga subito i risarcimenti!

Questa settimana Uniqlo apre il suo primo negozio a Milano. È l’occasione giusta per chiedere al marchio di assumersi le sue responsabilità!
Nel 2015 la fabbrica indonesiana Jaba Garmindo chiudeva i battenti senza alcun preavviso dopo che Uniqlo, unico acquirente, decideva di ritirare i suoi ordini. Da allora i lavoratori (per l’80% donne), improvvisamente licenziati e lasciati in condizioni disperate, aspettano almeno 5,5 milioni di dollari di indennità di licenziamento per ricominciare a vivere.
Unisciti a noi per chiedere a Uniqlo di assumersi le sue responsabilità dopo essersi rifornito presso quella fabbrica che sfruttava quei lavoratori con bassi salari, straordinari obbligatori e non pagati e altre vessazioni. Uniqlo paghi subito i risarcimenti dovuti!
Parliamo di un’azienda, il terzo distributore di moda nel mondo, che ha chiuso lo scorso anno fiscale (conclusosi il 31 agosto) con una crescita del 14,4% e un aumento del 29,8% del profitto. Concretamente, la Fast Retailing ha registrato un fatturato di 2,13 trilioni di yen (16,39 miliardi di euro) e un utile di 154 miliardi di yen (1,19 miliardi di euro). Profitti costruiti anche sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici della Jaba Garmindo.
Lascia un commento all’evento di Uniqlo e fagli sapere da che parte stai: https://www.facebook.com/events/1138341733024208/
(2019) Ali Enterprises: dopo 7 anni ancora fabbriche insicure

Nel giorno del settimo anniversario dell’incendio alla fabbrica tessile Ali Enterprises, che nel 2012 in Pakistan uccise oltre 250 lavoratori e lavoratrici, con il nuovo rapporto I lavoratori tessili del Pakistan hanno bisogno di un accordo sulla sicurezza, Clean Clothes Campaign, International Labor Rights Forum, Labour Education Foundation, National Trade Union Federation e Pakistan Institute of Labour Education and Research denunciano come ancora oggi le fabbriche tessili del Paese restino insicure come allora.
Le iniziative avviate negli ultimi anni non sono riuscite a porre i lavoratori (e i sindacati che li rappresentano) al centro dei programmi di sicurezza e quindi difficilmente potranno affrontare in modo significativo la questione. Per questo si chiede un meccanismo ispirato al programma per la sicurezza messo in atto nel 2013 dopo il drammatico crollo dell'edificio Rana Plaza in Bangladesh.
In questa giornata innanzitutto il nostro pensiero va da una parte a tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno vissuto questa tragedia traumatizzante sette anni fa e alle famiglie che in quel giorno hanno perso i propri cari; dall’altra a tutte le vittime e ai feriti colpiti da incendi e altri incidenti prevenibili accaduti negli anni a seguire.
“La totale mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio della sicurezza nell'industria dell'abbigliamento in Pakistan è costata centinaia di vite umane negli ultimi anni. Così come l’assenza delle misure che potrebbero essere messe immediatamente in atto, come assicurare che gli operai non restino mai bloccati all'interno degli edifici o rimuovere i prodotti accumulati davanti alle uscite di emergenza, e che avrebbero potuto fare la differenza, salvando centinaia di vite umane dal fuoco della Ali Enterprises e in molti altri incendi accaduti in seguito" dichiara Khalid Mahmood, direttore del Labour Education Foundation in Pakistan.
Il rapporto evidenzia come tutte le iniziative avviate dal 2012 in Pakistan volte a migliorare la sicurezza sul lavoro siano in realtà caratterizzate da scarsa trasparenza. E, cosa più importante, nessuna di esse sia stata sviluppata coinvolgendo i sindacati e le altre organizzazioni per i diritti dei lavoratori pakistane. La rappresentanza dei lavoratori è stata esclusa non solo nella fase di progettazione ma anche in quella di implementazione e nella governance.
Marchi e distributori continuano a convogliare le loro energie sugli stessi schemi di auditing aziendale che in passato non sono riusciti a migliorare significativamente il settore o a prevenire decine di morti. Gli ispettorati governativi pakistani non dispongono di personale e di risorse sufficienti e non sono in grado di coprire in modo significativo un settore in crescita. Nel frattempo, ogni giorno i lavoratori continuano a rischiare la vita in fabbriche non sicure.
“È giunto allora il momento che le aziende che producono abiti e tessuti per la casa in Pakistan inizino a prendere sul serio la sicurezza dei lavoratori. Tutte le parti interessate, a livello locale e internazionale, devono assumersi la loro responsabilità, mettendo le persone che fabbricano i loro prodotti al centro dei loro sforzi per la sicurezza” dichiara Nasir Mansoor, presidente della Pakistani National Trade Union Federation.
Il rapporto esorta i marchi e i distributori che si riforniscono in Pakistan a tenere conto delle richieste del movimento sindacale pakistano di sostenere la formazione di un accordo giuridicamente vincolante tra i brand dell’abbigliamento, i sindacati e i gruppi, locali e globali, impegnati per i diritti dei lavoratori. Tale intesa deve trarre insegnamento dall'esperienza vissuta in Bangladesh attraverso l’Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici, il che significa porre al centro del programma la trasparenza, l'applicazione, gli obblighi commerciali e la partecipazione dei lavoratori. È fondamentale per la sicurezza dei lavoratori che i sindacati locali e le altre organizzazioni locali per i diritti dei lavoratori siano coinvolti nell'ideazione, progettazione, governance e attuazione di qualsiasi iniziativa volta a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro nel Paese.
“Abbiamo visto in Bangladesh, dove sono emerse contemporaneamente due iniziative in materia di sicurezza, che il coinvolgimento dei lavoratori, la trasparenza e la natura vincolante sono essenziali per creare un programma di sicurezza di successo. Mentre l'Alleanza per la sicurezza dei lavoratori del Bangladesh, controllata dalle imprese, non ha mai coinvolto gruppi indipendenti di rappresentanza dei lavoratori nella sua progettazione, sviluppo o governance e ha rifiutato di richiedere impegni giuridicamente vincolanti da parte delle imprese, l'Accordo ha stabilito un nuovo standard rivoluzionario per un sistema di ispezione e bonifica trasparente, replicabile ed efficace. Qualsiasi programma di sicurezza in Pakistan deve partire da qui” dichiara Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti.
Il rapporto chiede che i governi nazionali e provinciali pakistani adottino una serie di misure per allineare la situazione in quelle fabbriche che non fossero incluse nell’accordo.
“È importante che i governi nazionali e provinciali aumentino le risorse, la copertura e l'efficacia, al fine di garantire che tutte le fabbriche di abbigliamento e le strutture tessili in Pakistan diventino più sicure, non solo quelle che producono per il mercato internazionale” dichiara Zulfiqar Shah, co-direttore del Pakistan Institute of Labour Education and Research.
Infine, il rapporto chiede ai governi dei Paesi che ospitano le sedi dei principali brand di abbigliamento e dei distributori di porre fine alle pratiche di autocontrollo inaffidabili, introducendo una legislazione obbligatoria di due diligence in materia di diritti umani garantendo così che i marchi si assumano le loro responsabilità lungo tutta la catena di fornitura. Inoltre anche le società di social auditing devono essere ritenute responsabili di audit erronei che potrebbero costare la vita ai lavoratori.
Leggi il report completo (inglese)
Donne nell’industria dell’abbigliamento e delle calzature in Albania

Pubblichiamo la traduzione di un articolo di Factoje dello scorso maggio sulla situazione dei lavoratori e delle lavoratrici tessili in Albania (traduzione a cura di Ersilia Monti)
Il 6 ottobre 2018 il primo ministro albanese Edi Rama ha visitato una delle più grandi fabbriche di abbigliamento di Durazzo. Nel corso della visita ha affermato che grazie agli incentivi economici del governo le imprese del settore hanno visto crescere negli ultimi anni la loro capacità produttiva e hanno così potuto garantire maggiore occupazione e consistenti aumenti salariali. A sostegno della sua tesi Rama ha pubblicato anche un video sulla sua pagina facebook, ma ha raccolto non pochi commenti da parte di cittadini che descrivono una realtà ben diversa fatta di retribuzioni che, non solo non sono aumentate, ma restano ancora troppo basse.
Ecco alcuni dei commenti:
“Dove li vedete questi aumenti salariali? Lavoro in fabbrica alla macchina da cucire, il massimo che ricevo sono 250 mila ALL (200 euro) e vivo in un clima di paura, come le mie colleghe”.
“Ho lavorato l’anno scorso in quella fabbrica e non portavo a casa più di 250 mila ALL al mese per 10 ore di lavoro al giorno. Per favore dite le cose come stanno e non come il primo ministro vorrebbe che fossero”.
“Signor primo ministro, guardi che lì si prendono solo 180 mila ALL. Non sono cose di cui vantarsi!”
“Perché non dice che gli straordinari non sono retribuiti e che i lavoratori non ricevono nemmeno il salario minimo?”
Per gli intervenuti sulla pagina facebook di Edi Rama le condizioni di lavoro nei luoghi descritti non sono per niente favorevoli. Si dice, per esempio, che solo i supervisori sono pagati in modo adeguato, che le donne sono autorizzate ad andare in bagno una sola volta, anche in condizioni di assoluta necessità, durante turni di lavoro di 9 ore, e che dopo sette anni di lavoro ci si ammala d’asma o di altre patologie respiratorie. Si afferma infine che quasi nessuna fabbrica ha adottato misure di sicurezza.
Le dichiarazioni del primo ministro e le reazioni, così numerose, apparse sui social network hanno indotto Faktoje a svolgere un’indagine per approfondire la questione e accertare i fatti. In questo contesto, sono state realizzate una serie di interviste a donne, occupate nell’industria dell’abbigliamento in città diverse, le quali si sono rese disponibili a rendere pubblici i propri problemi di lavoro. Solo due testimoni hanno chiesto di mantenere l’anonimato per paura di essere licenziate. Tefta Buci, ex dipendente di un’azienda di Tirana, ha accettato di essere intervistata di fronte alla telecamera nella convinzione che il suo esempio sarà di stimolo alle donne incoraggiandole a discutere apertamente delle loro condizioni di lavoro. Buci è stata licenziata per aver organizzato una serie di scioperi considerati illegali e per aver tentato di fondare un sindacato in fabbrica. Per vedere riconosciuta l’illegittimità del suo licenziamento, ha portato il suo caso in tribunale. I giornalisti di Faktoje hanno assistito alle udienze.
Tefta Buci è stata per dieci anni dipendente di AlbaGroup, un’azienda italiana, amministrata da un albanese, che è proprietario di una piccola quota azionaria. L’azienda è specializzata nella cucitura e incollaggio di calzature, e nella modellistica. Fra le marche più note per le quali AlbaGroup lavorava, Buci ha menzionato Valentino, Jimmy Choo, Disquared, Louboutin, Fendi, Versace, Aurelien, Hermes, and Philipp Plein.
Abbiamo tentato di metterci in contatto con la sede dell’azienda in Italia per avere maggiori informazioni sulle condizioni di lavoro, sui contratti applicati, o anche solo per sapere se era noto il caso di un ricorso legale da parte di una ex dipendente, ma finora non abbiamo ricevuto risposte.
In Albania non vengono utilizzati termini univoci, a livello istituzionale, per identificare il settore industriale di cui stiamo parlando. Qualche volta lo si classifica come “façon”, altre volte come “industria per la trasformazione di materiale tessile”. La poca precisione rende difficile la raccolta di dati ufficiali sia riguardo al numero di imprese che operano nel settore sia riguardo al numero degli occupati. Abbiamo inoltrato numerose richieste per ottenere informazioni ufficiali, ma sono state tutte respinte con la motivazione che non era stata utilizzata la terminologia corretta. Restano così di difficile individuazione le aziende che non rispettano la legge e obbligano i dipendenti a lavorare in nero.
Il caso di Tefta Buci è la dimostrazione del cattivo funzionamento del sistema preposto alla tutela dei lavoratori, con il risultato che questi ultimi sono costretti ad affrontare la battaglia per il riconoscimento dei loro diritti in totale solitudine. A detta di Tefta, l’ispettorato del lavoro ha svolto più di un sopralluogo su richiesta dei lavoratori che denunciavano irregolarità nelle condizioni di lavoro, nei livelli retributivi e nei ritmi di produzione. Tutto quello che è stato rilevato nel verbale di ispezione però è la mancanza di un servizio di mensa e l’abitudine dei dipendenti a fumare nei locali di lavoro, desunta dalla presenza di cartelli di avviso.
Non c’era niente di normale invece, secondo Tefta, nelle condizioni in cui lei e le colleghe erano costrette a lavorare: “le pressioni erano continue, ed esercitate nei modi più disparati, le donne subivano violenze fisiche e psicologiche, il caposquadra e i superiori non facevano che insultarci ben sapendo che non potevamo reagire, pena il licenziamento”.
Dal racconto di Tefta risulta che in fabbrica si sono verificati numerosi incidenti per i quali le vittime non solo non sono state risarcite, ma non hanno ricevuto nessun tipo di cura. Il medico responsabile sembra esistere solo sulla carta dal momento che non era mai presente ogni volta che si è verificato un problema di salute o un caso di infortunio. Secondo un’altra testimone, R.B., 35 anni, che ha chiesto di mantenere l’anonimato, i datori di lavoro e i superiori minimizzano i problemi pensando di risolverli con l’installazione di un climatizzatore, cosa che per altro hanno fatto solo dopo una serie di incidenti sul lavoro dei quali si sono occupati anche i mezzi di informazione.
“Facciamo straordinari senza ricevere la maggiorazione del 10% alla quale abbiamo diritto e non ci riconoscono le assenze per malattia”, dice R.B., che aggiunge che le lavoratrici non si lamentano apertamente perché temono di perdere l’unico reddito con il quale mantengono la famiglia.
Rimangono così nell’ombra anche le molestie sessuali. Un’altra testimone, L.K., 45 anni, dipendente di una fabbrica di Valona, ha raccontato a Faktoje di essere a conoscenza di casi in cui sono state effettuate delle nuove assunzioni di donne, selezionate espressamente per ottenere sotto ricatto occupazionale favori di tipo sessuale. Una di queste donne, a detta di L.K., è una ventenne divorziata, giudicata una facile preda per via del suo stato civile e dei problemi che ha dovuto affrontare nella vita.
La mancanza di attenzione che viene riservata ai gravi problemi che vivono le donne occupate nell’industria dell’abbigliamento in Albania è un’offesa al nostro paese, perché queste donne sono fra le categorie sociali più deboli e ignorate dallo stato. Ci si deve occupare di loro in modo costante e non soltanto l’8 marzo. Il governo ha il dovere di intervenire per risolvere una situazione scandalosa, anche se le aziende del settore sono quasi tutte di proprietà privata.
(2019) REPORT - Salari su misura
Un nuovo rapporto dimostra come i principali marchi dell’abbigliamento non siano riusciti a mantenere l’impegno del salario vivibile
- Nessun grande marchio di abbigliamento intervistato è stato in grado di dimostrare, al di fuori della propria sede centrale, che i lavoratori della sua catena di fornitura siano effettivamente pagati abbastanza per vivere con dignità e sostenere una famiglia.
- I marchi di abbigliamento e i distributori stanno violando le norme sui diritti umani riconosciute a livello internazionale e i propri codici di condotta.
Secondo un nuovo rapporto pubblicato oggi dalla Clean Clothes Campaign, nessun grande marchio di abbigliamento è in grado di dimostrare che i lavoratori che producono i loro capi in Asia, Africa, America Centrale o Europa Orientale siano pagati abbastanza per sfuggire alla trappola della povertà.
Lo studio "Salari su misura 2019: Lo stato delle retribuzioni nell’industria globale dell’abbigliamento" analizza le risposte di 20 grandi marchi della moda sui loro progressi nell'implementazione di un salario vivibile per i lavoratori che producono i loro vestiti. Dalla ricerca è emerso che l'85% dei marchi si è impegnato in qualche modo a garantire che i salari siano sufficienti a soddisfare le esigenze di base dei lavoratori, ma, al contempo, che nessuno di loro ha messo in pratica questo principio per nessun lavoratore nei Paesi in cui viene prodotta la stragrande maggioranza dei capi di abbigliamento.
Anna Bryher, autrice del rapporto, ha dichiarato: “A cinque anni di distanza dalla nostra precedente indagine, nessun marchio è stato in grado di mostrare alcun progresso verso il pagamento di un salario vivibile. La povertà nell'industria dell'abbigliamento sta peggiorando. È una questione urgente. Il nostro messaggio ai brand è chiaro: i diritti umani non possono aspettare e i lavoratori che realizzano i capi venduti nei nostri negozi devono essere pagati abbastanza per vivere con dignità”.
Dei 20 marchi intervistati, 19 hanno ricevuto il voto più basso possibile, mostrando di non essere in grado di produrre alcuna prova che a un lavoratore che confeziona i loro capi di abbigliamento sia stato pagato un salario vivibile in qualsiasi parte del mondo. L'unica eccezione è stata Gucci che è riuscita a dimostrare come, per una piccola parte della sua produzione in Italia, grazie alle trattative salariali nazionali, le paghe consentano a una famiglia di vivere in alcune zone del Sud e del Centro Italia.
"Le iniziative volontarie non sono riuscite a garantire i diritti umani dei lavoratori", ha aggiunto Deborah Lucchetti della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign. "Il modello economico globale che spinge i prezzi al continuo ribasso e mette in competizione i Paesi a basso salario è troppo forte. È un dato di fatto che i lavoratori che producono quasi tutti gli abiti che compriamo vivono in povertà, mentre le grandi marche si arricchiscono grazie al loro lavoro. È tempo che i marchi adottino misure efficaci di contrasto al sistema di sfruttamento che hanno creato e da cui traggono profitto".
I salari di base in Etiopia e Bangladesh sono meno di un quarto del salario dignitoso, mentre in Romania e in alcuni altri paesi dell'Europa orientale il divario è ancora maggiore, con i lavoratori che guadagnano solo un sesto di quanto necessario per vivere con dignità e mantenere una famiglia [1]. Di conseguenza, i lavoratori sono costretti a vivere in baraccopoli, soffrono di malnutrizione e debiti, spesso non possono permettersi di mandare i loro figli a scuola, il tutto mentre lavorano ore e ore di straordinario per cercare di sbarcare il lunario.
Marchi come C&A, H&M, Zara, Primark, Nike, Adidas e Zalando, tra gli altri, sono tutti responsabili di non aver fatto abbastanza per arginare la povertà dei lavoratori.
Deborah Lucchetti ha concluso: "I marchi e i distributori globali sanno da anni che i salari pagati ai lavoratori non sono sufficienti per permettergli di vivere con dignità ma continuano a fare promesse vuote mentre rastrellano profitti enormi. Se i marchi fossero davvero impegnati a pagare un salario dignitoso, dovrebbero passare dalle parole ai fatti, scegliendo un parametro di riferimento credibile, informando i fornitori e aumentando i prezzi di acquisto in coerenza. Dovrebbero iniziare subito con i 50 maggiori fornitori e rendere pubblici i libri paga, a dimostrazione che ciò stia realmente accadendo. È una questione affrontabile, basta mettere mano alla redistribuzione della catena del valore e pagare di più i lavoratori”.
Interrogativi sollevati a seguito dell’intesa raggiunta sull’Accordo sugli incendi e la sicurezza degli edifici Bangladesh (Accord).
Il 19 di maggio 2019 la Corte d’Appello della Corte Suprema del Bangladesh ha accettato un Protocollo di Intesa raggiunto all’inizio del mese tra il Comitato Direttivo dell’Accordo e l’associazione degli imprenditori tessili BGMEA. Il Protocollo stabilisce che l’Accordo continuerà ad operare in Bangladesh per un periodo di transizione di 281 giorni lavorativi durante i quali i marchi, i sindacati e il BGMEA daranno vita ad una nuova istituzione denominata RMG Sustainability Council (RSC) che assumerà le mansioni dell’Accordo nel 2020.
Il Protocollo mette fine ad un periodo di incertezza circa il futuro dell’Accordo nel paese e assicura la sua operatività ancora per un anno, ma non ne elimina totalmente il senso di incertezza, lasciando ambiguità circa l’impatto immediato sulla funzionalità dell’Accordo. Esso solleva anche dubbi su elementi vitali relativi alle future istituzioni previste. Alcuni mediae rappresentati dei lavoratori in Bangladesh hanno già sollevato questioni relativa al fatto se il Protocollo indebolirà l’indipendenza dell’Accordo e darà più potere agli imprenditori locali. “Avrà delle conseguenze negative”, ha dichiarato il leader sindacale Babul Akhter a AFP.
L’impatto immediato dl Protocollo
La presenza concordata di una “Unità BGMEA”all’interno dell’ufficio dell’Accordo e l’esatta funzione di questa entità, costituisce fonte di preoccupazione. Secondo il Protocollo di intesa, i Piani di azione correttiva saranno valutati in collaborazione con questa unità. Questo solleva interrogativi circa l’influenza dei datori di lavoro sull’indipendenza del processo decisionale dell’Accordo. Inoltre, una presenza visibile delle imprese all’interno dell’ufficio dell’Accordo potrebbe avere un impatto negativo sulla disponibilità dei lavoratori a fidarsi del meccanismo di denuncia, una delle caratteristiche più importantidell’Accordo.
Ci sono timori che il BGMEA, che ha ripetutamente e pubblicamente rigettato il lavoro dell’Accordo come interferente nei suoi affari, proverà ad utilizzare questa Unità per esercitare una influenza indebita sul funzionamento indipendente dell’Accordo, contrariamente all’intento del Protocollo. Tali timori sono rinforzati da una recente dichiarazione media del BGMEA secondo la quale selezione ed esclusione delle fabbriche dalla fornitura dei marchi firmatari richiederà il consenso del BGMEA, laddove il Protocollo semplicemente richiama la “collaborazione” sul processo di escalation. Il linguaggio del Protocollo dà origine a diverse interpretazioni ed è assolutamente urgente fare maggiore chiarezza.
Interrogativi e preoccupazioni in merito al RMG Sustainability Council.
Il Protocollo di intesa inoltre ha annunciato la nascita di un sistema permanente nazionale di monitoraggio della sicurezza denominato RMG Sustainability Council (“RSC”), istituito a partire dall’infrastruttura dell’Accordo, continuando il suo lavoro e mantenendo lo stesso livello di trasparenza.
Il Protocollo di intesa non fa chiarezza sulla struttura decisionale del nuovo organismo,sul meccanismo di finanziamento e di attuazione, incluso se tale nuova istituzione avrà la stessa natura legalmente vincolante dell’Accordo. Ciò significa che i seri interrogativi sollevati dall’aggiunta di un nuovo stakeholder (gli imprenditori) al programma rimangono irrisolti. Per esempio, se la componente sindacale continuerà ad avere la metà dei voti nella struttura di governance o potrà essere facilmente essere messa in minoranza dai marchi e dai datori di lavoro alleati. Non è chiaro neanche cosa comporterà per i livelli futuri di trasparenza, l’evidente esclusione delle ONG quali agenzie di controllo, da questo nuovo organismo e come questo dovrebbe essere interpretato in un Paese dove il diritto fondamentale alla libertà di associazione e di espressione dei sindacati resta fortemente sotto minaccia.
Per il bene dei lavoratori tessili in Bangladesh, è di massima importanza accertarsi che la nuova istituzione operi secondo gli stessi principi e criteri che hanno reso l’Accordo così credibile ed efficace nel garantire protezione ai lavoratori.
Questo implica:
- un sistema di ispezioni meticoloso e trasparente che operi indipendentemente da qualunque influenza delle imprese;
- la formazione dei lavoratori e un sistema di denuncia che permetta ai lavoratori di proteggere la propria sicurezza e i propri interessi contro quelli del management senza avere paura di ritorsioni;
- robusti e credibili meccanismi di attuazione e controllo dove i sindacati abbiano la capacità di far rispettare l’accordo attraverso l’arbitrato vincolante;
- una forte e indipendente leadership dell’Accordo dove l’Ispettore Capo mantenga piena e indipendente discrezionalità per assumere decisioni sulle misure correttive da adottare e sulla pianificazione delle ispezioni, laddove necessario.
(2019) Romania: salari da fame. Meno di un sesto del salario dignitoso
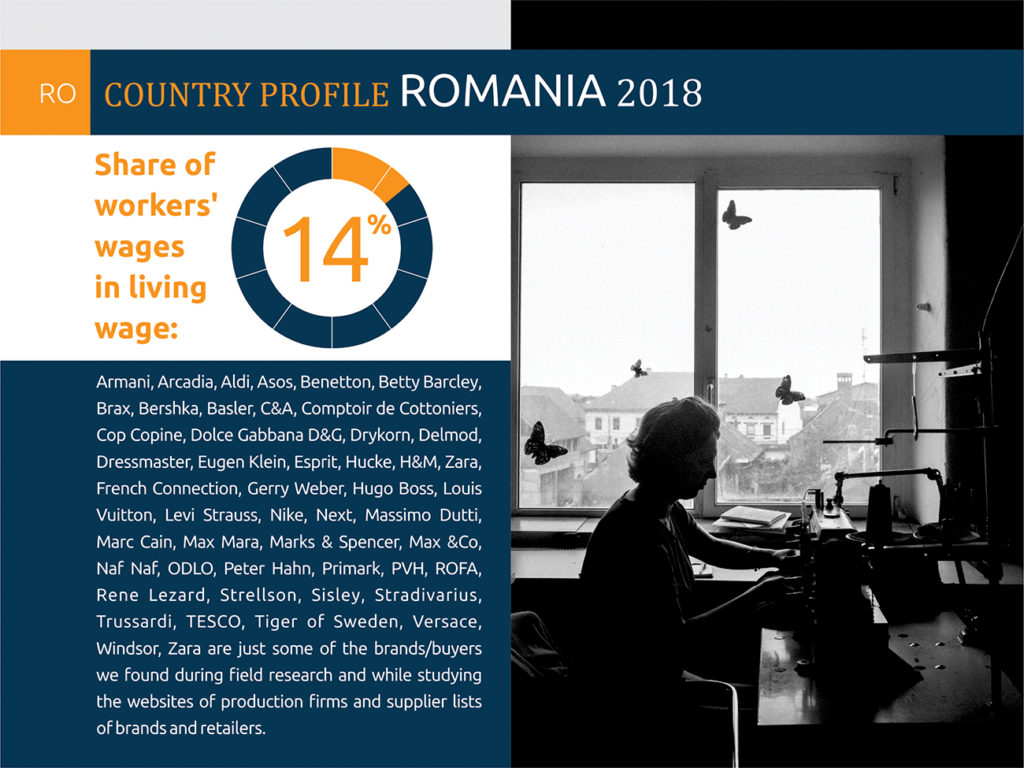
I lavoratori dell'abbigliamento in Romania guadagnano solo il 14 per cento del salario dignitoso. Per questo motivo i loro familiari sono costretti a cercare lavori precari in Europa occidentale.
Il nuovo rapporto della Clean Clothes Campaign dedicato alla Romania analizza ampie ricerche che coprono gli ultimi sei anni, con particolare attenzione al periodo 2017-2018. Quasi mezzo milione di persone lavora nell'industria della moda rumena - la maggiore forza lavoro di questo settore in Europa. Le principali destinazioni di esportazione dell'abbigliamento "Made in Romania" sono l'Italia, il Regno Unito, la Spagna, la Francia, la Germania e il Belgio. I marchi rilevati durante le indagini spaziano da discount e aziende di fast fashion a marchi del lusso di alta gamma, tra cui Armani, Aldi, Asos, Benetton, C&A, Dolce & Gabbana, Esprit, H&M, Hugo Boss, Louis Vuitton, Levi Strauss, Next, Marks & Spencer, Primark e Zara (Inditex). Con quasi 10.000 fabbriche e laboratori, la Romania rappresenta a uno dei paesi di produzione storici per i marchi di moda dell'Europa occidentale.
Da più di un decennio, l'industria dell'abbigliamento del Paese soffre di una drammatica carenza di manodopera, a causa delle condizioni di lavoro pessime. I lavoratori considerano i salari bassissimi del settore come il problema più grave: la paga media dei lavoratori intervistati per un orario di lavoro regolare è pari solo al 14% del salario dignitoso. Contrariamente alla legge, una cifra spesso inferiore al salario minimo legale, che di per sé costituisce comunque solo il 17% del salario vivibile. Sempre secondo i lavoratori, il mancato pagamento del salario minimo legale costituisce la norma. Molti di loro riferiscono di essere costretti a contrarre prestiti per far fronte alle spese quotidiane, come quelle di riscaldamento in inverno. Ciò significa che la maggior parte è fortemente indebitata. "Sto restituendo un prestito mentre guadagno 150 euro al mese. Soldi chiesti non per acquisti di lusso, ma per pagare le mie cure mediche", ha riferito un lavoratore al nostro ricercatore.
Oltre a contrarre debiti, i lavoratori e le loro famiglie sopravvivono, nonostante la povertà dei salari, grazie all'agricoltura di sussistenza, condotta oltre le lunghe ore di lavoro in fabbrica, e grazie al sostegno dei membri della famiglia che migrano verso l'Europa occidentale in cerca di lavoro. Quasi tutti gli altri lavoratori intervistati hanno raccontato di avere familiari che lavorano nell'edilizia o nell'agricoltura, ad esempio in Italia o in Francia. La migrazione della manodopera verso l'Occidente è una conseguenza diretta della povertà dei salari. "Provate a mantenere le vostre famiglie per un solo mese con i nostri salari" è stato l’invito di un lavoratore rivolto alle aziende che producono abiti nella fabbrica in cui è impiegato.
Oltre ai bassi salari, i lavoratori della metà delle fabbriche oggetto di indagine riferiscono di ore di lavoro straordinario non retribuito, così come di ventilazione e aria condizionata non funzionanti in un Paese dove le estati possono essere roventi. La ricerca ha riscontrato anche casi di straordinari forzati e di accesso limitato o mancato all'acqua. Tutti i lavoratori si sono lamentati di essere vittime di bullismo: vengono maltrattati verbalmente, molestati e costantemente minacciati di licenziamento.
Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti, membro italiano della Clean Clothes Campaign, lo riassume così: “I marchi del tessile spesso si vantano di portare lavoro in quei Paesi in cui ce ne bisogno e di offrire soprattutto alle donne una strada per uscire dalla povertà. La nuova ricerca della CCC dimostra che lavorare per i marchi della moda occidentali non costituisce una via di uscita dalla povertà, piuttosto favorisce la contrazione di debiti per sopravvivere ed è causa di separazione delle famiglie. Nessuno dei marchi che si rifornisce in Romania si è impegnato seriamente ed efficacemente contro le violazioni dei diritti umani e del lavoro nel Paese. È giunto il momento che l’Unione Europea introduca norme vincolanti sui diritti umani lungo le catene di forniturae affronti le grandi disuguaglianze all’interno del continente. In una parte - quella occidentale - i salari minimi legali sono a prova di povertà; nell’altra sono addirittura al di sotto della soglia di povertà stabilita dall’Unione Europea.”
La Clean Clothes Campaign chiede che l’Unione Europea sviluppi una politica comune sui salari minimiper garantire in tutti gli Stati membri il rispetto del diritto umano a un salario vivibile, applicando di fatto il suo “Pilastro dei diritti sociali”. In particolare al Capitolo II, paragrafo 6 di questo documento si legge che “i lavoratori hanno diritto a salari equi che garantiscano un tenore di vita dignitoso” e che “la povertà lavorativa deve essere prevenuta”.
Gli azionisti di H&M coglieranno l'opportunità di far uscire i lavoratori dalla povertà?
Nel 2013 H&M si è impegnata a garantire salari dignitosi entro il 2018 a 850.000 lavoratori della sua catena di fornitura. La promessa aveva avuto molto risalto mediatico, portando benefici all'immagine pubblica del brand. Peccato che il tempo sia scaduto e nessun lavoratore abbia visto aumentare il proprio salario fino alla soglia di dignità.
Abbiamo già raccolto oltre 170 mila firme per chiedere a H&M di mantenere la sua promessa e presto le consegneremo al CEO Karl-Johann Persson e alla responsabile della sostenibilità Anna Gedda.
Nel frattempo però, abbiamo fatto qualcosa in più. Abbiamo comprato alcune azioni di H&M garantendoci così l'opportunità di presentare una risoluzione agli azionisti durante la prossima Assemblea generale annuale dell'azienda che si terrà a Stoccolma il prossimo 7 maggio.
Con questa risoluzione chiederemo agli azionisti di usare i loro profitti del 2019 per istituire un fondo e iniziare a pagare salari dignitosi ai loro lavoratori.
CI SERVE ANCORA IL TUO SOSTEGNO:
CHIEDI AGLI AZIONISTI DI VOTARE LA NOSTRA RISOLUZIONE
QUI TUTTE LE ISTRUZIONI SU COME ATTIVARTI:
https://turnaroundhm.org/take-action/
#TurnAroundHM #ShareYourProfits
Il governo del Bangladesh non è pronto a sostituirsi all’Accordo per la sicurezza
Il governo del Bangladesh sta utilizzando i procedimenti dinanzi alla Corte Suprema per impedire il funzionamento dell’Accordo sugli incendi e la sicurezza degli edifici (Accordo), mettendo così a rischio la sicurezza dei lavoratori. Una sentenza della Corte d'appello bengalese prevista per il prossimo 7 aprile potrebbe imporre all'Accordo di chiudere l'ufficio e le operazioni di Dhaka senza considerare se le agenzie nazionali siano in grado di farsi carico di questo lavoro.
Il governo sostiene di avere la capacità di controllare le 1.688 fabbriche di competenza dell’Accordo ma la ricerca pubblicata oggi da Clean Clothes Campaign, International Labor Rights Forum, Maquila Solidarity Network e Worker Rights Consortium (firmatari dell’Accordo in qualità di testimoni) mostrano un livello scioccante di impreparazione.
In particolare, si evince che:
- I due database governativi destinati a fornire informazioni sul risanamento delle fabbriche di abbigliamento sono incompatibili tra loro e non forniscono informazioni sulle ispezioni successive.
- Nessuno dei 745 stabilimenti del programma di ispezione governativo ha ancora eliminato i rischi per la sicurezza identificati negli ultimi tre/cinque anni. Tra questi figurano, ad esempio, le vie di uscita bloccate che, in caso di incendio, potrebbero lasciare i lavoratori intrappolati all'interno. Molti pericoli ad alto rischio dovrebbero - e avrebbero potuto - essere eliminati immediatamente dopo essere stati identificati.
- Il governo ha il potere di chiudere le fabbriche ritenute talmente pericolose da mettere a rischio la sicurezza immediata dei lavoratori. Come è stato ampiamente riconosciuto, se il governo avesse utilizzato questo potere quando le crepe del Rana Plaza erano state identificate pochi giorni prima del crollo nel 2013, migliaia di vite sarebbero state salvate. L'Accordo ha identificato 114 fabbriche di questo tipo, talmente insicure da eliminarle dal suo programma di ispezione. Oggi, la metà di queste stesse strutture rimane aperta nell'ambito del programma di ispezione del governo, ma nei registri non vi è alcuna indicazione che siano stati apportati miglioramenti in materia di sicurezza al loro interno
- Il governo sostiene di aver ricevuto 18 denunce dal 2013 attraverso il suo meccanismo di segnalazione. L'Accordo, nello stesso periodo, ne ha ricevute 1.152. Questa netta differenza potrebbe essere attribuita, in parte, al fatto che il governo non garantisce l'anonimato dei lavoratori che presentano reclami contro le fabbriche.
- In diversi dibattiti pubblici, il governo ha dichiarato che il 29% di tutti i lavori di ristrutturazione richiesti nelle fabbriche di sua competenza sono stati completati. Uno sguardo più attento ai loro dati però dimostra che si tratta di una grossolana sovrastima. 346 su 400 fabbriche (per le quali ci sono informazioni disponibili) hanno completato meno del 20% di tutti i lavori di ristrutturazione richiesti. Solo due stabilimenti hanno completato tra il 21 e il 40% dei lavori di risanamento. Sulle restanti 52 fabbriche non ci sono informazioni. Al contrario, l'89% dei lavori di ristrutturazione necessari in tutti gli stabilimenti coperti dall'Accordo sono stati completati.
Sia i marchi che le organizzazioni firmatarie dell'Accordo di Transizione 2018 si sono impegnati a trasferire la responsabilità dei lavori di ispezione e bonifica una volta che sia stata istituita un'agenzia nazionale di regolamentazione credibile. Attualmente, le parti interessate a livello internazionale concordano sul fatto che le agenzie nazionali di ispezione del Bangladesh non soddisfino ancora gli standard previsti in materia di trasparenza, monitoraggio o esecuzione. Le agenzie di controllo del governo sono molto in ritardo nel completare i lavori di messa in sicurezza presso le fabbriche di abbigliamento che producono per marchi non firmatari dell’Accordo o per il mercato interno. Nonostante ciò il governo del Paese sostiene che i suoi organismi di controllo siano pronti ad assumersi l’incarico, considerando di fatto l'Accordo non più necessario. Per questo esso sta spingendo per un rapido trasferimento non solo del sistema di ispezioni e riparazione, ma anche del meccanismo dei reclami e dei programmi di formazione sulla sicurezza svolti ora dall'Accordo, rifiutandosi di discutere e considerare un processo graduale basato su una valutazione dell’effettiva capacità di subentrare definitivamente all’Accordo.
Benetton, il colore del risentimento
Un'interessante inchiesta di Margherita Nasi e Aureliano Tonet pubblicata da Le Monde sugli affari della famiglia Benetton, dalle autostrade alla moda. Leggi l'inchiesta
Nuovo incendio in Bangladesh: le agenzie nazionali di controllo non sono all'altezza
 Gli incendi alle fabbriche di abbigliamento in Bangladesh confermano che le agenzie nazionali di controllo non sono ancora all’altezza del loro compito.
Gli incendi alle fabbriche di abbigliamento in Bangladesh confermano che le agenzie nazionali di controllo non sono ancora all’altezza del loro compito.
Un altro incendio in una fabbrica di abbigliamento del Bangladesh a Dhaka ha ferito otto persone, secondo i media locali. Questo tragico incidente è avvenuto durante un periodo di incertezza e di negoziati sul futuro dell’Accordo sugli incendi e la sicurezza degli edifici in Bangladesh (Accordo): l'unico programma internazionale che ha migliorato significativamente la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'abbigliamento dopo il crollo della Rana Plaza nel 2013. L'incendio conferma che, nonostante le affermazioni contrarie del governo del Bangladesh, gli organismi di controllo nazionali non sono ancora pronti ad assumersi la responsabilità di questo importante lavoro.
I media bengalesi raccontano di un incendio divampato lo scorso 4 marzo a Baipail, Ashulia, alla periferia di Dhaka, nella fabbrica Anzir Apparels Ltd, uno stabilimento presente sul sito web dell'Alliance for Bangladesh Worker Safety, un programma di sicurezza istituito da Gap, Walmart, VF e altri marchi nordamericani in risposta al crollo della Rana Plaza. Secondo il sito web dell'Alleanza, la fabbrica non era riuscita a compiere adeguati progressi in tema di sicurezza dopo che alcune ispezioni del 2014 avevano rivelato enormi problemi. Per questo era stata rimossa da quella lista, intendendo che nessuno dei marchi dell’Alleanza vi si sarebbe più rifornito. Lo stabilimento ha poi chiuso nel marzo 2016. Tra i problemi individuati vi era la mancanza di un adeguato sistema di allarme antincendio, di attrezzature antincendio e di uscite di emergenza sicure. Secondo i lavoratori però la fabbrica non è rimasta chiusa, ma è stata riaperta due mesi dopo. Nel 2017 infine un marchio firmatario dell’Accordo ha effettuato un ordine, ma in tre mesi la fabbrica ha chiuso di nuovo invece di correggere le falle come richiesto.
Il recente incendio dimostra che la fabbrica aveva ricominciato di nuovo a produrre e, secondo i lavoratori, già nel 2017. Lo ha fatto senza affrontare adeguatamente gli evidenti problemi di sicurezza individuati nei rapporti di ispezione, resi pubblici e condivisi con le autorità. L'organismo di controllo che avrebbe dovuto sovrintendere la situazione, il Bangladesh Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE), sembra aver registrato la ripresa dell'attività della fabbrica, ma senza riuscire ad intraprendere alcuna azione. Sul suo sito web e su quello della Remediation and Coordination Cell (RCC), un'organizzazione ombrello per le autorità ispettive del Bangladesh, la Anzir Apparels Unit 1 è elencata come "in funzione", mostrando una sintesi del rapporto di ispezione iniziale dell'Alleanza, ma senza ulteriori segnali di azione.
La fabbrica non solo ha ignorato le misure di sicurezza, ma anche i diritti dei lavoratori. Recentemente ha cambiato il suo nome in BP Fashion come mossa contro il sindacato di fabbrica, registrato con il vecchio nome e non in grado di accreditarsi nel presunto "nuovo" stabilimento. Ciò è particolarmente preoccupante, poiché la capacità di organizzazione dei lavoratori è fondamentale per la salvaguardia della loro sicurezza, permettendo di denunciare collettivamente i pericoli e rifiutare il lavoro non sicuro. L'Accordo riconosce la libertà di associazione sindacale come parte centrale del suo mandato.
Gli organismi nazionali di ispezione hanno quindi consapevolmente consentito il funzionamento di una fabbrica che, nonostante le sollecitazioni, ha ripetutamente omesso di affrontare i pericoli per la sicurezza ed è stata attiva per tutti questi anni, ad eccezione di due brevi periodi nel 2016 e 2017. Una tale flagrante mancanza di responsabilità dimostra ancora una volta che le autorità nazionali di ispezione del Bangladesh sono pericolosamente in ritardo nell'ispezione, nel monitoraggio e nell'applicazione di misure correttive nelle fabbriche di abbigliamento di loro competenza. Questa osservazione è dimostrata dai numeri: ad esempio, secondo un rapporto del settembre 2018 cofirmato dal governo del Bangladesh, solo il 29% dei difetti di sicurezza iniziali riscontrati nelle fabbriche coperte da organismi di ispezione nazionali sono stati eliminati. Molti dei problemi di sicurezza che rimangono in sospeso costituiscono pericoli immediati per i lavoratori del settore dell'abbigliamento e la maggior parte dei termini imposti per adeguarsi sono scaduti anni fa. La valutazione della situazione è ulteriormente ostacolata dalla mancanza di trasparenza: nessun rapporto di follow-up delle ispezioni è disponibile al pubblico.
Negli ultimi mesi, il governo del Bangladesh ha cercato di garantire ai marchi, ai governi stranieri e ai giornalisti che le sue agenzie nazionali fossero all'altezza del compito di ispezionare e far rispettare le misure correttive in tutte le fabbriche di abbigliamento del Paese. Ha ripetutamente affermato che fosse giunto il momento che i programmi internazionali di sicurezza creati in risposta alla tragedia del Rana Plaza trasferissero le loro responsabilità alle agenzie di ispezione nazionali, plaudendo all'Alleanza per aver rivisto le sue attività e cercando attivamente di limitare l'Accordo.
Deborah Lucchetti della Campagna Abiti Puliti, coalizione italiana della Clean Clothes Campaign ha dichiarato: "Alla luce della mancanza di capacità degli organismi di controllo nazionali dimostrata ancora una volta da questo incendio, e ulteriormente aggravata dal fatto che essi sono responsabili anche di tutti gli altri edifici industriali del Paese, risulta evidente che oggi il passaggio delle funzioni ispettive delle fabbriche monitorate dall'Accordo a questi organismi sarebbe estremamente irresponsabile. Non può esserci un trasferimento di responsabilità fino a quando l'Accordo non avrà terminato la messa in sicurezza delle fabbriche di sua competenza affrettandosi ad ampliare la sua portata e includere l’ispezione delle caldaie e le industrie correlate nella filiera tessile. L’Accordo dovrebbe anche esaminare seriamente i reclami dei proprietari delle fabbriche per i prezzi sleali pagati dai marchi che limitano le possibilità di investire in sicurezza. Allo stesso tempo il governo del Bangladesh dovrebbe accelerare le riforma degli enti nazionali per garantire trasparenza e ispezioni continuative, secondo standard elevati a reale protezione della vita dei lavoratori”
Le organizzazioni che hanno firmato l’Accordo del Bangladesh in qualità di testimoni - Clean Clothes Campaign, International Labor Rights Forum, Maquila Solidarity Network e Worker Rights Consortium- invitano il governo del Bangladesh a rispondere a questo incendio sostenendo pubblicamente e senza condizioni il lavoro salvavita svolto dell'Accordo fino a quando l’impegno avviato con il crollo della Rana Plaza non sarà completamente portato a termine.
Note:
- L'Alleanza cita lo stabilimento come chiuso l'8 marzo 2016: http://www.bangladeshworkersafety.org/factory/suspended-factories?fid=10149#table
- Il database DIFE-RCC considera la fabbrica “in funzione” e cita un sommario dell’ispezione dell’Alleanza http://database.dife.gov.bd/index.php/factories/alliance-assessed/details/4/332
- I problemi di capacità dell'organismo nazionale di controllo sono stati resi evidenti anche da un altro incendio in un quartiere di Dhaka divampato pochi giorni prima. https://www.business-humanrights.org/en/dhaka-fire-shows-that-bangladesh-must-build-better-safety-systems-rather-than-scrap-the-accord.
- Il rapporto di settembre 2018 del Bangladesh Sustainability Compact dichiara una bonifica del 29% per le fabbriche tessili coperte dagli organismi di ispezione nazionali. Ciò contrasta con il tasso di bonifica dell'89% annunciato dall'Accordo un mese dopo per 1.572 fabbriche di sua competenza.
Manifestazioni davanti alle ambasciate del Bangladesh per chiedere il rispetto dei diritti dei lavoratori del tessile
Questa settimana attivisti e sindacalisti in tutto il mondo protesteranno davanti alle ambasciate e ai consolati del Bangladesh per esprimere solidarietà ai lavoratori bengalesi del settore tessile. Attraverso una settimana di solidarietà globale chiederanno salari dignitosi, fabbriche sicure e la fine della repressione dei lavoratori. La preoccupazione per i diritti dei lavoratori dell’abbigliamento sta crescendo dopo la risposta violenta alle recenti proteste per i salari scoppiate in Bangladesh e il protrarsi delle vicende giudiziarie dell’Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici in Bangladeshche stanno minando progressi essenziali nel campo della sicurezza delle fabbriche.
Salari da fame e violenze
Lo scorso dicembre, migliaia di lavoratori sono scesi in piazza per protestare dopo che la revisione dei livelli salariali si è rivelata avere impatti significativamente diversi per i lavoratori a seconda del loro livello retributivo: per alcuni significa solo pochi centesimi in più in busta paga.
L’atteso aumento dei salari minimi è arrivato dopo un processo lungo e molto problematico, privo di un’adeguata rappresentanza delle voci dei lavoratori. Il risultato è stato una revisione che corrisponde appena alla metà di quanto chiedevano gli operai, un valore molto lontano da qualsiasi soglia di salario dignitoso. Quando i lavoratori hanno visto nelle loro buste paga a quanto ammontava l’aumento, hanno deciso di scioperare e organizzare massicce proteste, represse violentemente dalla polizia causando un morto e molti feriti.
La violenza è tutt’ora in corso. I dirigenti delle fabbriche hanno licenziato centinaia di lavoratori per aver preso parte alle proteste. Decine di loro, compresi i sindacalisti, sono stati arrestati e ora devono affrontare accuse inventate che potrebbero portare a lunghe pene detentive, oltre a quelle che si trascinano dalle proteste del 2016-2017 per salari più elevati.
Deborah Lucchetti della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign, dichiara: “Il nocciolo della questione è che anche dopo i recenti emendamenti, i lavoratori bengalesi continuano a percepire paghe da fame mentre il governo del Bangladesh continua a intimidire i lavoratori e reprimere qualsiasi tentativo di organizzarsi. I lavoratori hanno il diritto fondamentale di manifestare e scioperare per salari dignitosi e devono essere liberi di farlo. La Campagna Abiti Puliti chiede al governo di rispettare questo diritto, di rilasciare tutti i lavoratori e i sindacalisti arrestati e di ritirare le accuse nei loro confronti”.
I lavoratori hanno bisogno di fabbriche sicure
L’attuale ondata di violenza e repressione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sull’industria dell’abbigliamento del Bangladesh. Da novembre 2018, gli atti della Corte Suprema del Paese stanno generando incertezza sul futuro dell’Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici in Bangladesh. L’Accordo, istituito dopo il crollo del Rana Plaza nel 2013, che uccise almeno 1.134 persone, ha ottenuto miglioramenti concreti e duraturi per l’industria tessile del Paese. Il governo ha ripetutamente sostenuto che il suo programma di ispezioni, il Remediation and Coordination Cell(RCC), sarà presto pronto a subentrare e che l’Accordo dovrebbe essere autorizzato a operare solo temporaneamente e sotto la sua supervisione. Tuttavia, l’RCC non ha ancora dimostrato la capacità o la volontà di eseguire le ispezioni garantendo gli stessi standard di sicurezza previsti dall’Accordo.
“I progressi ottenuti nel campo della sicurezza delle fabbriche in Bangladesh sono stati una dura conquista degli ultimi cinque anni e mezzo” continua Deborah Lucchetti. “L’incertezza intorno al futuro dell’Accordo unita alla repressione delle proteste rischiano di vanificare questi sforzi. Per prevenire un altro caso come quello del Rana Plaza servono due cose: le fabbriche devono essere regolarmente e adeguatamente ispezionate e i lavoratori devono essere liberi di denunciare e organizzarsi. Se chi lavora ha paura di far sentire la propria voce o di rifiutare un lavoro insicuro, i marchi e i consumatori sappiano che torneranno le condotte aziendali pericolose che hanno causato il crollo del Rana Plaza”.
Durante questa settimana di solidarietà con i lavoratori bengalesi del tessile, le organizzazioni, i sindacati, gli attivisti e i consumatori dimostreranno a favore del rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori che producono gli abiti che tutti indossiamo. Manifestazioni e lettere di protesta coinvolgeranno le ambasciate e i consolati del Bangladesh in molte città del mondo: Berlino, Bruxelles, Londra, Ginevra, Madrid, L’Aia, New York, Washington DC, solo per citarne alcune.

COSA PUOI FARE TU
In 1 minuto
– Firma la petizione
– Condividi sui social networks: “Io sto con i lavoratori tessili del Bangladesh #WeStandWithGarmentWorkers #Bangladesh #FreedomSafetyLivingWage“
In 10 minuti:
– Cerca nel tuo armadio un abito “made in Bangladesh“. Scatta una foto all’etichetta e postala con il testo “Io sto con i lavoratori e le lavoratrici tessili del Bangladesh che producono gli abiti che indosso #WeStandWithGarmentWorkers #Bangladesh #FreedomSafetyLivingWage“
Maggiori informazioni
- Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulle manifestazioni: https://cleanclothes.org/safety/week-of-solidarity
- Lettere di protesta sono state inviate anche alle ambasciate di Edimburgo, Helsinki, Hong Kong, Oslo, Oulo, Roma, Stoccolma, Tampere.
- Le proteste contro l’implementazione della revisione del salario minimo sono scoppiate a dicembre. Si sono fermate il 30 dicembre per le elezioni e sono ripartite il 6 gennaio. La repressione delle forze governative è stata particolarmente violenta, causando 1 morto e circa 50 feriti. Il 13 gennaio è stato annunciato un aumento minimo per tutti i gradi salariali, tranne quelli più bassi, e i lavoratori sono stati invitati a tornare al loro posto di lavoro. Il giorno dopo sono iniziati i primi licenziamenti. Attualmente, secondo quanto riferito, almeno 5.948 lavoratori sono stati licenziati, 2.292 sono sulla “lista nera” e 45, inclusi alcuni sindacalisti, sono stati arrestati. Molte altre denunce sono state depositate contro i lavoratori, la maggior parte delle quali contro ignoti: questo significa che il tribunale potrà inserire qualsiasi lavoratore nella lista delle persone accusate.
- Questa situazione somiglia alla risposta alle proteste per i salari scoppiate nel dicembre 2016-gennaio 2017, quando furono arrestati 30 lavoratori, compresi i dirigenti sindacali; oltre 1.500 lavoratori furono licenziati; circa 50 leader sindacali furono costretti a nascondersi e tutt’ora lo sono. Molte accuse sono ancora pendenti lasciando i lavoratori a rischio costante di arresto.
- Il futuro dell’Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici in Bangladeshrimane incerto fino a quando una decisione della Corte Suprema sull’appello contro un ordine restrittivo pendente sulle sue operazioni nel Paese non verrà emessa. Una nuova audizione è prevista per il 18 febbraio. Per maggiori informazioni:
Repressione in Bangladesh: il governo ascolti i lavoratori
La repressione delle proteste dei lavoratori in Bangladesh mostra la mancanza di rispetto da parte del governo per le libertà fondamentali.
Migliaia di lavoratori in Bangladesh sono scesi in strada per protestare contro la recente revisione dei salari nel settore tessile. Quando la polizia di Dhaka ha iniziato a sparare proiettili di gomma e gas lacrimogeni sulla folla, un lavoratore è rimasto ucciso e molti altri feriti.
La Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign, condanna con forza la violenta repressione del diritto di manifestare e chiede al governo di fermare la violenza e le intimidazioni ai lavoratori e sindacalisti e di smetterla di ignorare le loro richieste.
Il clima generale è pessimo. Le proteste si svolgono in un quadro generale disastroso per la libertà di associazione nel Paese, già evidenziato dalla crisi irrisolta del 2016 in Ashulia, quando in una settimana dozzine di fabbriche chiusero, più di 1500 lavoratori furono licenziati, circa 30 operai e sindacalisti furono arrestati e 50 leader sindacali costretti a nascondersi. Molti hanno ancora accuse pendenti nei loro confronti e sono in costante rischio di arresto.
Il governo del Bangladesh ignorò le richieste di aumento salariale nel 2016. Durante il lungo processo di revisione dei salari dello scorso anno non ha tenuto conto della richiesta dei lavoratori di 16.000 taka (164 euro). Il nuovo salario minimo per i lavoratori meno qualificati è stato fissato solo alla metà: 8.000 taka (82 euro). Per la maggior parte de lavoratori, la nuova revisione non ha praticamente corrisposto nessun aumento del salario base. Allo stesso tempo, le fabbriche stanno prendendo misure contro i lavoratori per mitigare l’effetto del presunto aumento.
Nonostante un clima di paura e intimidazione oltre la già limitata libertà di associazione in Bangladesh, soprattutto in vista delle elezioni nazionali del 30 dicembre, lavoratori e sindacalisti hanno ripetutamente espresso il loro malcontento durante il processo di revisione e dal momento dell’annuncio dell’introduzione del salario minimo.
Durante questo processo di revisione, la Clean Clothes Campaign ha chiesto ai marchi internazionali e ai distributori di sostenere pubblicamente le rivendicazioni dei lavoratori. Alcuni di essi hanno espresso la speranza che la voce dei lavoratori fosse ascoltata ma non si sono impegnati a sostenere una cifra specifica. Quando poi l’annuncio e l’incremento del salario minimo si è dimostrato ben al di sotto delle richieste e della soglia di salario dignitoso, nessuno di questi marchi ha detto nulla.
Le manifestazioni si stanno svolgendo in un momento in cui gli occhi del mondo e dell’industria dell’abbigliamento sono già concentrati sul Bangladesh, dopo la controversa vittoria del partito al potere e con l’Alta Corte in procinto di decidere sul futuro dell’Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici in Bangladesh.
Anche se il governo ha ripetutamente preso impegni a livello internazionale per migliorare la situazione dei lavoratori, le recenti modifiche sono insufficienti per contrastare le preoccupazioni nazionali e internazionali. La libertà di associazione sindacale rimane fortemente ridotta, il che ostacola l’espressione degli interessi dei lavoratori.
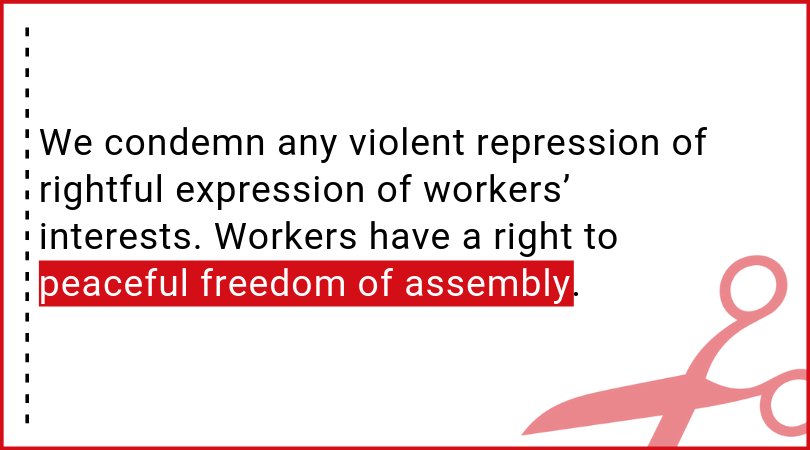
Leggi anche…
- Le nuove proteste sono state innescate dalle disposizioni delle revisioni salariali del 2018, che hanno effetti diversi per grado di retribuzione. Per alcuni livelli salariali, la revisione non ha aumentato il salario di base ma ha adeguato le altre quote. Tuttavia i pagamenti degli straordinari, il trattamento di fine rapporto e i bonus saranno calcolati sulla base di questo salario in gran parte inalterato, il che significa che i benefici per la maggior parte dei lavoratori nel settore non aumenteranno per nulla. Leggi anche: https://cleanclothes.org/news/2018/09/21/outrageous-new-minimum-wage-announced-in-bangladeshe http://www.newagebd.net/article/57668/govt-changes-conditions-paving-way-for-workers-benefit-cut.
- Anche durante queste nuova ondata di proteste ci sono notizie non ancora confermate di procedimenti legali contro i lavoratori che partecipano alla protesta e intimidazioni dei sindacalisti.
- I recenti emendamenti al diritto del lavoro bengalese affrontano in modo insufficiente le preoccupazioni nazionali e internazionali sulla situazione della libertà di associazione sindacale nel Paese. Ad esempio, l’abbassamento dal 30% al 20% della percentuale di iscritti in una fabbrica necessaria per costituire un sindacato, viola ancora gli standard fondamentali ILO. La registrazione dei sindacati rimane macchinosa e il processo di accettazione arbitrario. Maggiori informazioni sulla denuncia della CCC al difensore civico dell’UE qui: https://cleanclothes.org/news/2018/06/11/complaint-lodged-against-the-european-commission-for-failing-to-uphold-fundamental-human-rights-in-trade-policy.
- Il futuro dell’Accordo sul Bangladesh continua a rimanere in bilico. Qui alcune informazioni: https://cleanclothes.org/safety/protect-progresse qui https://cleanclothes.org/news/2018/12/10/bangladesh-government-attempts-to-paralyze-accord-and-strip-its-independence.
Sondaggio Europeo: i cittadini chiedono trasparenza
Mercato abbigliamento italiano:
La maggioranza degli Italiani pensa che i marchi dell’abbigliamento debbano assumersi la responsabilità dell’impatto delle proprie filiere
Lo rivela un sondaggio europeo, il più approfondito mai realizzato.
Solo un Italiano su dieci associa il brand del lusso Gucci a una filiera sostenibile
I consumatori italiani diventano sempre più consapevoli, non solo nel settore della produzione alimentare ma anche in quello dell’abbigliamento e della moda,che, secondo Statista[1]si stima arriverà a un valore di mercato di 42 miliardi di dollari nel 2020. I grandi brand non possono più contare su una fiducia indiscussa ma devono mettere in conto, da parte di chi compra, un occhio sempre più vigile e attento sugli aspetti che riguardano l’ambiente, la salute e le condizioni dei lavoratori.
Lo rivela un sondaggio effettuato da Ipsos MORI per conto di Changing Markets Foundatione Clean Clothes Campaign, che ha evidenziato che solo due Italiani su dieci (22%) ritengono che l’industria informi adeguatamente i consumatori riguardo all’impatto produttivo sull’ambiente e sulla popolazione e otto su dieci (82%) ritengono che i marchi debbano fornire informazioni sugli obblighi assunti e le misure adottate per ridurre l’inquinamento.
Secondo il sondaggio, inoltre, due Italiani su tre (64%) dichiarano di non essere disposti a comprare articoli di abbigliamento da marchi la cui produzione è associata all’inquinamento e addirittura il 72% (i tre quarti degli Italiani) pensa che i marchi di abbigliamento debbano assumersi la responsabilità di ciò che avviene nelle loro catene di produzione e distribuzione e debbano garantire che i loro articoli siano prodotti in maniera ecosostenibile. Per quello che riguarda le condizioni di lavoro e di salario ben otto italiani su dieci (78%) considera importante che i marchi dell’abbigliamento dichiarino in maniera trasparente se i dipendenti che lavorano nelle proprie filiere ricevono un salario dignitoso e il 58% sostiene che non comprerebbe prodotti da un marchio che non paga i giusti compensi.
“Si tratta dell’indagine di mercato più approfondita mai realizzata relativa alla percezione da parte dei consumatori degli standard ambientali e lavorativi nell’industria dell’abbigliamento. L’indagine rivela che i consumatori si aspettano che i marchi si assumano la responsabilità di ciò che avviene all’interno delle proprie filiere e chiedono maggiore trasparenza sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro sia per il rispetto dell’ambiente. I risultati dell’indagine puntano tutti verso un netto cambiamento di mentalità da parte dei consumatori i quali chiedono una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell’industria e più informazioni” dichiara Urska Trunk della Changing Markets Foundation.
Sono sempre più numerosi gli appelli rivolti all’industria della moda italiana affinché adotti processi produttivi più responsabili.[i]Nonostante l’alto valore di mercato del settore, le rivelazioni fatte dalla Clean Clothes Campaign relative alle misere condizioni di lavoro nelle fabbriche in Albania e Macedonia, dove vengono prodotte le calzature cosiddette “Made in Italy” per i marchi di lusso, e i risultati non soddisfacenti delle analisi di “internal auditing” relative alle condizioni di lavoro, hanno causato un danno di immagine e hanno condotto l’opinione pubblica a fare pressione affinché questa situazione cambi.[ii]
In linea generale i marchi del lusso elencati nel sondaggio non sono considerati migliori dei marchi più economici o dei rivenditori al dettaglio. Il sondaggio ha infatti messo in luce alcuni dati sorprendenti relativi ai brand del lusso. Per esempio, il 10% degli Italiani associa il marchio Gucci a una filiera ecosostenibile, contro il 13% di Zara e il 17% di H&M. Ricerche condotte dalla Clean Clothes Campaign tra l’altro rivelano come Gucci si rifornisca in diversi Paesi dove sussistono misere condizioni di lavoro, come la Serbia[1].
Questione viscosa
La viscosa è una fibra vegetale che sta diventando un’alternativa sempre più diffusa al cotone o ai prodotti sintetici. Ma la produzione della viscosa necessita di sostanze chimiche tossiche che hanno effetti nocividocumentati sull’ambiente e sulla salute delle persone se non debitamente controllate.[iii] Più di 303.000 consumatori dell’UE hanno firmato una petizione lanciata da WeMove per chiedere all’industria dell’abbigliamento di impegnarsi nella produzione di viscosa pulita.[iv]
L’indagine Ipsos MORI ha anche rivelato che il 71% degli Italiani concorda sul fatto che i marchi dell’abbigliamento dovrebbero fornire informazioni sui loro produttori di viscosa e il loro impatto sull’ambiente.
Secondo il rapporto della Changing Market Foundation Dirty Fashion: on track for transformation (La moda sporca: sulla via della trasformazione), i brand del lusso italiani quali Gucci, Prada e Fendi sono stati inclusi tra i marchi peggiori per quanto riguarda la viscosa, accanto a rivenditori al dettaglio della fascia più bassa come Lidl ed ASDA.
“Questa indagine indica un forte sostegno da parte dei consumatori alle azioni intraprese dall’industria della moda per garantire che i marchi producano articoli di abbigliamento in maniera ecosostenibile. Le aziende del settore dovranno passare a metodi più “puliti” per soddisfare le aspettative dei consumatori. Ci stiamo rivolgendo alle aziende italiane che si occupano di abbigliamento chiedendo di seguire l’esempio di altri marchi UE e firmare la nostra Roadmap per una filiera della viscosa più pulita. Abbiamo bisogno della massima trasparenza e di uno spostamento verso un modello produttivo che non distrugga la vita delle persone e gli ecosistemi naturali” aggiunge Urska Trunkdella Changing Markets Foundation.
Salari bassi, serve più informazione.
Sempre secondo il sondaggio di Ipsos MORI, più della metà dell’opinione pubblica italiana (54%) ha la sensazione che l’industria della moda paghi salari troppo bassi ai lavoratori delle proprie filiere e due terzi (67%) ritiene che sia difficile sapere con certezza se gli articoli di abbigliamento che acquistano rispettano gli standard etici più alti.
“I consumatori non sono più disposti a comprare prodotti di quei marchi che non pagano salari dignitosi”, dichiaraDeborah Lucchetti della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign. “Se l’industria dell’abbigliamento non si decide ad agire concretamente, convertendo la produzione verso una maggiore sostenibilità e legalità, è giunta l’ora che lo facciano direttamente i governi.”
La Changing Markets Foundation collabora con le ONG realizzando campagne incentrate sui mercati. Il nostro obiettivo è portare all’attenzione dell’opinione pubblica pratiche aziendali irresponsabili e spingerla verso un’economia più sostenibile.www.changingmarkets.org / @ChangingMarkets
Clean Clothes Campaign è un’alleanza globale che si occupa del miglioramento delle condizioni di lavoro e dei diritti dei lavoratori della filiera dell’abbigliamento in tutto il mondo. E’ composta di sindacati e ONG che garantiscono la copertura di un ampio spettro di argomenti e interessi, tra i quali salario dignitoso, salute e sicurezza, trasparenza e lavoro migrantein una prospettiva di genere, azioni di sensibilizzazione dei consumatori e riduzione della povertà. www.cleanclothes.org/ @cleanclothes
Il link al sondaggio:
https://tinyurl.com/ycctqdra
Note:
L’indagine
La Ipsos MORI è stata incaricata dalla Changing Markets Foundation di effettuare un’indagine di mercato presso consumatori adulti tra i 16 e i 75 anni in sette Paesi: GB, USA, Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna. Sono state realizzate 7.701 interviste, pari a più di 1.000 interviste per ogni Paese, come indicato in dettaglio nella tabella.
Totale: 7701
GB: 1117
USA: 1117
Francia: 1100
Germania: 1093
Italia: 1076
Polonia: 1109
Spagna: 1089
Sono state fissate delle quote demografiche per ottenere un campione rappresentativo in ogni Paese. I dati sono stati successivamente ponderati sulla popolazione conosciuta di ogni paese.
L’indagine è stata condotta online, con interviste di gruppo effettuate tramite il sistema Ipsos MORI (i:omnibus), tra il 19 e il 26 ottobre 2018.
Considerato che l’indagine è stata realizzata on line, è rappresentativa solo della popolazione online (c.90% in tutti i paesi).
I confronti tra i vari paesi vengono fatti solo se statisticamente significativi. Trattandosi di un’indagine on line, e quindi con campione auto-selezionato, i margini di errore sono più alti. Tecnicamente la significatività e gli intervalli di confidenza si applicano solo a campioni randomizzati; tuttavia, i campionamenti causali di buona qualità si sono rivelati altrettanto accurati nella pratica.
Il questionario verteva sui seguenti argomenti:
- Domande sulle abitudini di acquisto di articoli di abbigliamento e sulle scelte fatte in merito alla sostenibilità.
- Percezione delle questioni della sostenibilità nell’ambito dell’industria della moda e la filiera dei marchi dell’abbigliamento.
- Opinioni sui diritti dei lavoratori e sui salari pagati nel settore della produzione di articoli di abbigliamento.
- Opinioni specifiche sull’uso della viscosa nei processi produttivi dei capi di abbigliamento.
- Opinioni sui sistemi di certificazione dei capi di abbigliamento attuali e alternativi.
[1]https://www.abitipuliti.org/report/2017-report-europes-sweatshop-leuropa-dello-sfruttamento/
1https://www.statista.com/topics/4124/apparel-market-in-italy/
[ii]https://www.abitipuliti.org/report/2014-report-stiched-up-salari-da-poverta-per-i-lavoratori-dellabbigliamento-in-europa-orientale-e-in-turchia/, https://www.abitipuliti.org/report/2016-report-il-lavoro-sul-filo-di-una-stringa-2/
[iii]https://changingmarkets.org/portfolio/dirty-fashion/
[iv]https://act.wemove.eu/campaigns/zara-hm-abiti-puliti
LEGGI ANCHE…
- AVVENIRE – Abiti puliti. I consumatori:«Più trasparenza su sostenibilità e diritti dei lavoratori»
- REDATTORE SOCIALE – Salari, ambiente, salute: italiani sempre più attenti al mercato dell’abbigliamento
- ANSA – Moda, consumatori consapevoli, occhio ad ambiente anche per i grandi marchi
- HELP CONSUMATORI – Clean Clothes Campaign: 2 italiani su 3 chiedono una moda “più pulita”
- 9 COLONNE – Moda, sondaggio: 70% vuole brand eco-solidali
- AGENPRESS – Abiti Puliti.Sondaggio europeo. Solo un Italiano su dieci associa il brand del lusso Gucci a una filiera sostenibile
- ARTICOLO 21 – Salari, ambiente, salute: italiani più attenti al mercato dell’abbigliamento
- GREEN REPORT – Moda sporca: i marchi dell’abbigliamento devono assumersi la responsabilità dei loro impatti
Week of Justice: le vittime dell'Ali Enterprises in Italia per chiedere giustizia
Con una settimana internazionale di eventi relativi all’incendio della fabbrica Ali Enterprises che nel 2012 uccise oltre 250 persone, le vittime e alcune organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani e dei lavoratori cercheranno di rispondere a una domanda: se quei lavoratori e lavoratrici sono morte mentre cucivano i nostri abiti, di chi è la responsabilità?
Quando la fabbrica è bruciata, il principale acquirente era l’azienda tedesca KiK. Inoltre solo poche settimane prima dell’incendio l’edificio aveva ricevuto una certificazione dall’azienda italiana RINA per conto del Social Accountability International. Da allora, una coalizione di organizzazioni insieme alla Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association ha implementato una strategia comune per accertare le responsabilità delle due aziende e garantire giustizia per le vittime e i loro familiari.
KiK
La battaglia per avere un pieno e giusto risarcimento è un processo tutt’ora in corso. Dopo quattro anni di campagne e negoziati, KiK ha accettato di pagare 6,15 milioni di dollari sotto forma di pensioni a lungo termine per i sopravvissuti e le famiglie delle vittime, per le spese mediche e la perdita di reddito. Sono esclusi i danni per il dolore e la sofferenza causati dal terribile incidente. Una causa civile parallela contro KiK, presso la Corte di Dortmund in Germania, si prefigge di includere anche questo tipo di danni per chiarire maggiormente le responsabilità legali delle aziende nei confronti della catena di fornitura. Sia la campagna internazionale per ottenere i risarcimenti che questa causa legale hanno giocato un ruolo chiave nel mettere sotto pressione KiK, portando l’azienda al tavolo e chiudere il negoziato. Ciò dimostra che le azioni legali possono giocare un ruolo molto importante nelle lotte dei lavoratori per la giustizia.
RINA
Come provato da una video simulazione realizzata dalla Forensic Architecture, sarebbero stati sufficienti piccoli miglioramenti alla sicurezza per salvare centinaia di persone durante l’incendio. Per accertare le responsabilità dell’azienda italiana di auditing RINA nel non aver denunciato questi difetti nella sicurezza, lo scorso settembre la coalizione internazionale di attivisti e difensori dei diritti umani insieme all’associazione delle vittime del rogo della Ali Enterprises hanno presentato un’istanza OCSE contro l’azienda presso il Punto di Contatto Nazionale in Italia.
Dal 26 novembre al 4 dicembre, ospiti dal Pakistan strettamente collegati al caso viaggeranno per l’Europa. Presenteranno il loro caso al Global Forum for Business and Human Rights delle Nazioni Unite a Ginevra, parteciperanno alla prima audizione orale presso la Corte di Dortmund e incontreranno i responsabili del Punto di Contatto Nazionale OCSE in Italia.

Ecco il programma del loro viaggio e delle piccole biografie dei partecipanti.
26 novembre, Ginevra
ore 10.00 – UN Forum on Business and Human Rights
28 novembre, Dortmund/Bochum
ore 10.00 – Conferenza stampa Theater Dortmund
ore 13.30 – Symposium alla Bochum University (German/English): Strategies of Justice – Fighting Factory Disasters in South Asia
ore 20.00 – Evento pubblico, Schauspiel Dortmund
29 novembre, Dortmund
ore 10.00 – Riunione di fronte al Tribunale (Landgericht)
ore 12.00 – Audizione pubblica in tribunale
3 dicembre, Roma
ore 11.00 – Conferenza stampa Sala “Caduti di Nassirya”, Piazza Madama, Roma – Senato della Repubblica
ore 17.00 – Incontro Ministro Plenipotenziario Fabrizio Petri, Presidente del Comitato Interministeriale per i diritti umani
4 dicembre, Roma
ore 14.30 – Incontro con Stefano Firpo, Direttore Generale – Presidente, e Benedetta Francesconi, Segretariato, del Punto di Contatto Nazionale OCSE
LEGGI ANCHE
RADIO 1 – Intervista a Radio Anch’io
REPUBBLICA – Sfruttamento e morte sul lavoro, in Senato le vittime dell’incendio nella fabbrica Ali Enterprises in Pakistan
AVVENIRE – I sopravvissuti della Ali Enterprises in Italia per chiedere giustizia
VITA – Le vittime dell’incendio alla fabbrica Ali Enterprises in Italia per chiedere giustizia
VALORI – Dietrofront sulla sicurezza nella patria del tessile low cost
HELP CONSUMATORI – Ali Enterprises: serve ancora giustizia per le vittime
AGENPRESS – Le vittime dell’incendio alla fabbrica Ali Enterprises in Italia per chiedere giustizia
RADIO ARTICOLO 1 – I sopravvissuti dell’Ali Enterprises
RADIO IN BLU – I familiari delle vittime della fabbrica Ali Enterprises in Italia per chiedere giustizia
Saeeda Khatoon ha perso il suo unico figlio nell’incendio di Karachi dell’11 settembre 2012. Da allora, ha continuato a lottare insieme all’Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association (AEFFAA), di cui è Presidente, per chiedere giustizia per i sopravvissuti e i familiari delle vittime. È una dei quattro cittadini pakistani ad aver intentato causa contro KiK in Germania. AEFFAA fa parte della coalizione di organizzazioni internazionali che ha inoltrato la denuncia all’OCSE nell’autunno 2018 contro la società italiana RINA.
Nasir Mansoor è Vice Segretario Generale della Pakistani National Trade Union Federation (NTUF). Lavora a stretto contatto con l’Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association (AEFFAA), supportando la loro richiesta di giustizia a livello locale e internazionale. Anche NTUF fa parte della coalizione di organizzazioni internazionali che ha inoltrato la denuncia all’OCSE nell’autunno 2018 contro la società italiana RINA.
Deborah Lucchetti è la coordinatrice della Campagna Abiti Puliti, la sezione italiana della Clean Clothes Campaign (CCC), una rete globale di sindacati e Ong che si battono per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore tessile. È impegnata, tra le altre cose, come rappresentante italiana nel lavoro di monitoraggio della CCC sul Bangladesh Accord on Fire and Building Safety e nelle campagne internazionali per i risarcimenti alle vittime dei casi Rana Plaza, Tazreen e Ali Enterprises, visto il coinvolgimento di molti marchi italiani e della società italiana di certificazione RINA.
Alessandro Mostaccio è un avvocato con una lunga esperienza come Pubblico Ministero, si è occupato di migliaia di procedimenti penali come giudice ordinario a Torino. Dal 2004, è Presidente dell’Associazione Movimento Consumatori Torino e dal 2013 Segretario Generale nazionale del Movimento Consumatori. L’organizzazione partecipa alla campagna internazionale per supportare le vittime dell’incendio alla Ali Enterprises per ottenere un pieno risarcimento, visto che la fabbrica era stata certificata dall’auditor sociale italiano RINA solo poche settimane prima dell’incidente.
Dr. Carolijn Terwindt è un Consulente Legale Esperto del programma Business and Human Rights dell’European Center for Constitutional and Human Rights’ (ECCHR). Una delle sue principali aree di lavoro è la responsabilità aziendale di clienti, commercianti e fornitori di servizi di certificazione nelle catene di fornitura dell’industria tessile globale. Nel 2013 si è recata a Karachi per la prima volta e da allora lavora a stretto contatto con le vittime dell’incendio. È stata coinvolta nella preparazione della causa contro KiK in Germania. Inoltre ha lavorato con i querelanti e le organizzazioni partner sulla denuncia all’OCSE contro la società italiana RINA.
Ben Vanpeperstraete è il coordinatore del team Lobby e Advocacy della Clean Clothes Campaign. Precedentemente ha ricoperto il ruolo di Supply Chain Coordinator presso UNI Global Union e IndustriALL Global Union, dove ha supportato il lavoro sull’innovativo Bangladesh Accord on Fire and Building Safety (Bangladesh Accord). È stato coinvolto negli Accordi di Risarcimento sugli incidenti Rana Plaza, Tazreen e Ali Enterprises. Inoltre è membro del OECD Advisory Group on Responsible Supply Chains in the Textile and Garment Sector.
H&M e le mancate promesse: una settimana globale di mobilitazione
Da Delhi a Londra, da Washington DC a Zagabria e in molte altre città, attivisti riportano l’attenzione sul mancato impegno dell’azienda H&M di corrispondere a 850 mila lavoratori tessili un salario dignitoso. Gli operai di uno dei principali poli europei della logistica di H&M a Stradella (Italia) denunciano condizioni di lavoro misere e precarie ed esprimono la loro solidarietà a tutti gli altri lavoratori della catena di fornitura H&M.
“Mai avrei immaginato che H&M mi avrebbe stravolto la vita” scrive una lavoratrice che confeziona pacchi di abbigliamento per H&M presso il polo logistico di Stradella in Italia in una lettera agli altri lavoratori della catena dell’azienda svedese. “Nell’enorme magazzino in cui lavoro (…) il turno iniziava alle 4,30 della mattina con nessuna certezza dell’orario di uscita. Tutto era possibile, 4 ore di lavoro come 12”.La lavoratrice preferisce l’anonimato visto che XPO, l’azienda che gestisce il polo logistico, ha intentato una causa contro 147 lavoratori e il sindacato che li rappresenta nella lotta per migliorare le loro condizioni di lavoro.
“Il modello di business di H&M sta mettendo sotto pressione i lavoratori e le lavoratrici a diversi livelli della catena di fornitura. Ma chi cuce nelle fabbriche, chi si occupa di smistare i pacchi nei punti logistici e chi è impiegato nei negozi di distribuzione hanno tutti diritto a un salario dignitoso e a giuste condizioni di lavoro” dichiara Deborah Lucchetti, coordinatrice della Campagna Abiti Puliti. “Oggi uniamo le forze insieme ai delegati italiani dei negozi di H&M per portare le nostre richieste nel cuore di Milano”.
“Il raggiungimento di condizioni normative e salariali sostenibili per tutti i lavoratori che fanno riferimento al brand H&M, diretti ed indiretti, continua a rappresentare una priorità. Partendo dal rispetto degli accordi sottoscritti tra sindacato e multinazionale svedese, è ora necessario affrontare il tema della complessiva qualità occupazionale in H&M, ragionando sempre di più in termini di filiera” continua Jeff Nonato, funzionario nazionale della Filcams CGIL, che coordina l’iniziativa di Milano in collaborazione con la Campagna Abiti Puliti.
Mentre H&M si prepara allo shopping di fine anno, attivisti e lavoratori in tutto il mondo si uniscono per chiedere salari dignitosi e giuste condizioni di lavoro in tutta la catena del gigante svedese della fast fashion. Si tratta della nuova fase della campagna “Turn Around, H&M!”, che dal 23 al 30 novembre cercherà di sensibilizzare ancor più i consumatori sugli impegni mancati di H&M attraverso una serie di azioni di strada. Si inizierà da Londra e Milano e si proseguirà almeno in altre 24 città nei prossimi giorni. In Italia si mobiliteranno anche Bolzano.
La settimana globale di mobilitazione ha luogo intorno al quinto anniversario delle promesse non mantenute fatte da H&M di pagare a 850 mila suoi lavoratori un salario dignitoso. “Tutte le iniziative mirano ad assicurare che H&M non sfugga alla verifica dell’impegno specifico assunto e che non ha evidentemente rispettato, facendo invece affermazioni ingannevoli secondo le quali avrebbe addirittura superato i suoi obiettivi! Chiunque può farlo, se rivendica anche il diritto di modificare l’obiettivo iniziale come meglio crede. Ma non permetteremo che tale ipocrisia passi inosservata”. ha dichiarato Neva Nahtigal dell’ufficio internazionale della Clean Clothes Campaign.
Quest’ultima dimostrazione globale di solidarietà con gli operai che producono gli abiti di H&M segue la pubblicazione dei risultati della ricerca sulla situazione in sei fabbriche che rientrano nell’impegno preso nel 2013 da H&M. “I lavoratori hanno rivelato come H&M non fosse in alcun modo vicina al pagamento dei salari dignitosi promessi nelle sue fabbriche fornitrici – al contrario, molti di loro hanno riportato paghe da fame e violazioni dei loro diritti. Abbiamo buone ragioni per credere che quei risultati rispecchino una realtà più diffusa: H&M ha tratto molto vantaggio dalle sue promesse iniziali in termini di immagine ma non si è curata di trasformarle in realtà” ha dichiarato Bettina Musiolek, coordinatrice della ricerca per conto della della Clean Clothes Campaign.
Oltre al rafforzamento delle connessioni lungo la catena di fornitura, sempre più consumatori esprimono la loro solidarietà con i lavoratori e l’aspettativa che H&M garantisca un salario dignitoso a tutti, senza ulteriori ritardi. La petizione lanciata nell’ambito della campagna “Turn Around, H&M!” ha, infatti, già raccolto oltre 135.000 firme.
Link utili
- Firma la petizione
- L’analisi “A closer look at H&Ms wage data”
- Le richieste della campagna a H&M
- La lettera della lavoratrice del polo logistico H&M di Stradella
- La ricerca Le promesse non bastano, i salari restano di povertà
- Il rapporto Lost and found: H&M’s living wage roadmap
(2018) REPORT - Paghe da fame e violazioni nella catena di H&M
I risultati di una ricerca pubblicata oggi, raccolti nel report “H&M: Le promesse non bastano, I salari restano di povertà”, rivelano come molti lavoratori e lavoratrici che producono abiti per H&M vivano sotto la soglia di povertà, nonostante le promesse dell’azienda di pagare un salario dignitoso entro il 2018 e le recenti ingannevoli dichiarazioni sui progressi raggiunti. I lavoratori intervistati guadagnano in India e Turchia un terzo e in Cambogia meno della metà della soglia stimata di salario dignitoso. In Bulgaria, lo stipendio dei lavoratori intervistati presso un “fornitore d’oro” di H&M non arriva nemmeno al 10% di quello che necessiterebbero per avere vite dignitose.
Uno dei più grandi rivenditori al mondo, con profitti per 2,6 miliardi di dollari, ha una catena di fornitura con lavoratori costretti a ore eccessive di lavoro per pura sopravvivenza.
Straordinari per sopravvivere
“I salari sono così bassi che dobbiamo fare gli straordinari per coprire i nostri bisogni primari” ha raccontato un lavoratore di un “fornitore d’oro” di H&M in India.
Le ore di straordinari in tre delle sei fabbriche coinvolte nell’inchiesta spesso superano il limite massimo legale e lavorare di domenica è frequente in tutti e quattro i paesi in cui si è svolta la ricerca: Bulgaria, Turchia, Cambogia e India. In Bulgaria addirittura i lavoratori hanno raccontato di dover effettuare gli straordinari solo per raggiungere il salario minimo legale.
“Entri in fabbrica alle 8 di mattina, ma non sai mai quando ne uscirai. A volte torniamo a casa alle 4 del mattino seguente” ha rivelato un lavoratore della Koush Moda, “fornitore d’oro” di H&M in Bulgaria.
Svenimenti sul posto di lavoro
Scarsi salari, straordinari eccessivi e l’onere aggiuntivo del lavoro domestico portano a malnutrizione, stanchezza e svenimenti sul posto di lavoro.
Un terzo delle donne intervistate in Indiae due terzi in Cambogia– che lavorano nelle fabbriche classificate da H&M come “fornitori di platino” – sono svenute sul posto di lavoro. Una lavoratrice in India ha raccontato di essere stata accompagnata dai suoi compagni in ospedale per un’emorragia interna dopo che aveva colpito una macchina durante uno svenimento.
Le lavoratrici bulgare parlano degli svenimenti come di eventi quotidiani. Inoltre, una lavoratrice ha denunciato il licenziamento di una compagna dopo uno svenimento.
Il contesto della ricerca
Le interviste ai lavoratori e alle lavoratrici e la fase di analisi sono state condotte tra marzo e giugno 2018 durante la campagna “Turn Around, H&M” coordinata dalla Clean Clothes Campaigne sostenuta dall’International Labor Rights Forume da WeMove.EU.
La campagna è stata lanciata nel maggio 2018quando è diventato evidente che H&M non avrebbe mantenuto l’impegno di “adottare modelli retributivi tali da garantire entro il 2018 la corresponsione di salari dignitosi, un provvedimento che avrebbe interessato a quella data 850.000 lavoratori dell’abbigliamento”. Al tempo dell’annuncio le maestranze interessate fabbricavano il 60% dei prodotti del marchio, alle dipendenze di “fornitori strategici e selezionati” che l’azienda classifica come “gold” o “platinum”. Proprio tra queste sono state scelte le fabbriche in cui realizzare l’inchiesta.
Non ci si può fidare delle parole di H&M
“Sapevamo che H&M non avrebbe mantenuto il suo impegno, ma ciò che abbiamo trovato a livello di salari e di condizioni di lavoro nelle fabbriche della sua catena di fornitura è davvero scioccante. H&M deve intervenire immediatamente per porre fine allo scandalo dei salari da fame e delle violazioni dei diritti dei lavoratori” ha dichiarato Bettina Musiolek della Clean Clothes Campaign,che ha coordinato la ricerca.
“La scorsa settimana H&M ha rilasciato una dichiarazione altisonante, un chiaro tentativo di neutralizzare l’impatto dei risultati che pubblichiamo oggi e che, naturalmente, abbiamo inviato in anticipo all’azienda. Di fatto H&M sta cercando di rimuovere dalla memoria collettiva quegli 850.000 lavoratori cui doveva garantire un salario dignitoso entro il 2018. Ma noi abbiamo la memoria lunga e non lasceremo che ciò accada” ha dichiarato Deborah Lucchetti della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign.
“È ormai del tutto evidente che non ci si può fidare delle parole di H&M. Invece di vuote chiacchiere da pubbliche relazioni, vogliamo vedere cambiamenti reali e trasparenti nelle paghe dei lavoratori. Come abbiamo già scritto ai vertici della società, devono pubblicare una road map con obiettivi di aumento salariale misurabili e a breve termine, dettagliando in che modo l’azienda intenda cambiare le sue pratiche di acquisto per essere sicura che i lavoratori ottengano un salario dignitoso” ha dichiarato Judy Gearhart, direttore esecutivo di ILRF.
I consumatori chiedono di agire
“H&M non può continuare a fingere che le cose stiano migliorando quando i lavoratori sono costretti a fare gli straordinari e ancora vivono in povertà. Questa ricerca mobiliterà migliaia di cittadini preoccupati e consumatori critici che hanno a cuore il rispetto dei diritti umani e il consumo e la produzione sostenibile” ha dichiarato Virginia Lopez di WeMove.EU.
All’interno della campagna “Turn Around, H&M! esiste una petizione per chiedere salari dignitosi e condizioni di lavoro giuste in tutta la catena di fornituradi H&M. Le firme raccolte hanno già superato quota 100mila.
Ali Enterprises: presentato reclamo contro RINA nel sesto anniversario della tragedia
Presentato reclamo contro l’auditor italiano RINA, per aver ignorato irregolarità fatali nella fabbrica di abbigliamento.
Roma, 11 settembre – Oltre 250 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nell’incendio che ha coinvolto la fabbrica tessile Ali Enterprises a Karachi, in Pakistan, l’11 settembre 2012. Solo tre settimane prima, l’auditor italiano RINA Services S.p.a. aveva certificato quella fabbrica per aver rispettato gli standard internazionali del lavoro. Nel sesto anniversario di quella tragedia, una coalizione internazionale di otto organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani, dei lavoratori e dei consumatori ha presentato un reclamo formale presso il Punto di Contatto Nazionale OCSE al Ministero dello Sviluppo Economico contro RINA, l’azienda che avrebbe potuto prevenire la morte di centinaia di persone, se avesse lavorato correttamente.
“Mio figlio è morto nell’incendio insieme a centinaia di persone perché non è riuscito a scappare in tempo dalla fabbrica in fiamme. Non c’era un sistema antincendio funzionante, le uscite di emergenza erano bloccate o inutilizzabili” ha raccontato Saeeda Khatoon, portavoce dell’Associazione vittime dell’incendio della Ali Enterprises.
L’elevato numero di morti di questa tragedia dimostra come il processo di certificazione abbia ignorato i principali problemi di sicurezza. Una simulazione digitale dell’incendio, prodotta dall’agenzia di ricerca Forensic Architecture, con sede a Goldsmiths presso l’Università di Londra, ha mostrato che se le mancanze sugli standard sulla sicurezza fossero state identificate e corrette in tempo, centinaia di vite avrebbero potuto essere salvate.
Responsabile dell’audit e della certificazione della fabbrica era l’azienda italiana RINA che non ha mai visitato la fabbrica, nemmeno attraverso la sua filiale pakistana RI&CA (Regional Inspection & Certification Agency). L’audit non ha evidenziato una serie di infrazioni agli standard internazionali che stava verificando (SA 8000) e alle norme sulla sicurezza pakistane che si sarebbero rivelate fatali, tra cui un pavimento costruito illegalmente, un sistema di allarme antincendio non funzionante, la presenza di lavoro minorile e un sistema strutturale di lavoro straordinario eccessivo. Il rapporto ha anche falsamente certificato la presenza di diverse uscite di emergenza e sufficiente materiale antincendio, quando in realtà le porte erano chiuse, le uscite bloccate e l’unico estintore disponibile non funzionante.
Ben Vanpeperstraete, coordinatore del settore lobby e advocacy della Clean Clothes Campaign ha dichiarato: “È evidente che RINA ha svolto un pessimo lavoro sottoscrivendo un rapporto che ha chiaramente fallito nell’identificare i principali rischi per la sicurezza dei lavoratori. RINA avrebbe dovuto evidenziare le criticità della fabbrica e usare la certificazione SA 8000 come leva per spingere l’azienda a porre rimedio prima di certificarla.”
Deborah Lucchetti, coordinatrice della Campagna Abiti Puliti ha aggiunto: “Il rifiuto di RINA di fornire informazioni rilevanti in nome degli obblighi di riservatezza ha ostacolato il lavoro dei difensori dei diritti umani e delle parti esterne indipendenti impegnate a ricostruire i fatti e a accelerare il processo di risarcimento. Questo caso mostra ancora una volta la necessità di una piena e pubblica trasparenza attraverso la rimozione di qualsiasi ostacolo contrattuale tra le aziende di certificazione e i loro clienti.”
RINA è un’azienda multinazionale con sede in Italia, paese membro dell’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) ed è quindi tenuta ad osservare le Linee guida OSCE per le Imprese Multinazionali. Per questo oggi, una coalizione internazionale di otto organizzazioni dal Pakistan, Germania, Italia e Olanda hanno presentato un reclamo formale al Punto Nazionale di Contatto italiano contro RINA per il rilascio della certificazione SA8000 sulla base di un rapportodi audit carente e scorretto. Le associazioni sollecitano RINA a pubblicare la relazione di audit della Ali Enterprises, a garantire una procedura di audit più trasparente in futuro e che si dimostri responsabile nei confronti dei lavoratori. Inoltre, il reclamo denuncia due difetti generali del sistema di certificazione, sollecitando che gli audit tengano conto del contesto delle pratiche di acquisto dei marchi e includano un sistema di pagamento che eviti l’attuale conflitto di interesse derivante dagli audit di fabbrica pagati dai proprietari delle fabbriche stesse. Il documento vuole mostrare come l’attuale sistema di certificazione legittimi lo sfruttamento e crei false assicurazioni che possono costare la vita: un cambiamento sostanziale è necessario, in merito alla trasparenza, al coinvolgimento dei lavoratori e alla responsabilità delle società di revisione. Infine si chiede che RINA si impegni nel processo di risarcimento.
Carolijn Terwindtdell’European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), organizzazione che ha partecipato alla presentazione di questo reclamo e che sta supportando le vittime pakistane in una causa civile contro il principale acquirente della fabbrica, ha dichiarato: “Il fallimento evidente di RINA nel riconoscere e agire sulle violazioni della sicurezza dei lavoratori nella fabbrica Ali Enterprises mostra ancora una volta l’imperfezione intrinseca dell’attuale sistema di certificazione e la necessità di trasparenza e coinvolgimento dei lavoratori nell’intero processo, se si vuole evitare di continuare a fallire.”
Alessandro Mostaccio, Segretario Generale del Movimento Consumatori, altra organizzazione coinvolta nel reclamo, ha dichiarato: “La certificazione SA 8000 costituisce una garanzia per i consumatori di tutto il mondo nell’acquisto di prodotti sicuri. Rilasciandola alla Ali Enterprises, RINA ha fornito una garanzia ingannevole ai consumatori, gettando una pesante ombra su tutto il sistema di certificazione e la sua capacità di contribuire a rendere l’industria più sicura e giusta. Questa è una violazione del diritto fondamentale dei consumatori a prodotti sicuri, come contemplato dall’articolo 2 del Codice Italiano del Consumo.”
Questo fallimento del sistema di certificazione dimostra l’estrema necessità di meccanismi credibili di prevenzione per la sicurezza nel settore dell’abbigliamento che siano orientati verso la costruzione di capacità pubbliche invece di affidarsi a sistemi paralleli basati sul profitto.

- Leggi l’istanza completa
- Il reclamo OSCE è stato presentato l’11 settembre 2018 al Punto di Contatto Nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI, Divisione VI – Politiche internazionali, promozione della responsabilita sociale d’impresa e del movimento cooperativo
- Le organizzazioni che hanno presentato il reclamo sono: Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association (AEFFAA), National Trade Union Federation (NTUF), Pakistan Institute of Labour Education and Research (PILER), European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Clean Clothes Campaign (CCC), Campagna Abiti Puliti, Movimento Consumatori, medico international
- Il video della simulazione digitale prodotta dal Forensic Architecture è disponibile qui: https://www.forensic-architecture.org/case/outsourcing-risk/
- RINA è anche sotto inchiesta da parte della procura di Genova. Il principale acquirente della fabbrica al momento dell’incendio, l’azienda low cost KIK, sta affrontando una causa legale a Dortmund
- Qualche mese fa la battaglia per i risarcimenti ai familiari delle vittime si è finalmente conclusa. Qui maggiori informazioni:https://www.abitipuliti.org/news/iniziati-finalmente-i-risarcimenti-alle-vittime-dellincendio-alla-ali-enterprises-del-2012/
- Cronologia degli eventi dal 2012 ad oggi: https://cleanclothes.org/safety/ali-enterprises/time-line-for-the-ali-enterprises-case
Iniziati finalmente i risarcimenti alle vittime dell’incendio alla Ali Enterprises del 2012
 Dopo oltre 5 anni di attesa, i sopravvissuti e le famiglie delle vittime dell’incendio del 2012 della fabbrica Ali Enterprises hanno ricevuto le pensioni attraverso un fondo finanziato dal principale marchio acquirente di quella fabbrica, il distributore tedesco KiK. Il processo è stato lungo, ma il risultato è innovativo. Creando un precedente per l’industria tessile globale, le famiglie riceveranno contributi corrispondenti agli standard internazionali stabiliti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).
Dopo oltre 5 anni di attesa, i sopravvissuti e le famiglie delle vittime dell’incendio del 2012 della fabbrica Ali Enterprises hanno ricevuto le pensioni attraverso un fondo finanziato dal principale marchio acquirente di quella fabbrica, il distributore tedesco KiK. Il processo è stato lungo, ma il risultato è innovativo. Creando un precedente per l’industria tessile globale, le famiglie riceveranno contributi corrispondenti agli standard internazionali stabiliti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).
Tutti i beneficiari hanno perso componenti delle loro famiglie o la loro salute nell’incendio mortale che ha coinvolto la fabbrica Ali Enterprises a Karachi, in Pakistan, l’11 settembre 2012, uccidendo più di 250 lavoratori e lavoratrici del tessile. La fabbrica produceva abiti per l’azienda tedesca KiK che ha pagato 1 milione di dollari subito dopo la tragedia per garantire sollievo immediato. Nonostante questo ci sono voluti altri quattro anni di campagne e negoziati prima che l’azienda sottoscrivesse un accordo di risarcimento a lungo termine. Nel settembre 2016, KiK ha accettato di versare 5,15 milioni di dollari nel fondo che deve fornire le pensioni per le famiglie colpite.
Questo accordo è innovativo per molti aspetti. Al contrario di precedenti accordi di risarcimento su larga scala sottoscritti nell’industria del tessile, questo è stato realizzato per garantire pensioni a lungo termine nel pieno rispetto della Convenzione 121 dell’ILO sui benefici per infortuni sul lavoro. Inoltre il processo di preparazione, i calcoli, l’istituzione di un comitato pienamente rappresentativo, il processo distributivo e la ricerca di una soluzione che rispettasse le aspettative nazionali e incontrasse gli standard internazionali hanno rappresentato un lavoro pioneristico, che sfortunatamente ha richiesto un altro anno e mezzo di impegno. Qualche giorno fa, finalmente, la Sindh Employees Social Security Institution ha avviato il pagamento delle pensioni.
Saeeda Khatoon, presidente della Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association, che ha perso un figlio nell’incendio, ha dichiarato: “Il risarcimento a lungo termine garantirà sollievo alle famiglie delle vittime, che stanno attraversando difficoltà insopportabili. Sono grata al Dipartimento pakistano del lavoro, al SESSI e al governo del Sindh per essersi interessati ai nostri casi e reso possibile questo processo”.
Nasir Mansoor, vice segretario generale del National Trade Union Federation Pakistan (NTUF) ha aggiunto: “È un momento storico. Le famiglie vittime di questa tragedia vengono risarcite secondo gli standard dell’ILO. Questo rappresenta un precedente per il futuro. Il supporto internazionale dell’ILO, di IndustriALL e della Clean Clothes Campaign è stato fondamentale per raggiungere il risultato. È ormai tempo di riconoscere e rispettare i diritti fondamentali alla sicurezza e alla salute per i lavoratori pakistani, per prevenire futuri incidenti.”
“Nel frattempo altri lavoratori restano a rischio lavorando in fabbriche ancora insicure. L’incendio della Ali Enterprises è solo uno degli esempi più evidenti del fallimento del sistema privatizzato di ispezione e certificazione sociale usato dalle imprese nel settore della moda” dichiara Deborah Lucchetti della Campagna Abiti Puliti. “La fabbrica, infatti, aveva ricevuto la certificazione SAI8000 solo poche settimane prima dell’incendio dalla società italiana di auditing RINA, che non si è mai fatta carico di alcuna responsabilità per l’accaduto”, conclude Lucchetti.
Karamat Ali, direttore esecutivo del Pakistan Institute of Labour Education and Research ricorda che: “Ora che le famiglie della Ali Enterprises riceveranno finalmente le loro pensioni, è ora di tener conto delle altre lezioni imparate da questa tragedia e guardare al futuro. L’evento mostra dolorosamente l’urgenza di stabilire ispezioni credibili e conformi agli standard internazionali, inserite in un sistema adatto al contesto nazionale”.
Note
- Maggiori informazioni sul processo che ha portato al risarcimento per le famiglie delle vittime della Ali Enterprises sono raccolte cronologicamente sul sito della Campagna Abiti puliti e della Clean Clothes Campaign.
- L’Oversight Committee è composto da rappresentanti dell’ILO, del governo pakistano, dell’associazione delle vittime e delle organizzazioni del lavoro.
- Le pensioni consisteranno in versamenti mensili di 7.545 Rs. per i genitori delle vittime non sposate e lo stesso ammontare per le vedove dei lavoratori defunti con supplementi per i figli a carico.
- Una recente simulazione informaticarealizzata dalla Forensic Architecture su richiesta dell’European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) mostra che con pochi piccoli aggiustamenti si sarebbero potute salvare molte persone, se non tutti i lavoratori presenti nella fabbrica. La simulazione sarà presa in considerazione in una causa avviata da quattro vittime in Germania per il risarcimento del dolore e della sofferenza subiti (non compresi nella Convenzione ILO 121 che si limita a risarcire la perdita di reddito).
La Cambogia intende cancellare le accuse contro l'attivista per i diritti dei lavoratori Tola Moeun
 La scorsa settimana il difensore dei diritti umani e dei lavoratori Tola Moeun ha ricevuto il Labor Rights Defenders Award 2018 per il suo costante impegno a favore dei lavoratori in Cambogia, immersi in un clima di forte repressione che colpisce società civile, sindacati, attivisti, opposizione e media. Il premio è arrivato dodici giorni dopo che il Ministero del Lavoro cambogiano aveva annunciato di aver chiesto ai tribunali di sospendere le accuse penali nei suoi confronti.
La scorsa settimana il difensore dei diritti umani e dei lavoratori Tola Moeun ha ricevuto il Labor Rights Defenders Award 2018 per il suo costante impegno a favore dei lavoratori in Cambogia, immersi in un clima di forte repressione che colpisce società civile, sindacati, attivisti, opposizione e media. Il premio è arrivato dodici giorni dopo che il Ministero del Lavoro cambogiano aveva annunciato di aver chiesto ai tribunali di sospendere le accuse penali nei suoi confronti.
L'annuncio del Ministero è incoraggiante, indica che il governo cambogiano è sensibile alle pressioni internazionali ed è disposto a cambiare il suo approccio repressivo basato su accuse infondate. Il lavoro di Tola è stato fondamentale per affrontare le violazioni nelle catene di fornitura multinazionali e queste accuse hanno gravemente limitato la sua capacità di operare.
Un’accusa preliminare per “violazione della fiducia” è stata formulata lo scorso 18 gennaio dal sostituto procuratore della corte di Phnom Penh nei confronti di tre uomini: Tola Moeun, Pa Nguon Teang (difensore della libertà di stampa) e But Buntenh (monaco attivista). Tutti e tre erano stati membri del comitato funerario dell’attivista assassinato Kem Ley. Il sostituto procuratore ha chiesto per i tre uomini la custodia cautelare ma al momento dell’annuncio nessuno di loro era nel Paese. Se fossero tornati avrebbero rischiato la detenzione preventiva per un periodo indefinito e tre anni di carcere se condannati.
Fin dalla formulazione delle accuse, oltre 100 organizzazioni in tutto il mondo hanno sottoscritto un appello chiedendo al governo cambogiano di rispettare i diritti umani fondamentali e di ritirare immediatamente le accuse nei confronti dei tre uomini. La dichiarazione ha definito il caso emblematico di un più ampio deterioramento del clima lavorativo e dei diritti umani in Cambogia: il governo cambogiano è infatti ritenuto responsabile per la chiusura di una serie di media indipendenti, del National Democratic Institute, lo scioglimento del Cambodia National Rescue Party con l’arresto dei suoi leader con accuse di “tradimento” e la persecuzione giudiziaria di una serie di difensori dei diritti umani e di sindacalisti.
I prossimi giorni sono cruciali per il caso Tola. Fino a quando le accuse non saranno ritirate formalmente, l’attivista rischia il procedimento penale. La decisione verrà probabilmente presa in breve tempo.
La Clean Clothes Campaign ritiene importante continuare a mantenere alta la pressione sul governo fino a quando le accuse non verranno effettivamente ritirate. Inoltre chiede all’Ethical Trading Initiative (ETI), che rappresenta i principali brand attivi in Cambogia, di sostenere questo caso e in generale la difesa dei diritti umani nei suoi rapporti con il governo. Questo tipo di impegno è fondamentale per favorire un cambiamento di atteggiamento da parte del governo cambogiano.
Alcuni giorni dopo l’annuncio del Ministero del Lavoro, l’Unione Europea ha predisposto una missione in Cambogia per monitorare il Generalised Scheme of Preferences, l’accordo commerciale in base al quale le merci cambogiane raggiungono il mercato europeo esenti da dazi doganali. La tempistica di questa missione presenta l'opportunità di avere un impatto su un caso particolarmente grave di uso improprio del sistema della giustizia penale e di restituire un importante difensore dei diritti dei lavoratori alla sua famiglia e alla sua comunità, dove può continuare il suo importantissimo lavoro.
H&M rispetti l’impegno a pagare salari dignitosi
Mentre gli azionisti di H&M si riuniscono a Stoccolma per l’incontro annuale (AGM), la crescente coalizione internazionale che promuove la campagna “Turn Around, H&M!” richiama l’attenzione sul fatto che H&M stia lasciando senza risposte centinaia di migliaia di lavoratori in attesa di ricevere un salario dignitoso.
Nel 2013 H&M annunciava che 850.000 lavoratori avrebbero ricevuto un salario dignitoso entro il 2018. Invece di materializzarsi nelle buste paga dei lavoratori, l’obiettivo stesso è scomparso dalla comunicazione aziendale, proprio come i documenti originali sono scomparsi dal sito web. La comunicazione aziendale di H&M oggi si riferisce solo all’introduzione del metodo del salario equo per le fabbriche dei fornitori. Gli 850.000 lavoratori e i loro redditi effettivi non fanno più parte del messaggio.
La richiesta formale di discutere, durante l’assemblea degli azionisti prevista per domani 8 maggio, dell’impegno assunto dalla multinazionale a garantire il salario dignitoso ai lavoratori tessili della sua filiera, non è stata presa in considerazione. Ciò è avvenuto nonostante H&M abbia beneficiato dell’accoglienza positiva di tale impegno da parte dei media e dei consumatori socialmente consapevoli; il fallimento dell’impegno assunto minerebbe indubbiamente la reputazione di H&M. Si tratta di un tema sensibile su cui gli azionisti dovrebbero generalmente essere prudenti, anche se la società riporta profitti per 2,6 miliardi di dollari, come accaduto nel 2017.
La Clean Clothes Campaign ha ripetutamente, sebbene senza successo, invitato H&M a dichiarare chiaramente il parametro di riferimento per il salario dignitoso e a pubblicare altre informazioni necessarie a condurre una seria valutazione degli sforzi compiuti a riguardo. Dominique Muller di Labour Behind the Label (la Clean Clothes Campaign inglese) dichiara: “Un marchio che dichiara pubblicamente con molto clamore tali impegni e riceve per questo molto credito, deve dimostrare, chiaramente e pubblicamente, progressi misurabili e verificabili verso un cambiamento reale. Quello che H&M ci presenta invece, è un quadro molto vago, opaco e non significativo.”
Una recente dimostrazione sono i dati sui salari per paesi selezionati che H&M ha presentato in aprile. Sono focalizzati sulla differenza tra il salario minimo – che non è mai prossimo ad alcun livello credibile di salario dignitoso – e il salario medio più elevato nelle fabbriche dei fornitori di H&M. Non ci sono informazioni sul fatto che i salari includano vari bonus, ma è molto probabile che sia così. Le ricerche condotte presso i fornitori di H&M in Cambogia hanno rivelato che quasi tutti gli emolumenti, oltre il salario minimo, sono legati a prestazioni particolari come il lavoro straordinario di domenica e nei giorni festivi.
Anannya Bhattacharjee dell’Asia Floor Wage Alliance (AFWA) ha dichiarato: “Sulla base dei miei contatti con i lavoratori penso che le cifre di H&M siano gonfiate e travisate, probabilmente includono pagamenti che non dovrebbero far parte del calcolo del salario“. Bhattacharjee ha anche sottolineato che i sindacati dell’AFWA hanno contattato H&M nel 2016: “L’idea era di incontrarsi e negoziare un accordo per il pagamento progressivo di un salario dignitoso; invece di lavorare su quella proposta, H&M ha scelto di nascondersi dietro esperimenti unilaterali e non trasparenti.”
Se anche prendiamo le cifre pubblicate da H&M come riferimento, è chiaro che i lavoratori portano a casa solo una frazione di ciò che costituirebbe un salario dignitoso. In Cambogia ad esempio, i lavoratori sono pagati in media 166 euro al mese secondo H&M, e questo è superiore al salario minimo nazionale. Tuttavia un salario dignitoso secondo l’AFWA dovrebbe essere di 396 euro al mese. In Indonesia H&M riporta lo stipendio medio mensile di 148 euro mentre la stima fatta da AFWA per un salario dignitoso è pari a 352 dollari. In Bangladesh, la cifra riportata da H&M è di 79 euro al mese mentre un salario dignitoso dovrebbe essere quasi cinque volte più alto (374 euro). A Bangalore, centro dell’industria indiana dell’abbigliamento, i lavoratori portano a casa 111 euro al mese mentre la stima di AFWA è pari a 280 euro. Non c’è da meravigliarsi se molti lavoratori hanno già aderito alla campagna “Turn Around, H&M!“, invitando l’azienda a rispettare gli impegni assunti durante la manifestazione pubblica tenutasi a Bangalore lo scorso 1° maggio.
La situazione non sembra migliore in Europa. “Abbiamo recentemente parlato con un certo numero di lavoratori che producono vestiti per H&M, e senza eccezione, guadagnano molto, molto meno di quello di cui avrebbero bisogno per essere in grado di soddisfare i bisogni primari per se stessi e le loro famiglie e così avere una vita dignitosa“, ha detto Bettina Musiolek, coordinatrice del gruppo dei Paesi produttori europei della Clean Clothes Campaign.
H&M dichiara di rifornirsi da 1.668 fabbriche in tutto il mondo che impiegano oltre 1,6 milioni di persone. Le pratiche commerciali dell’azienda perciò influenzano direttamente moltissime persone.
“Se si considera l’intero processo necessario a produrre un capo di abbigliamento e farlo arrivare al consumatore in negozio o direttamente a casa, stiamo parlando di milioni di persone coinvolte. Mentre la nostra campagna è stata innescata dal fatto che H&M ha voltato le spalle a un impegno esplicito verso 850.000 lavoratori tessili che lavorano per il noto marchio, non dobbiamo dimenticare tutti gli altri lavoratori che vengono sfruttati nella sua catena di fornitura“, ha dichiarato Deborah Lucchetti della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign.
La campagna “Turn Around, H&M!” farà in modo che i tentativi di H&M di allontanarsi dall’impegno originale non passino inosservati. Anche se questo importante tema non è entrato nell’agenda formale della riunione degli azionisti, un gruppo di attivisti si recherà domani a Stoccolma per ricordare a tutti i presenti che un utile di 2,6 miliardi di dollari è più che sufficiente per porre fine allo scandalo dei salari di povertà nella catena di fornitura di H&M. Adesso!
Turn Around, H&M!
Firma la petizione
Per approfondire:
- La campagna “Turn Around, H&M!” ha sito online su turnaroundhm.org ed è presente sui social media con #TurnAroundHM e #LivingWageNow.
- La Clean Clothes Campaign definisce un salario dignitoso come il salario che dovrebbe essere guadagnato in una settimana lavorativa standard (non più di 48 ore) e consentire alla lavoratrice tessile di acquistare cibo per sé e la sua famiglia, pagare l’affitto, pagare per l’assistenza sanitaria, l’abbigliamento, il trasporto e l’istruzione e una piccola quantità di risparmi per gli imprevisti.
- Recenti appelli pubblici da parte di Clean Clothes Campaign verso H&M perché onori il suo impegno:
- Dichiarazione pubblica rilasciata in risposta al rapporto di sostenibilità 2017 di H&M (12 aprile 2018)
- Lettera al Consiglio di amministrazione, al CEO e al responsabile della sostenibilità di H&M (19 marzo 2018)
- Rapporti con informazioni sulle condizioni di lavoro e salari all’interno della catena di approvvigionamento H&M includono:
- Lo compriamo? Un’inchiesta sulla supply chain sugli impegni salariali da parte di M&S e H&M in inglese
- Quando “migliore” è tutt’altro che sufficiente



Rana Plaza 5 anni dopo: i marchi devono firmare il nuovo Accordo
Oggi, a una settimana dal quinto anniversario del crollo del Rana Plaza, la Campagna Abiti Puliti (sezione italiana della Clean Clothes Campaign) e i suoi alleati iniziano una sette giorni di pressione sui marchi internazionali affinché si assumano le loro responsabilità nel garantire fabbriche sicure in Bangladesh firmando l’Accordo di Transizione 2018.
L’Accordo di Transizione 2018 porta avanti il lavoro svolto con l’attuale Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici in Bangladesh sottoscritto nel 2013, a partire dalla scadenza del prossimo maggio, per assicurare la continuità dell’impegno a garantire la sicurezza nelle fabbriche (al 1° marzo l’85% degli interventi riparatori in tema di sicurezza identificati durante le ispezioni iniziali sono stati completati).
L’Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici in Bangladesh fu istituito nel maggio 2013 in risposta al crollo del Rana Plaza e, grazie alle sue ispezioni indipendenti e alla formazione dei lavoratori, ha contribuito in maniera significativa a migliorare la sicurezza delle fabbriche in quel Paese. Un’estensione dell’inziale programma quinquennale è stata già firmata dal oltre 140 marchi, coprendo più di 1.300 fabbriche e circa due milioni di lavoratori. L’obiettivo è di aumentare il numero di operai salvaguardati rispetto al precedente accordo.
Convinta che tutti i lavoratori del tessile e dell’abbigliamento che producono in Bangladesh abbiano il diritto a non temere per le loro vite nei luoghi di lavoro, la Clean Clothes Campaign chiede a tutti i marchi che si riforniscono in quel Paese, e non l’hanno ancora fatto, di sottoscrivere l’Accordo di Transizione 2018.
Innanzitutto stiamo facendo pressione su quei marchi che avevano già sottoscritto il primo Accordo (firmato da oltre 220 aziende) affinché rinnovino il loro impegno. Tra questi ricordiamo il marchio italiano Teddy S.p.A, Abercrombie & Fitch, Sainsbury’s e Gekas Ullared. Per Abercrombie & Fitch è prevista una giornata specifica di mobilitazione di Clean Clothes Campaign, International Labor Rights Forum, United Students Against Sweatshops e altri alleati il prossimo 21 aprile. Sainsbury’s è l’unica ancora reticente tra 6 aziende target di una petizione lanciata da SumofUs lo scorso febbraio.
Poi ci stiamo rivolgendo a quelle aziende che non hanno mai sottoscritto la prima versione dell’Accordo per chiedergli di abbandonare le ispezioni unilaterali aziendali e impegnarsi in un programma ispettivo credibile e trasparente come quello previsto dall’Accordo. Tra queste VF Corporation (The North Face, Timberland, Lee, Wrangler), Gap, Walmart, Decathlon e New Yorker.
Infine, raccogliamo la possibilità offerta dal nuovo Accordo 2018 di includere anche fabbriche che producono accessori tessili, a maglia e in tessuto non necessariamente di abbigliamento. È ad esempio il caso di marchi come IKEA, chiamati ad assumersi anche loro la responsabilità di garantire la sicurezza per i propri lavoratori sfruttando l’opportunità offerta dall’Accordo 2018.
L’Accordo 2018 inoltre, include disposizioni migliorate per il risarcimento per i lavoratori infortunati e riconosce l’importanza della libertà di associazione sindacale nell’assicurare che i lavoratori abbiano voce in capitolo nella protezione della propria sicurezza.
Ma siglare l’Accordo 2018 non è l’unica azione urgente per garantire adeguati e credibili progressi per la sicurezza nelle fabbriche per milioni di lavoratori del settore. Dopo il Rana Plaza si sono verificati nuovi incidenti minori per scala e visibilità che non attenuano la gravità e la sofferenza per le famiglie coinvolte.
“La Campagna Abiti Puliti esprime solidarietà alle famiglie dei numerosi lavoratori che sono morti e sono rimasti feriti in gravi incidenti in incendi, esplosioni, crolli fin dal 2013 che non hanno ricevuto lo stesso livello attenzione e protesta internazionale” dichiara Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti “Pertanto sollecitiamo il governo del Bangladesh, con il sostegno dell’OIL e dei marchi che si riforniscono Bangladesh, a rendere giustizia a tutti i lavoratori colpiti da incidenti sul lavoro attraverso l’istituzione di un sistema nazionale permanente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo gli standard internazionali e a individuare una soluzione transitoria per risarcire i lavoratori vittime degli incidenti passati che attendono da troppo tempo equi risarcimenti basati su un sistema credibile e trasparente”conclude Deborah Lucchetti.
Per spingere i marchi a sottoscrivere il nuovo Accordosaranno organizzati eventi di pressione in tutto il mondo. L’appuntamento in Italia è per il 23 aprile a Torino, presso la Stanza dello Zodiaco del Castello del Valentino alle ore 18,15, quando, insieme a Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti, al giurista Ugo Mattei, alla ricercatricedel Green Team Management del Politecnico di Torino Giulia Sonetti, al direttore Mauro Rossetti con la moderazione Sara Conforti, presidente di hoferlab, attraverso un dibattito pubblico faremo un bilancio trasparente a 5 anni dal Rana Plaza, su cosa è cambiato in Bangladesh e su cosa bisogna ancora mettere in campo per il futuro.
Cosa puoi fare tu
Firma la petizione!
- Chiedi a Sainsbury’s (SumOfUs) di firmare il nuovo accordo
- Chiedi a Abercrombie & Fitch di assumersi le sue responsabilità (ILRF).
- Chiedi a Abercrombie & Fitch di firmare ora (Green America).
Scrivi a Teddy per chiedergli di sbrigarsi e assumersi le sue responsabilità. Mandagli un messaggio su Facebook e su Twitter:
- Teddy non mettere a rischio la vita dei tuoi lavoratori. Firma l’Accordo sul Bangladesh 2018. Ora! #workersafety
Scrivi a Abercrombie & Fitch per chiedergli di sbrigarsi e assumersi le sue responsabilità. Mandagli un messaggio su Facebook e su Twitter:
- Abercrombie non mettere a rischio la vita dei tuoi lavoratori. Firma l’Accordo sul Bangladesh 2018. Ora! #RanaPlazaNeverAgain
Scrivi a IKEA per chiedergli di sbrigarsi e assumersi le sue responsabilità. Mandagli un messaggio su Facebook e su Twitter:
- IKEA assumiti le tue responsabilità. Firma l’Accordo sul Bangladesh 2018. Ora! #RanaPlazaNeverAgain
Scrivi a the North Face per chiedergli di sbrigarsi e assumersi le sue responsabilità. Mandagli un messaggio su Facebook e su Twitter:
- The North Face ai lavoratori che producono i tuoi abiti hanno bisogno di fabbriche sicure. Firma l’Accordo sul Bangladesh 2018. Ora! #RanaPlazaNeverAgain
Controlla la lista dei marchi firmatari e vedi se il tuo marchio preferito ha già sottoscritto l’Accordo 2018. No? Digli attraverso i social media di farlo subito!
- [@NomeMarchio] Rispetta i lavoratori. Non mettere a rischio le loro vite. Firma subito l’Accordo per il Bangladesh 2018 #workersafety

Notizie Utili
- I tecnici dell’Accordo hanno ispezionato più di 1.900 fabbriche di abbigliamento bengalesi fornitrici dei marchi che lo hanno sottoscritto.
- 97000 rischi per incendi, problemi elettrici e strutturali sono stati corretti.
- l’Accordo ha risolto 183 reclami formulati dai lavoratori.
- Nel gennaio 2018 IndustriALL e UNI hanno raggiunto un accordo, nell’ambito del meccanismo legalmente vincolante dell’Accordo, un impegno a pagare 2,3 milioni di dollari da parte di marchio internazionale da destinare alla messa in sicurezza di più di 150 fabbriche sue fornitrici. Questo, dopo un altro accordo di successo con un marchio globale inadempiente, presso il tribunale arbitrale dell’Aia nel dicembre 2017.
- L’Accordo di Transizione 2018, lanciato nel giugno 2017, ha già raccolto le firme di oltre 140 marchi. Estende le protezioni previste dal primo accordo fino a maggio 2021, a meno che le condizioni per un passaggio a un organismo di regolamentazione nazionale non vengano soddisfatte prima.
- Documento di approfondimento “Cinque anni dopo il crollo del Rana Plaza: cosa è successo nel campo della prevenzione e dell’accesso alla giustizia per le vittime?“ a cura della Campagna Abiti Puliti.

EVENTO: Rana Plaza + 5 / Cosa è cambiato in Bangladesh e nella moda?
23 aprile ore 18.15
Stanza dello Zodiaco
Castello del Valentino • TORINO
IL 24.04.13 A DACCA IN BANGLADESH PERSERO LA VITA ALMENO 1.134 LAVORATORI E PIÙ DI 2.000 RIMASERO FERITI MENTRE CUCIVANO ABITI DESTINATI AI NEGOZI DI TUTTO IL MONDO.
Poche ore dopo, coraggiosi attivisti e attiviste per i diritti umani scavavano a mani nude sotto le macerie per trovare le prove che collegavano quelle fabbriche a noti marchi occidentali, i veri datori di lavoro di quei lavoratori che non sono più tornati a casa.
UN BILANCIO TRASPARENTE A 5 ANNI DAL RANA PLAZA
MODERA
- Sara Conforti – presidente hoferlab
INTERVENGONO
- Deborah Lucchetti – portavoce Campagna Abiti Puliti
- Ugo Mattei – Giurista, docente Università di Torino e Hastings College of Law California, Coordinatore accademico IUC di Torino
- Mauro Rossetti – direttore Associazione Tessile e Salute
CONCLUDE
- Giulia Sonetti – Polito Green Team Management Interuniversity Department of Regional & Urban Studies and Planning
A SEGUIRE CONFRONTO CON IL PUBBLICO

Cresce la mobilitazione per sostenere Tola Moeun
 Dalla pubblicazione di una lettera rivolta al governo della Cambogia, oltre 100 organizzazioni hanno aderito alla richiesta di porre fine al processo politico di Tola Moeun, difensore dei diritti umani cambogiano.
Dalla pubblicazione di una lettera rivolta al governo della Cambogia, oltre 100 organizzazioni hanno aderito alla richiesta di porre fine al processo politico di Tola Moeun, difensore dei diritti umani cambogiano.
La lettera era stata scritta e firmata da quattro sindacati globali e oltre 30 organizzazioni nazionali e internazionali impegnate nella difesa dei diritti dei lavoratori, dopo che i pubblici ministeri in Cambogia avevano rivolto accuse penali e un ordine di detenzione preventiva nei confronti di Tola e altri due importanti leader della società civile: Pa Nguon Teang, difensore della libertà di stampa, e Venerable But Buntenh, monaco attivista. Le accuse, come spiegato nella lettera, sono infondate e sembrano essere mosse da motivazioni politiche.
Tola è il Direttore Esecutivo del Center for the Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL) e un noto difensore dei diritti dei lavoratori in Cambogia.
Da quando la lettera è diventata pubblica lo scorso 19 febbraio, oltre 50 organizzazioni, tra cui Amnesty International, in tutto il mondo l’hanno sottoscritta manifestando il loro sostegno e chiedendo al governo cambogiano di rispettare i diritti umani fondamentali ritirando immediatamente le accuse a carico di Tola e dei due attivisti.
È noto che i tribunali cambogiani non siano indipendenti ma guidati dagli interessi politici del partito di governo Cambodian People’s Party. Queste accuse costituiscono un tentativo di silenziare e punire una delle voci indipendenti del paese per i diritti dei lavoratori.
“Guardare le autorità cambogiane che si concentrano senza sosta su un famoso attivista per i diritti dei lavoratori che ha facilitato l'accesso ai risarcimenti per i lavoratori dell'abbigliamento prima del Consiglio di Arbitrato del Paese dovrebbe allarmare i marchi internazionali che conoscono i costi per scongiurare le situazioni di crisi" ha dichiarato Aruna Kashyap, consigliere senior della divisione diritti di genere di Human Rights Watch. "I marchi che tacciono dovrebbero avere chiaro che ogni iniziativa, eventualmente pianificata in Cambogia, rischia di fallire o ridicolizzarsi, se la società civile è confinata in carcere o perseguitata dalle autorità cambogiane. Inoltre questo non farà che aumentare il livello degli abusi sui lavoratori nelle catene di fornitura, compromettendo la possibilità stessa per i lavoratori di risolvere le loro controversie in modo costruttivo”
“Tutto questo fa parte della repressione in corso, non solo contro i difensori dei diritti umani critici del regime di Hun Sen ma anche contro il movimento sindacale nazionale. Questo governo ha introdotto e attuato la legge sindacale che rende impossibile organizzarsi e contrattare collettivamente. Se è rimasto un senso di decenza, è il caso che si intervenga” ha dichiarato Apolinar Z. Tolentino, rappresentante regionale per l’Asia e il Pacifico dei Building e Wood Workers.
La Campagna Abiti Puliti si unisce alle richieste della società civile internazionale nel richiedere al governo cambogiano di rispettare i diritti umani fondamentali e di ritirare immediatamente le accuse nei confronti di Tola e degli altri due leader. Inoltre esprime solidarietà e sostegno alle 35 organizzazioni per i diritti umani cambogiane che hanno già espresso simili preoccupazioni.
Bangladesh: 100 giorni alla scadenza dell’Accordo. I firmatari invitano i marchi a sottoscrivere il nuovo Accordo 2018
 A 100 giorni dalla scadenza dell’Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici in Bangladesh, le aziende dell’abbigliamento sono chiamate a continuare il loro impegno per rendere l’industria tessile sicura e sostenibile sottoscrivendo l’Accordo di Transizione 2018.
A 100 giorni dalla scadenza dell’Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici in Bangladesh, le aziende dell’abbigliamento sono chiamate a continuare il loro impegno per rendere l’industria tessile sicura e sostenibile sottoscrivendo l’Accordo di Transizione 2018.
Questo Accordo continuerà il lavoro ispettivo nelle fabbriche del Bangladesh, identificando i rischi per la sicurezza e assicurandosi che vengano corretti. Ad oggi 109 aziende del tessile hanno già firmato questo nuovo Accordo, coprendo oltre 2 milioni di lavoratori.
Tuttavia molte aziende, tra cui Marks and Spencer, Next, Sainsbury’s, Metro Group, Abercrombie & Fitch e Dansk Supermarked, non hanno ancora riconfermato il loro impegno.
I sindacati globali (IndustriALL e UNI) e le quattro organizzazioni testimoni (Clean Clothes Campaign, International Labor Rights Forum, Maquila Solidarity Network e Worker Rights Consortium) firmatari dell’Accordo chiedono a queste aziende di impegnarsi il prima possibile.
“Non firmando l’Accordo 2018, tra 100 giorni i lavoratori saranno lasciati in fabbriche non monitorate. Di conseguenza, i marchi della moda verranno meno ai loro obblighi di due diligence per garantire ai lavoratori delle proprie catene di fornitura la giusta sicurezza” ha dichiarato Ineke Zeldenrust, coordinatrice internazionale della Clean Clothes Campaign.
L’Accordo originario è entrato in vigore nel maggio 2013, in seguito alla tragedia del Rana Plaza accaduta nell’aprile 2013, quando 1134 lavoratori e lavoratrici persero la vita. L’Accordo ha creato un sistema realistico per monitorare e correggere le storture delle fabbriche delle catene di fornitura dei marchi firmatari, insieme a un programma di formazione sulla sicurezza per i lavoratori. Un lavoro che continuerà in virtù dell’Accordo 2018.
“Non esiste un’alternativa credibile all’Accordo per garantire la sicurezza dei lavoratori in Bangladesh. Non è possibile tornare indietro ai programmi gestiti dalle aziende visto che si sono dimostrati del tutto fallimentari nel prevenire tragedie immani. Firmare l’Accordo 2018 è l’unica strada per le aziende per rispettare i loro obblighi di due diligence nei confronti dei lavoratori” ha dichiarato Jenny Holdcroft, assistente del segretario generale di IndustiALL
È altrettanto importante per quelle aziende che non avevano sottoscritto il primo Accordo, così come per quelle che hanno già posto rimedio ai difetti riscontrati nelle loro fabbriche grazie al primo Accordo.
“La necessità di comitati per la sicurezza e di un programma di ispezione in corso è sempre valida perché una fabbrica può essere sicura un giorno e poi avere le porte antincendio bloccate il giorno dopo. Finché il governo del Bangladesh non sarà pronto ad assumersi questa responsabilità, l’Accordo continuerà a fornire formazione, competenze ingegneristiche e strutture di monitoraggio per rendere sicure le fabbriche”, ha dichiarato Christy Hoffman, vice segretario generale di UNI global union.
Questo appello a sottoscrivere l’Accordo 2018 è rivolto anche alle aziende non firmatarie della prima versione come quelle dell’Alleanza per la sicurezza dei lavoratori in Bangladesh, un programma di sicurezza gestito dalle aziende stesse.
“Chiediamo alle aziende dell’Alleanza e a quelle che non hanno mai sottoscritto alcun programma di firmare l’Accordo 2018 il prima possibile mostrando la loro volontà nel garantire la sicurezza nelle fabbriche del Bangladesh insieme ai sindacati bengalesi e internazionali” ha dichiarato Judy Gearhart, direttore esecutivo dell’International Labor Rights Forum.
(2018) REPORT - Lavoro senza libertà - Lavoratrici migranti nell’industria tessile di Bangalore
Le donne migranti impiegate nelle fabbriche tessili indiane che riforniscono i grandi marchi internazionali della moda come Benetton, C&A, GAP, H&M, Levi’s, M&S e PVH, sono soggette a condizioni di moderna schiavitù. A Bangalore, il più grande centro di produzione di abbigliamento in India, giovani donne, reclutate con false promesse di salari e benefici economici, lavorano sotto pressione per paghe da fame. Le loro condizioni di vita negli ostelli sono precarie e la loro libertà di movimento è severamente limitata. Nonostante si dichiarino almeno diciottenni, molte di loro sembrano molto più giovani.
Queste sono alcune delle condizioni riportate nel report “Lavoro senza Libertà – Lavoratrici migranti nell’industria tessile di Bangalore”, curato dall’organizzazione per i diritti umani India Committee of the Netherlands, la Clean Clothes Campaign e il sindacato femminile di Bangalore Garment Labour Union. La ricerca ha riscontrato che 5 degli 11 indicatori dell’ILO per identificare il lavoro forzato sono presenti nelle fabbriche di Bangalore: abuso di vulnerabilità, inganno con false promesse (ad esempio sui salari), limitazione dei movimenti nelle abitazioni, intimidazioni e minacce, condizioni di lavoro e di vita inumane
70 mila persone chiedono ad Armani e Primark di rivelare dove vengono prodotti i loro abiti
Circa 70mila persone chiedono ad alcuni fra i maggiori marchi e distributori della moda (Armani, Primark, Urban Outfitters, Forever 21 e Walmart) di fare della trasparenza uno dei loro buoni propositi dell’anno nuovo e rendere pubbliche le informazioni sulle fabbriche che producono i loro abiti. Durante il mese di gennaio, attivisti in tutta Europa e nel mondo consegneranno le firme raccolte con la petizione sulla trasparenza ai i marchi coinvolti.
La consegna delle firme è l’ultimo passo, in ordine cronologico, della campagna globale #GoTransparent, portata avanti da Human Rights Watch, Clean Clothes Campaign e International Labor Rights Forum. Con questa campagna le organizzazioni hanno fissato uno standard minimo di trasparenza per il settore tessile, l’Iniziativa per la trasparenza nella catena di fornitura dell’abbigliamento e delle calzature, convincendo 17 marchi ad impegnarsi a pubblicare le informazioni sulle fabbriche da cui si riforniscono, compresi indirizzi e numeri di lavoratori impiegati.
La campagna #GoTransparent era indirizzata in modo specifico a cinque marchi, Armani, Primark, Urban Outfitters, Forever 21 e Walmart, considerati tra i più reticenti a svelare le informazioni sulle loro catene di fornitura e che si sono rifiutati di seguire l’esempio degli altri brand di impegnarsi a rendere più trasparenti le loro filiere.
Le informazioni richieste dall’Iniziativa per la Trasparenza sono fondamentali per i lavoratori e gli attivisti per poter allertare i marchi di eventuali violazioni dei diritti lungo la catena di fornitura. Si potrebbero, ad esempio, evitare scene drammatiche come quelle seguite al crollo del Rana Plaza, quando attivisti e lavoratori rischiando la propria vita sono dovuti rientrare tra le macerie per cercare le etichette dei marchi responsabili.
Tra l’altro questi cinque marchi sembrano non essere al passo con i tempi: già dieci anni fa, alcune università negli Stati Uniti avevano iniziato a richiedere maggiore trasparenza alle aziende che producevano le loro divise. Più recentemente, molti marchi internazionali hanno iniziato a fare passi avanti in questo senso. Altri nel 2017 hanno deciso di passare dalla mancanza totale di trasparenza al pieno rispetto delle richieste contenute nell’Iniziativa (tra questi ASICS, ASOS, Clarks, New Look, Next e i Pentland Brands). ASOS, dopo aver aderito, ha dichiarato: “Tutte le strade portano alla trasparenza. Se le nostre pratiche nel settore della moda non sono abbastanza buone da poterle raccontare ai nostri consumatori, allora semplicemente non sono buone a sufficienza”.
Deborah Lucchetti della Campagna Abiti Puliti ha dichiarato: “Qualsiasi marchio si rifiuti di condividere informazioni sulla propria catena di fornitura dovrebbe far scattare un allarme rosso nei consumatori e in tutti coloro che hanno a cuore i diritti umani. Che cosa c’è da nascondere? Le imprese committenti conoscono la provenienza dei loro prodotti e monitorano le loro catene di fornitura? Se i marchi stanno realmente compiendo passi avanti verso la trasparenza, dovrebbero essere desiderosi di comunicarlo ai propri consumatori”.
Di questi temi si discuterà a Firenze il prossimo 10 gennaio dalle 9.30 alle 14 durante l’evento “La filiera trasparente nel settore della moda” promosso dalla Campagna Abiti Puliti (sezione italiana della Clean Clothes Campaign) e dalla FILCTEM CGIL, con il patrocinio della Regione Toscana. Oltre agli organizzatori, parteciperanno alla discussione rappresentanti dell’industria del settore e delle istituzioni. Per il programma completo dell’evento: https://www.abitipuliti.org/news/la-filiera-trasparente-nel-settore-moda/
Elenco delle firme
Background:
L’attuale slancio verso la trasparenza della catena di approvvigionamento è ripreso da importanti iniziative internazionali, come la mozione prodotta dal Parlamento Europeo in Aprile 2017, l’Iniziativa faro nell’industria dell’abbigliamento, che richiede catene di approvvigionamento trasparenti e due diligence. Sempre nell’aprile 2017, 79 organizzazioni europee della società civile hanno rivolto un appello alla Commissione Europea. Inoltre, i marchi di calzature erano già stati sollecitati a mostrare maggiore trasparenza attraverso una petizione di Change Your Shoes, iniziativa promossa da diverse organizzazioni per i diritti dei lavoratori in Europa e in Asia (in Italia dalla Campagna Abiti Puliti).
Note per l’editore:
- La consegna delle firme è ad oggi programmata in diverse città, tra cui Amsterdam (Primark, Armani), Antwerp (Armani, Urban Outfitters), Brussels (Primark) e Zagabria (Armani).
- Il testo della petizione rivolta a Walmart, Urban Outfitters, Forever 21, Armani e Primark è qui org/gotransparent.
- Il Rapporto Segui il il filo che ha lanciato la petizione ad Aprile 2017
- La coalizione che ha lanciato l’iniziativa per la Trasparenza è composta da Human Rights Watch, Clean Clothes Campaign, International Corporate Accountability Roundtable, International Labour Rights Forum, Workers Rights Consortium, Maquila Solidarity Network, IndustriALL Global Union, UNI Global Union International Trade Union Confederation. La coalizione di organizzazioni per i diritti umani, del lavoro e i sindacati che hanno promosso l’iniziativa sta attualmente verificando le risposte dei marchi e il rispetto degli impegni assunti
Consegna delle firme ad Armani a Hong Kong
(2017) REPORT - Guarda dove metti i piedi! Nuovo rapporto sulle concerie della pelle
Oggi la Campagna Abiti Puliti, nell’ambito dell’iniziativa Change your shoes, lancia il nuovo report “Guarda dove metti i piedi”. Attraverso un’approfondita ricerca sul campo condotta negli stati federali di Tamil Nadu e Uttar Pradesh in India, lo studio analizza le dannose condizioni ambientali e di lavoro nelle concerie della pelle. Le due regioni, che ospitano varie concerie, centri di produzione ed esportazione di pelle anche verso l’Unione Europea, sono caratterizzate da livelli anormali di inquinamento idrico e del suolo, danni ambientali e rischi sanitari per i lavoratori e le comunità circostanti. La ricerca ha evidenziato come tali problemi derivino da un trattamento incauto di acque reflue e rifiuti solidi derivanti dal processo di concia.
Il rischio più significativo è legato all’uso del Cromo III che in determinate circostanze può trasformarsi nel più tossico e cancerogeno Cromo VI (CrVI) e diventare una seria minaccia per i lavoratori e le lavoratrici. La ricerca sul campo ha rivelato che i rifiuti solidi e le acque reflue non trattate contenenti Cr (VI) sono spesso abbandonati su terreni aperti, contaminando per decenni i corpi idrici circostanti, compresa l’acqua potabile. Inoltre, l’acqua di irrigazione ricca di Cr (VI) e i fanghi di depurazione hanno danneggiato i terreni e le coltivazioni che circondano le concerie, mettendo così a rischio la sopravvivenza dell’intera popolazione rurale.
L’osservazione sul campo e le interviste ai lavoratori delle concerie indicano poi una serie di problemi per la salute e la sicurezza sul lavoro. La maggior parte degli operai e delle operaie ha raccontato di soffrire di diversi disturbi come febbre cronica, problemi respiratori e irritazione agli occhi e alla pelle causati dal contatto diretto con agenti chimici della concia. Ciò potrebbe essere ricondotto all’insufficienza di equipaggiamento protettivo adeguato e di formazione specifica sulla sicurezza. A questo si aggiungono condizioni di lavoro estremamente precarie, salari da fame, contratti di lavoro irregolari e assenza di protezione assicurative sociali e per la salute. Questa combinazione tra malattie e insicurezza finanziaria costringe molti degli intervistati a una battaglia quotidiana per la sopravvivenza.
Nonostante l’India sia dotata di una regolamentazione e di norme stringenti in materia ambientale e di diritto del lavoro, compreso il settore delle concerie, “l’implementazione di queste regole è scarsa o del tutto assente, soprattutto in contesti informali o parzialmente illegali” come ricorda Pradeepan Ravi del Cividep. A ciò si aggiunge la mancanza di trasparenza che caratterizza tutto questo livello della catena di fornitura. “Questo è il punto su cui possono giocare un ruolo determinante i marchi nazionali e internazionali, responsabili tra le altre cose del rispetto dei diritti umani e degli standard ambientali” dichiara Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti, rappresentante italiana di Change Your Shoes. “In linea con i Principi Guida per le imprese e i diritti umani delle Nazioni Unite (UNGPs), i marchi dovrebbero stabilire una strategia di due diligence con mappe e analisi dell’intera catena di fornitura, in modo da identificare e intervenire sui rischi per gli esseri umani e per l’ambiente a ogni livello. Azioni concrete dovrebbero poi essere intraprese in accordo con le organizzazioni della società civile, i sindacati e gli altri attori significativi”.
Per questi motivi la rete degli attivisti che ha promosso Change Your Shoes chiede alle autorità indiane di rafforzare e implementare in maniera rigorosa le norme esistenti e agli stati membri dell’Unione Europea di predisporre un accordo legalmente vincolante che obblighi le aziende a mettere in pratica la due diligence in linea con gli UNGPs.
Questo nuovo rapporto rappresenta un ulteriore passo per far luce sul lato oscuro della produzione globale di pelle riguardo i rischi ambientali e per i diritti umani e completa il quadro delle indagini sinora svolte in diversi paesi e segmenti delle filiere delle calzature. Tali ricerche tracciano la rotta di catene di fornitura globali di cui l’Italla è parte integrante sia come sito produttivo che come mercato di consumo.
MATERIALI
Scarica il FACTSHEET (Italiano)
Scarica il report completo (inglese)
Leggi anche
(2017) REPORT – Il vero costo delle nostre scarpe
(2015) REPORT – Una dura storia di cuoio
Diteci chi fabbrica le nostre scarpe! La consegna della petizione sulla trasparenza
13.606 persone hanno chiesto ai marchi europei delle calzature di fare un passo avanti, comunicare chi produce le loro scarpe e cessare di mettere a rischio la vita dei loro lavoratori e lavoratrici.
La petizione era rivolta a 26 marchi europei ed è stata sottoscritta da migliaia di cittadini preoccupati che le loro scarpe siano prodotte da persone che non rischiano la loro vita ogni volta che si recano sul posto di lavoro.
24 miliardi di scarpe sono prodotte ogni anno – 3 paia per ogni persona del pianeta. L’87% di queste viene realizzato in Asia, dove milioni di donne cuciono scarpe a casa loro sopportando paghe da fame, problemi di salute e condizioni di lavoro insicure. Nelle concerie, l’uso non regolamentato di sostanze chimiche tossiche e di coloranti espone i lavoratori al Cromo VI – prodotto nel processo di concia delle pelli – col rischio di causare asma, eczema, cecità e cancro. Quando questa sostanza entra poi in contatto con le acque reflue provoca inquinamento dannoso per l’ambiente e per coloro che vivono e lavorano nelle vicinanze.
La crescente domanda in Europa e la competizione tra i marchi per fornire prodotti sempre più economici e in tempi sempre più rapidi significa, in particolare per i lavoratori e le lavoratrici in Asia e in Est Europa, essere sotto pressione per produrre sempre più, spesso attraverso straordinari non pagati e sotto minaccia di licenziamento e intimidazione, se provano ad alzare la voce per chiedere più diritti. Queste condizioni di lavoro per noi consumatori restano nascoste, visto che i marchi tengono segrete le loro catene di produzione.
Ma ora i cittadini europei stanno sollevando questi problemi e vogliono essere sicuri che le loro scarpe non stiano causando danni all’ambiente e alle persone. Migliaia di persone chiedono ai marchi di pubblicare le informazioni sulla realizzazione delle loro scarpe, di smettere di usare sostanze tossiche durante la produzione e di garantire un salario vivibile e condizioni di lavoro dignitose ai loro operai e operaie.
In Germania le firme raccolte sono state consegnate a Deichmann la quale ha dichiarato che lavorerà per migliorare la situazione per i lavoratori lungo la sua catena di fornitura. In Polonia sono state consegnate a CCC, la più grande azienda del Paese. CCC ha replicato che assumerà passi concreti per monitorare la catena di fornitura e avvierà un dialogo con i lavoratori e le organizzazioni della società civile. In Italia la petizione è stata consegnata a Prada che finora non ha fornito alcuna risposta in merito alle diverse richieste di trasparenza. In Spagna le firme sono arrivate a Camper che ha appena iniziato a pubblicare alcune informazioni sulla sua catena di fornitura. In Inghilterra la petizione è stata consegnata a 11 marchi tra cui Schuh, che si è detta disponibile a considerare le raccomandazioni per migliorare la situazione.
Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti ha dichiarato: “La crescente richiesta di trasparenza non può essere ignorata. Una petizione parallela indirizzata a 5 marchi globali dell’abbigliamento e delle calzature sullo stesso tema ha raccolto oltre 70 mila firme. Come risultato di questa pressione pubblica alcuni grandi marchi, tra cui Clarks, hanno accettato di pubblicare la lista dei loro fornitori. Tuttavia troppi marchi ancora dimostrano di non essere per nulla interessati a parlare delle condizioni di lavoro nelle loro filiere produttive e molta strada resta da fare per garantire un trattamento equo per i loro lavoratori. Allo stesso tempo è promettente che alcuni grandi marchi stiano cambiando atteggiamento e riconoscano che l’unica soluzione è ascoltare le preoccupazioni dei consumatori e le esigenze dei lavoratori, mostrandosi disponibili ad assumersi le loro responsabilità. Continueremo a lavorare con i brand della moda per migliorare la trasparenza delle loro catene di fornitura e le condizioni dei loro lavoratori. E ci auguriamo che anche i grandi brand italiani, come Prada, rispondano alle richieste di migliaia di persone e accettino la sfida della trasparenza”
La coalizione Change your shoes ha presentato la petizione anche ai Membri del Parlamento Europeo a Bruxelles lo scorso 20 novembre mostrando l’esistenza di una forte pressione pubblica per cambiare l’industria calzaturiera e chiedendo all’Europa di rendere obbligatoria per le aziende la pubblicazione dei nomi e degli indirizzi dei loro fornitori.
Scarica il fumetto che racconta la consegna a Prada
Scarica l’elenco delle firme raccolte
H&M manterrà la promessa di pagare un salario dignitoso entro il 2018?
Quattro anni fa, H&M aveva fatto una promessa che, se mantenuta, avrebbe costituito un punto di svolta per l’intera industria dell’abbigliamento. Il 25 novembre 2013 H&M, infatti, aveva promesso che avrebbe pagato quello che loro stessi chiamavano un “salario dignitoso equo” ai lavoratori della sua catena di fornitura entro il 2018.
Il pagamento di un salario dignitoso da parte di H&M ai suoi lavoratori costituirebbe uno sviluppo rivoluzionario, considerando che i salari da fame rappresentano tutt’ora la norma in tutto il settore, compresa la catena di fornitura di H&M. Sono paghe ben distanti da quello che dovrebbe essere un salario dignitoso: un salario, cioè, che dovrebbe consentire al lavoratore e alla sua famiglia di condurre una vita decente, avere una dieta sana, un alloggio adeguato, accesso alle cure mediche, all’istruzione e ai trasporti, nonché una somma aggiuntiva da poter usare in caso di imprevisti.
Durante gli ultimi cinque anni da quell’annuncio, H&M si è dimostrata particolarmente opaca circa i suoi piani tanto da far pensare fosse solo uno spot pubblicitario per placare l’opinione pubblica preoccupata dalle sue condizioni di produzione.
Attualmente, i salari medi delle fabbriche dei fornitori di H&M in Bangladesh, Myanmar, Cambogia e India sono solo leggermente superiori ai salari minimi nazionali. In Bangladesh, per esempio, H&M sostiene che i lavoratori della sua catena di fornitura guadagnano in media 87 dollari al mese, che è addirittura inferiore alla soglia di povertà stabilita della Banca Mondiale di 88 dollari al mese. L’effetto è che i lavoratori e i loro figli soffrono di malnutrizione. Le stime di quanto dovrebbe essere il salario dignitoso variano, ma in media indicano tutte che in Bangladesh dovrebbe essere di almeno il triplo per garantire una vita dignitosa. La terribile situazione dei lavoratori di H&M è apparsa ancora più chiara quando migliaia di loro sono scesi in piazza nel dicembre 2016 per chiedere aumenti salariali.
Il salario minimo nei paesi di produzione tessile è stabilito dai governi a livello nazionale. Ma questi governi, per paura di perdere commesse importanti per la loro economia nazionale, si dimostrano particolarmente restii nell’accordare aumenti, alimentando una gara al ribasso per i salari di tutti i lavoratori e le lavoratrici.
In realtà, secondo la Clean Clothes Campaign, i marchi potrebbero influenzare queste politiche salariali, rassicurando i governi che aumenti del salario minimo legale non determinerebbero la loro fuga e che invece continuerebbero a investire in relazioni commerciali di lungo periodo e a commissionare ordini anche se i prezzi dovessero salire. I marchi potrebbero assumendosi la responsabilità per salari dignitosi attraverso pagamenti diretti inclusi negli ordini alle fabbriche dei loro fornitori. Essendo uno degli attori più importanti per le esportazioni dal Bangladesh, H&M potrebbe avere un’influenza determinante per i salari di milioni di lavoratori nel paese.
Invece, dopo aver alzato un gran polverone con le sue dichiarazioni, H&M ha riformulato la sua promessa rendendola molto meno ambiziosa. Invece di corrispondere direttamente a tutti i lavoratori della sua catena di fornitura un salario dignitoso, il brand ha precisato che avrebbe solo messo in moto dei “meccanismi” che avrebbero permesso di raggiungere il salario dignitoso per almeno l’80% dei suoi lavoratori e lavoratrici. Come abbia intenzione di fare e quali progetti pilota voglia implementare però non è dato sapersi. Questo impedisce ai lavoratori e alle loro organizzazioni di monitorare i progressi.
L’obiettivo che H&M si era data nel 2013, cioè di pagare un salario dignitoso agli 850 mila lavoratori e lavoratrici della sua catena di fornitura, sebbene ambizioso, è sicuramente raggiungibile per un’azienda delle dimensioni, profitti e potere di H&M. Ad esempio, il suo stesso presidente Stefan Persson potrebbe facilmente garantire ai lavoratori di H&M un aumento sulle loro retribuzioni fino a quando l’azienda abbia raggiunto il suo obiettivo. Oggi infatti, egli possiede un patrimonio di 19,9 miliardi di dollari che sarebbe sufficiente a pagare a tutti i lavoratori della sua filiera in Bangladesh un salario dignitoso pieno per i prossimi trent’anni.
H&M ha sicuramente le risorse per imprimere un importante cambiamento e ha più volte sostenuto di essere un’azienda leader su questi temi. Dando un’occhiata ai numeri, ci si rende conto che se H&M riallocasse il budget che in un solo anno spende in pubblicità a favore dei salari, potrebbe garantire ai suoi lavoratori in Cambogia 6,5 anni di salario dignitoso.
Il profitto netto di H&M nel 2016 è stato di oltre 2 miliardi di dollari. Basterebbe solo l’1,9% di questa cifra per pagare a tutti i suoi lavoratori in Cambogia i 78 dollari aggiuntivi al mese per garantirgli di vivere con dignità.
(2017) REPORT - Europe's sweatshop - L'Europa dello sfruttamento
Un nuovo rapporto della Clean Clothes Campaign rivela condizioni di grave sfruttamento nella produzione di abbigliamento e calzature “Made in Europe”
Un nuovo rapporto della Clean Clothes Campaign, Europe’s Sweatshops, documenta i salari da fame endemici e le dure condizioni di lavoro nell’industria tessile e calzaturiera dell’Est e Sud-Est Europa. Ad esempio, molti lavoratori in Ucraina, nonostante gli straordinari, guadagnano appena 89 euro al mese in un Paese in cui il salario dignitoso dovrebbe essere almeno 5 volte tanto. Tra i clienti di queste fabbriche ci sono marchi globali come Benetton, Esprit, GEOX, Triumph e Vera Moda.
Per questi marchi i Paesi dell’Est e Sud-Est Europa rappresentano paradisi per i bassi salari. Molti brand enfatizzano l’appartenenza al “Made in Europe”, suggerendo con questo concetto “condizioni di lavoro eque”. In realtà, molti dei 1,7 milioni di lavoratori e lavoratrici di queste regioni vivono in povertà, affrontano condizioni di lavoro pericolose, tra cui straordinari forzati, e si trovano in una situazione di indebitamento significativo.
Queste fabbriche di sfruttamento offrono lavoratori economici, anche se qualificati e professionali. Troppo spesso i salari mensili della maggior parte della forza lavoro femminile raggiungono appena la soglia del salario minimo legale, che varia dagli 89 euro in Ucraina ai 374 euro in Slovacchia. Ma il salario dignitoso, quello che permetterebbe a una famiglia di provvedere ai bisogni primari, dovrebbe essere quattro o cinque volte superiore e in Ucraina, ad esempio, questo vorrebbe dire guadagnare almeno 438 euro al mese.
I salari minimi legali in questi Paesi sono attualmente al di sotto delle loro rispettive soglie di povertà e dei livelli di sussistenza. Le conseguenze sono terribili. “A volte semplicemente non abbiamo niente da mangiare”, ha raccontato una lavoratrice ucraina. “I nostri salari bastano appena per pagare le bollette elettriche, dell’acqua e dei riscaldamenti” ha detto un’altra donna ungherese.
Le interviste a 110 lavoratrici e lavoratori di fabbriche di abbigliamento e calzature in Ungheria, Ucraina e Serbia hanno rivelato che molti di loro sono costretti ad effettuare straordinari per raggiungere i loro obiettivi di produzione. Ma nonostante questo, difficilmente riescono a guadagnare qualcosa in più del salario minimo.
Molti degli intervistati hanno raccontato di condizioni di lavoro pericolose come l’esposizione al calore o a sostanze chimiche tossiche, condizioni antigieniche, straordinari forzati illegali e non pagati e abusi da parte dei dirigenti. I lavoratori intervistati si sentono intimiditi e sotto costante minaccia di licenziamento o trasferimento.
Quando i lavoratori serbi chiedono perché durante la calda estate non c’è aria condizionata, perché l’accesso all’acqua potabile è limitato, perché sono costretti a lavorare di nuovo il sabato, la risposta è sempre la stessa: “Quella è la porta”
“Ci pare evidente che i marchi internazionali stiano approfittando in maniera sostanziosa di un sistema foraggiato da bassi salari e importanti incentivi governativi” dichiara Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign. “In Serbia, ad esempio, oltre ad ingenti sovvenzioni, le imprese estere ricevono aiuti indiretti come esenzione fiscale fino a per dieci anni, terreni a titolo quasi gratuito, infrastrutture e servizi. E nelle zone franche sono pure esentate dal pagamento delle utenze mentre i lavoratori fanno fatica a pagare le bollette della luce e dell’acqua, in continuo vertiginoso aumento” continua Deborah Lucchetti.
Le fabbriche citate nel rapporto producono tutte per importanti marchi globali: tra questi troviamo Benetton, Esprit, GEOX, Triumph e Vera Moda. La Campagna Abiti Puliti chiede ai marchi coinvolti di adeguare i salari corrisposti al livello dignitoso e di lavorare insieme ai loro fornitori per eliminare le condizioni di lavoro disumane e illegali documentate in questo rapporto.
MATERIALI
Schede paese
 Serbia (ITA) Serbia (ITA) |
 Ungheria (EN) Ungheria (EN) |
 Ucraina (EN) Ucraina (EN) |
Leggi anche
(2017) REPORT – Il vero costo delle nostre scarpe
Schede paese (2014)
Bosnia Erzegovina
Bulgaria
Croazia
Moldavia
Romania
Il divario tra il salario minimo legale e il salario dignitoso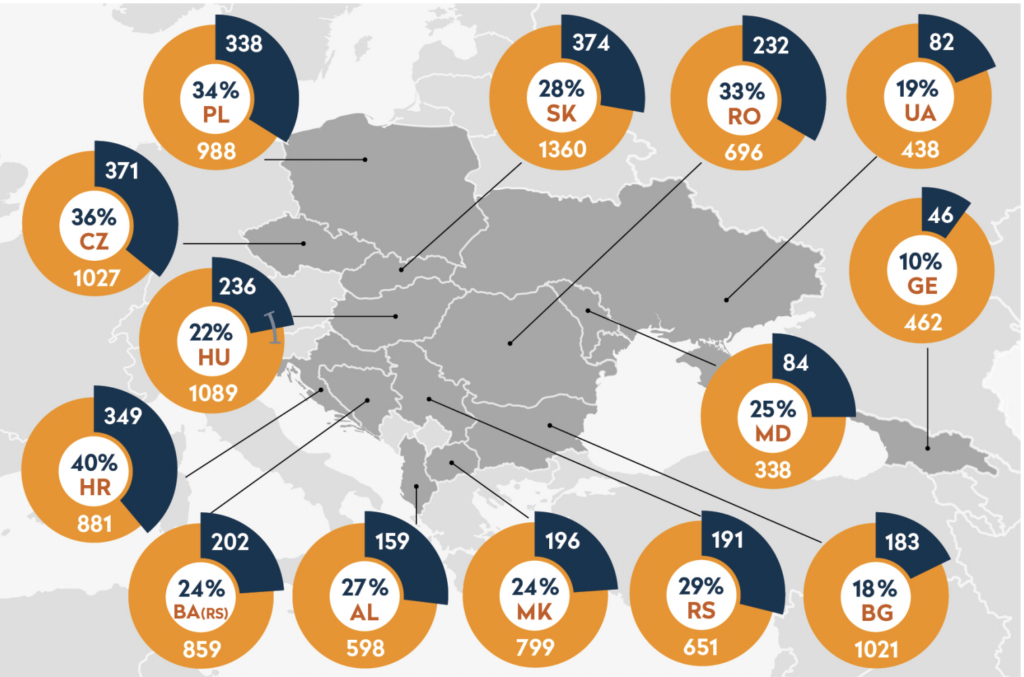
Il governo del Bangladesh continua a violare gli impegni assunti
Non ci sono più scuse: nuovi fatti rivelano il fallimento del Bangladesh nelle fare le riforme del lavoro mentre l’Europa rimane a guardare
Alla luce dei fatti evidenziati nel nuovo rapporto pubblicato oggi, i sindacati e le organizzazioni di attivisti del lavoro rinnovano alla Commissione Europea la richiesta di onorare la promessa di avviare un’indagine commerciale in Bangladesh, a seguito del perdurante fallimento del governo nel fare urgentemente le necessarie riforme di legge e delle politiche di governo dei diritti sindacali nell’industria dell’abbigliamento del paese.
In un nuovo rapporto inviato oggi alla Commissione Europea, la Clean Clothes Campaign, l’International Trade Union Confederation, l’European Trade Union Confederation, IndustriALL Global Union e UNI Global Union dimostrano che, nonostante la firma del “Sustainability Compact” con l’Unione Europea quattro anni fa, il governo del Bangladesh continua a violare gli impegni assunti, non realizzando le riforme vitali necessarie a garantire che l’industria dell’abbigliamento rispetti i principali standard internazionali del lavoro.
Il rapporto si concentra su quattro settori chiave che restano i principali ambiti di preoccupazione per l’Unione europea, l’ILO, i sindacati e gli attivisti per i diritti del lavoro, oltre ad altri portatori di interesse della comunità internazionale a seguito del crollo catastrofico dell’edificio Rana Plaza in Bangladesh. Si tratta della riforma del diritto del lavoro, della libertà di associazione sindacale nelle zone franche per l’esportazione (EPZ), del miglioramento della procedura di registrazione dei sindacati e della cessazione dei fenomeni diffusi di discriminazione anti-sindacale.
Il Sustainability Compact per il Bangladesh comprende una serie di azioni specifiche e temporanee nei quattro ambiti che il governo del Bangladesh si è impegnato ad attuare quando ha firmato il Compact nel 2013. Tuttavia, sebbene il Bangladesh continui a fallire nell’implentazione delle azioni necessarie, l’UE tarda nell’avviare un’indagine commerciale in Bangladesh per confermare in che misura siano soddisfatti i principali diritti del lavoro e dei diritti umani.
Lo scorso maggio la Commissione Europea aveva esteso il termine di attuazione delle azioni di adeguamento ad agosto 2017, quando il governo del Bangladesh avrebbe dovuto fornire all’UE “progressi tangibili” per poter conservare l’idoneità all’accesso commerciale preferenziale dell’UE. Questa estensione della scadenza è giunta a seguito di una serie di estensioni precedenti ed è oggi passata senza alcuna conseguenza. Ciò è indicativo della riluttanza della Commissione Europea ad utilizzare il suo potere nel richiamare il governo del Bangladesh alle sue responsabilità.
Come principale partner commerciale del Bangladesh, l’Unione Europea ha sia il potere che la responsabilità di contribuire ad assicurare che gli standard di lavoro in Bangladesh siano rispettati. Il nuovo rapporto include una serie di casi studio che sottolineano come i sindacalisti continuano a fronteggiare forti discriminazioni e violenze. Questi casi, associati alla repressione delle proteste pacifiche per i salari avvenute all’inizio dell’anno, dimostrano che il dialogo avviato è stato un approccio completamente inefficace per assicurare un cambiamento significativo in Bangladesh.
ITUC, IndustriALL, UNI, ETUC e CCC sollecitano la Commissione Europea a smettere di prolungare le scadenze e ad agire nei confronti del governo del Bangladesh avviando un’indagine commerciale sulla sua ammissibilità all’accesso preferenziale al mercato dell’Unione europea, al fine di esercitare pressioni sul Bangladesh perchè intraprenda riforme del lavoro significative. Un’indagine commerciale potrà fornire ampie possibilità al governo del Bangladesh di fare la cosa giusta, ma fornirà anche lo stimolo necessario per il cambiamento.
Scarica il rapporto completo “The European Union and the Bangladesh garment industry: the failure of the Sustainability Compact”
Informativa privacy petizione CYS
Questa azione on-line è coordinato da INKOTA-netzwerk. Per informazioni, per quanto riguarda la sicurezza e la privacy dei vostri dati, si prega di inviare una email a Fritz Schadow.
L’indirizzo mail e le informazioni personali fornite saranno protette.
Dopo aver inviato i tuoi dati, riceverai una mail. Clicca sul link riportato nella mail per convalidare la tua azione, altrimenti i tuoi dati saranno cancellati.
Non saranno comunicate a parti terze o rese pubbliche senza il consenso dell’interessato. Non conserveremo informazioni personali più del necessario. Se contrassegni il box opzionale, riceverai aggiornamenti per posta elettronica. Nel momento in cui vorrai essere rimosso dalla mailing list, dovrai seguire le istruzioni contenute nella mail.
Con la tua autorizzazione invieremo alcune delle informazioni forniteci ai seguenti gruppi:
- Politici e altri destinatari nel momento in cui decidi di utilizzare la tua posta elettrinica per inviargli messaggi.
- Politici e pubblicazione di notizie nel mometo in cui firmi la petizione o completi il questionario.
Potremmo condividere alcune delle tue informazioni personali solo con gli amministratori del nostro database e al solo fine di supportarci nel lavoro. Questi gruppi non condivideranno le tue informazioni personali, ne le useranno per scopi che vadano oltre alle nostre istruzioni.
Nel momento in cui ci affidi informazioni personali, prenderemo tutte le precauzioni necassarie per garantirne la sicurezza nel nostro sistema.
Petizione e questionario
Della petizione e del questionario che hai firmato o compilato saranno utilizzate come informazioni pubbliche il nome, la città, il Paese e i commenti – ad esempio potremmo consegnare le petizioni con i relativi commenti ai poltici, ad altri destinatari della petizione o alla stampa. Non renderemo pubblico il tuo indirizzo email, ma potremmo trasmetterlo ai destinatari come parte della petizione. Si tratta di una pratica standard in queste situazioni.
Azioni via mail
In alcuni casi, ti metteremo in grado di inviare delle mail individuali ai politici e agli altri destinatari. Questi messaggi verranno inviati a tuo nome e con il tuo indirizzo mail, dal momento che queste informazioni sono fornite come parte della petizione. Questi messaggi saranno inviati a tuo nome solo se acconsenti utilizzando il nostro servizio mail. Sarai responsabile in prima persona del contenuto del messaggio.
Monitoraggio dei dati
Al fine di fornire un servizio migliore ai nostri membri utilizziamo cookies e strumenti per analizzare i loghi presenti sul web. Potremmo raccogliere andirizzi IP per comprendere meglio da dove provengono i dati ricevuti e per fornire dei servizi personalizzati. Potremmo utilizzare servizi effetuati da enti terzi. Ciò ci aiuterà a gestire i flussi di dati ricevuti e a comprendere se ci sono problemi con il nostro sito internet.
L'Accordo per il Bangladesh viene rinnovato con notevoli miglioramenti
 Washington, Toronto, Amsterdam e Roma, 29 giugno – Oggi le federazioni sindacali globali Industriall e UNI annunciano l’accordo raggiunto con i marchi e i distributori per il rinnovo dell’Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici. Ad oggi 13 marchi hanno firmato il nuovo accordo e altri 8 hanno assunto l’impegno di firmarlo, con molti altri che probabilmente seguiranno nelle prossime settimane.
Washington, Toronto, Amsterdam e Roma, 29 giugno – Oggi le federazioni sindacali globali Industriall e UNI annunciano l’accordo raggiunto con i marchi e i distributori per il rinnovo dell’Accordo per la prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici. Ad oggi 13 marchi hanno firmato il nuovo accordo e altri 8 hanno assunto l’impegno di firmarlo, con molti altri che probabilmente seguiranno nelle prossime settimane.
Si tratta dell’innovativo Accordo sulla sicurezza fondato su impegni vincolanti e esecutivi per i marchi dell’abbigliamento al fine di garantire l’identificazione e la correzione dei rischi presso le loro fabbriche in Bangladesh. L’Accordo ha coordinato i lavori di ristrutturazione delle fabbriche coinvolte – dall’installazione delle porte antincendio al rinforzo di colonne strutturali pericolose – migliorando la sicurezza per milioni di lavoratori.
ll nuovo Accordo, che entrerà in vigore nel maggio del 2018 a scadenza dell’attuale, estende il programma per altri tre anni. Ciò comporta la prosecuzione di ispezioni robuste e indipendenti sulla sicurezza per garantire che i progressi raggiunti nel primo periodo siano mantenuti e che i proprietari delle fabbriche non tornino alle pratiche insicure del passato.
Il nuovo Accordo, come il primo, è siglato tra sindacati, marchi di abbigliamento e distributori e include, in qualità di “testimoni”, quattro organizzazioni non governative per i diritti del lavoro: la Clean Clothes Campaign, l’International Labor Rights Forum, il Maquila Solidarity Network e il Worker Rights Consortium.
Come dichiara Ineke Zeldenrust della Clean Clothes Campaign “Il rinnovo dell’Accordo garantisce la prosecuzione del programma più efficace per garantire la sicurezza nelle fabbriche nell’era contemporanea della produzione globale di abbigliamento. L’accordo ha già generato più di 100.000 miglioramenti documentati sulla sicurezza in più di 1.500 fabbriche di confezionamento che impiegano più di 2.5 milioni di lavoratori.”
“L’Accordo è l’antidoto ai sistemi volontari di ispezione che hanno fallito miseramente nel proteggere i lavoratori in Bangladesh e che hanno portato al crollo catastrofico del Rana Plaza” dichiara Scott Nova, Direttore Esecutivo del Workers Rights Consortium. “L’Accordo è un modello che sostituisce le promesse volontarie con impegni obbligatori, assicura severe conseguenze economiche per i fornitori che rifiutano di operare in sicurezza e richiede ai marchi committenti di assicurare che questi possano permettersi il costo dei lavori di ristrutturazione. Il rinnovo dell’Accordo testimonia l’efficacia di questo nuovo modello”
Judy Gearhart Direttore Esecutivo dell’ International Labor Rights Forum aggiunge: “chiediamo ai marchi e distributori che si riforniscono in Bangladesh di siglare il nuovo accordo. Crediamo che le imprese davvero responsabili lo faranno”
L’obiettivo dell’estensione è assicurare che i progressi raggiunti in questi anni siano mantenuti e che i lavoratori di nuove fabbriche siano ricondotti entro il contesto protettivo dell’Accordo, in funzione dei fornitori che i marchi e i distributori firmatari inseriranno nella loro filiera produttiva. Il nuovo Accordo mira anche a sostenere miglioramenti al regime pubblico di regolamentazione del Bangladesh.
Scopo del nuovo Accordo per ulteriori 3 anni non è concedere altro tempo per completare le misure richieste alle imprese attualmente coinvolte nei piani di risanamento. Tutte le imprese attualmente coinvolte dall’Accordo devono infatti completare i piani di azione correttivi entro le scadenze previste e non oltre maggio del 2018. L’ispettorato istituito dall’Accordo garantirà il rispetto di queste scadenze.
Per i lavoratori il nuovo Accordo presenta notevoli miglioramenti rispetto all’originale, incluso un mandato a pagare trattamenti di fine rapporto per le fabbriche che chiudono o si trasferiscono per ragioni di sicurezza, protezione per i rappresentanti sindacali che fronteggiano rappresaglie da parte del proprio datore di lavoro quando richiedono maggiore sicurezza e miglioramenti del meccanismo di risoluzione delle controversie, che vincola i marchi al rispetto dei loro impegni.
Secondo Gearhart: “Il nuovo Accordo non contiene tutti i miglioramenti che i sindacati e le ONG avrebbero voluto, ma mantiene tutti gli elementi critici dell’originale e aggiunge nuove preziose disposizioni“.
Il nuovo Accordo apre anche ad una possibile espansione negoziata del suo scopo, per includere fabbriche che fanno prodotti collegati come tessuti per la casa e calzature, filati e stoffa. Tali fabbriche sono oggi al di fuori del perimetro dell’attuale Accordo, lasciando i lavoratori senza protezione. “Accogliamo con favore il linguaggio nel nuovo accordo che consente potenziali negoziati per includere fabbriche fuori dall’attuale ambito dell’accordo“, ha dichiarato Deborah Lucchetti portavoce della Campagna Abiti Puliti (sezione italiana della Clean Clothes Campaign).
Afferma Lynda Yanz, direttore esecutivo della rete di solidarietà di Maquila, “L’Accordo non ha ancora raggiunto tutti i suoi obiettivi ma si è già distinto per il grande avanzamento rispetto a tutte le iniziative che l’hanno preceduto. L’accordo è stato indubbiamente impegnativo da mettere in atto ed ha incontrato molti ostacoli, con i lavori di ristrutturazione molto in ritardo rispetto al programma. Tuttavia i progressi realizzati sono reali e implicano decine di migliaia di miglioramenti alla sicurezza documentati che hanno ridotto i rischi per milioni di lavoratori “.
Aggiunge ancora Nova “Per quanto riguarda i diritti del lavoro nelle catene di approvvigionamento, la retorica spesso sostituisce l’azione e il tipo di progresso concreto e oggettivamente misurabile per i lavoratori che l’Accordo ha prodotto è ancora poco diffuso. Ecco perché era vitale rinnovarlo”
Il testo del nuovo Accordo
http://bangladeshaccord.org/wp-content/uploads/2018-Accord-full-text.pdf
L’annuncio delle Federazioni sindacali globali
http://www.industriall-union.org/leading-fashion-brands-join-with-unions-to-sign-new-bangladesh-accord-on-fire-and-building-safety.
Un passo avanti: campagna sulla trasparenza nel settore delle calzature
Continua la campagna per chiedere ai grandi marchi trasparenza sulle loro filiere di produzione. Accanto alla petizione #GoTransparent accompagnata dal report Segui il filo, che si focalizza sull’industria dell’abbigliamento, le organizzazioni di Change your Shoes lanciano la campagna “Step Up / Un passo avanti” per chiedere trasparenza nel settore delle calzature.
Le poche norme sulla sicurezza e i salari bassi dei lavoratori dell’abbigliamento sono ampiamente conosciuti, ma raramente sentiamo notizie sulle persone che fanno le nostre scarpe. Ora attivisti in tutta Europa stanno invitando i marchi produttori di scarpe a smettere di nascondersi e ad assumersi la responsabilità delle condizioni nelle proprie catene di fornitura, dove i lavoratori patiscono salari da povertà e condizioni lavorative pericolose.
L’85% della pelle venduta nell’UE viene conciata con il cromo. Durante il processo produttivo i lavoratori sono esposti a sostanze chimiche che possono causare asma, cancro della pelle e altre malattie mortali. Uno dei lavoratori intervistato durante la creazione di un rapporto Change Your Shoes, ad esempio, per l’esposizione a queste sostanze chimiche ha avuto tumori in tutto il corpo.
In altri luoghi troviamo lavoratrici domestiche che per cucire tomaie in pelle per le nostre scarpe lavorano in modo intenso e senza pause. Ma, come parte finale della complessa catena di fornitura, queste donne sono spesso invisibili ai grandi marchi: invece soffrono di problemi di salute dovuti al lavoro ripetitivo e purtroppo sono anche particolarmente vulnerabili allo sfruttamento da parte dei loro datori di lavoro.
La campagna “Step Up/Fai un Passo Avanti”, lanciata il 9 maggio (in occasione dello Europe Day), invita i principali marchi di scarpe europei a seguire la crescente tendenza verso una maggiore trasparenza, rendendo pubblica la lista dei propri fornitori, e mostrando di non temere di mostrarsi responsabili sulle condizioni lavorative in cui vengono realizzati i propri prodotti. Chiede anche di adottare misure per proteggere i lavoratori da condizioni pericolose come le sostanze chimiche utilizzate nel processo di conciatura e garantire che i lavoratori siano trattati in modo equo, in linea con le proprie responsabilità basate sulle linee guida dell’ONU.
Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti ha dichiarato: “La trasparenza è uno strumento importante per migliorare le condizioni dei lavoratori delle scarpe. Se sappiamo quali marchi acquistano da quali fabbriche, possiamo chiedergli di assumersi le loro resposnabilità, e i lavoratori saranno in grado di richiedere risarcimenti e esporre le proprie considerazioni o preoccupazioni sulla sicurezza e sul salario a chi di dovere. Inoltre, i cittadini dell’UE potranno accedere alle informazioni e compiere scelte consapevoli sulle proprie scarpe“.
La campagna Change Your Shoes sta chiedendo a Deichmann, Camper, Prada, Birkenstock, CCC e Leder & Schuh di pubblicare i nomi e gli indirizzi di tutti i propri fornitori, di abbandonare l’uso di sostanze chimiche pericolose e garantire condizioni di lavoro eque e sicure per le persone che producono le loro scarpe.
“Non abbiamo accesso a molte informazioni sulle condizioni di lavoro nell’industria delle calzature perché molti marchi mantengono segrete le loro catene di fornitura“, ha contiunato Deborah Lucchetti. “Questo deve cambiare”.
È giunto il momento per la Commissione Europea di imporre la trasparenza nelle catene di fornitura dell'abbigliamento
Oggi, 27 aprile 2017, “l’iniziativa faro della UE sul settore dell’abbigliamento” è stato approvata dal Parlamento europeo in seduta plenaria con una grande maggioranza dei voti.
È importante che, oltre a promuovere iniziative volontarie, il Parlamento europeo inviti la Commissione a presentare una proposta legislativa sull’obbligatorietà dell’applicazione della due diligence nelle catene di fornitura del settore tessile in linea con i nuovi orientamenti OCSE in materia di due diligence nel settore dell’abbigliamento e della calzatura. Il Parlamento europeo chiede inoltre alla Commissione di avviare un’iniziativa per la divulgazione obbligatoria dei siti produttivi e “sottolinea la necessità di raccogliere e pubblicare dati completi sul rendimento della sostenibilità aziendale attraverso l’elaborazione di definizioni e standard comuni per la raccolta e il confronto di dati statistici, in particolare sulle importazioni generali“.
In linea con il presente invito del Parlamento europeo, oggi la Clean Clothes Campaign insieme a 78 organizzazioni della società civile invia una lettera comune per invitare la Commissione Europea a rendere obbligatoria per le imprese la pubblicazione della lista completa dei fornitori, inclusi i nomi, i contatti, gli indirizzi dei siti produttivi, su base regolare e accessibile. La trasparenza è un prerequisito fondamentale per verificare l’effettivo rispetto dei diritti umani e del lavoro in qualunque fase produttiva, ovunque essa avvenga nel mondo.
Rana Plaza: 4 anni dopo poco è cambiato
Il 24 aprile 2017 la rete della Clean Clothes Campaign ricorderà coloro che sono rimasti uccisi e feriti al Rana Plaza, l’edificio a più piani che è crollato in Bangladesh quattro anni fa. In una dichiarazione rilasciata oggi la Clean Clothes Campaign invia i suoi pensieri e la sua vicinanza a coloro che soffrono per i propri cari e coloro che soffrono ancora per le cicatrici fisiche e psicologiche lasciate dal disastro.
La Clean Clothes Campaign ricorda il quarto anniversario del Rana Plaza, definendo una serie di azioni fondamentali da parte dei governi, dei marchi e dei datori di lavoro per garantire la sicurezza, i diritti dei lavoratori e la trasparenza. Queste azioni sono necessarie per ottenere quel cambiamento strutturale promesso in seguito al disastro.
Nella sua dichiarazione disponibile on line, la Clean Clothes Campaign affronta una serie di problemi ricorrenti che affliggono l’industria dell’abbigliamento e che sono stati particolarmente evidenziati dal disastro di Rana Plaza. Quando l’edificio, che ospitava cinque fabbriche di indumenti, è crollato non era stato adeguatamente ispezionato, i suoi lavoratori non erano organizzati in un sindacato e non c’erano dati pubblici sui marchi committenti.
L’Accordo legalmente vincolante sulla sicurezza e la prevenzione degli incendi è stato istituito a seguito del disastro per assicurare che vengano effettuate ispezioni corrette e siano risolti i problemi rilevati. Ciò ha portato ad un significativo miglioramento della sicurezza delle fabbriche in Bangladesh tuttavia l’avanzamento verso un’industria dell’abbigliamento più sicura è ostacolato dalla continua repressione dei diritti dei lavoratori e dal segreto ingiustificato che avvolge le filiere produttive e non rivela dove i marchi di abbigliamento producono i loro beni.
Questo livello di segretezza ha anche ostacolato la campagna di risarcimento che ha seguito il crollo del Rana Plaza. Gli attivisti e i giornalisti hanno dovuto ricercare tra le macerie le etichette e documenti necessari per dimostrare il legame tra marchi e fabbriche di produzione. Come sottolinea Deborah Lucchetti della Campagna Abiti Puliti (Clean Clothes Campaign italiana): “I lavoratori non dovrebbero rischiare la propria vita o il posto di lavoro per cercare di trafugare etichette e documenti fuori da una fabbrica per farsi ascoltare. I lavoratori hanno il diritto di sapere per chi producono e i consumatori dovrebbero sapere dove vengono prodotti i vestiti che acquistano “.
La Clean Clothes Campaign, nella sua dichiarazione, ha sviluppato una serie di azioni chiare, semplici e realizzabili che, se assunte dai marchi e dai governi, ci avvicinerebbero all’industria sostenibile promessa ai lavoratori del settore e ai consumatori all’indomani della tragedia. Queste azioni includono l’estensione dell’attuale Accordo oltre il periodo iniziale di validità di cinque anni e il suo rafforzamento. La Clean Clothes Campaign invita inoltre i marchi e i distributori a migliorare la trasparenza della loro catena di approvvigionamento, consentendo ai lavoratori e ai consumatori di monitorare più attentamente le condizioni di lavoro. Inoltre la dichiarazione evidenzia la necessità di un’azione maggiore da parte dell’Unione Europea – il principale mercato di esportazioni del Bangladesh – finalizzata ad utilizzare gli accordi commerciali per far rispettare i diritti sindacali in Bangladesh e ad approvare una normativa che obbliga i marchi e i distributori a rendere pubblica la loro catena di approvvigionamento.
In occasione del quarto anniversario della più grave catastrofe nell’industria dell’abbigliamento, chiediamo ai governi e ai marchi di agire adesso per mantenere la promessa di lavorare per il cambiamento.
Leggi la dichiarazione completa della Clean Clothes Campaign qui: https://www.abitipuliti.org/wp-content/uploads/2017/04/Dichiarazione-anniversario-Rana-Plaza.pdf
(2017) REPORT - Segui il filo: alla ricerca della trasparenza di filiera nell’industria dell’abbigliamento e delle calzature
Molte più aziende dell’abbigliamento e delle calzature dovrebbero unirsi alle 17 che già sono in linea con una nuova importante iniziativa per la trasparenza, secondo il rapporto lanciato oggi da una coalizione di gruppi di difesa dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori. L’iniziativa impegna le aziende a pubblicare le informazioni che permettano a sostenitori dei diritti, lavoratori e consumatori di scoprire dove vengono realizzati i loro prodotti.
Il rapporto di 40 pagine Segui il filo: alla ricerca della trasparenza di filiera nell’industria dell’abbigliamento e delle calzature, arriva poco prima del quarto anniversario della tragedia del crollo del Rana Plaza in Bangladesh. Chiede nello specifico ai marchi di adottare l’”Iniziativa per la trasparenza nella catena di fornitura dell’abbigliamento e delle calzature”. Le aziende che vi aderiscono si impegnano a pubblicare informazioni che identifichino le fabbriche che realizzano i loro prodotti, rimuovendo un ostacolo fondamentale per sradicare pratiche di lavoro abusive e aiutando a prevenire disastri come quello del Rana Plaza.
La coalizione ha contattato 72 aziende e chiesto loro di adottare e dare piena attuazione all’iniziativa. Il documento riporta le loro risposte in maniera dettagliata e valuta le pratiche di trasparenza messe in atto in relazione all’impegno richiesto dall’iniziativa stessa.
“Un livello minino di trasparenza nella catena di fornitura dell’industria tessile dovrebbe essere la norma nel 21° secolo” dichiara Aruna Kashyap, Senior Counsel della divisione diritti delle donne di Human Rights Watch. “Un atteggiamento di apertura rispetto ai propri fornitori è utile per i lavoratori, per i diritti umani e mostra la buona volontà delle aziende nel prevenire abusi lungo la catena di fornitura”.
Il crollo dell’edificio Rana Plaza il 24 aprile 2013 ha ucciso in Bangladesh più di 1.100 lavoratori tessili e ne ha feriti più di 2.000. Fu preceduto da due grossi incendi, uno divampato nella fabbrica Ali Enterprises in Pakistan e l’altro alla Tazreen Fashions in Bangladesh, che uccisero più di 350 persone e ne ferirono gravemente molte altre. Non potendo determinare quali aziende si rifornissero presso quelle fabbriche, i sostenitori dei diritti dei lavoratori dovettero andare alla ricerca di etichette tra le macerie ed intervistare i sopravvissuti per scoprire chi fossero i responsabili.
Alla fine del 2016, almeno 29 marchi globali dell’abbigliamento avevano pubblicato alcune informazioni sulle fabbriche che confezionano i loro prodotti. Sulla scia del momento favorevole, nel 2016, una coalizione di nove organizzazioni sindacali e di difesa dei diritti umani e dei lavoratori ha ideato l’Iniziativa, il cui obiettivo è creare parità di condizioni nel settore dell’abbigliamento e portarlo verso uno standard minimo di pubblicazione delle informazioni sulle fabbriche fornitrici.
La coalizione è composta da: Clean Clothes Campaign, Human Rights Watch, IndustriALL Global Union, International Corporate Accountability Roundtable, International Labor Rights Forum, International Trade Union Confederation, Maquila Solidarity Network, UNI Global Union e Worker Rights Consortium.
I membri della coalizione hanno scritto a 72 aziende – comprese 23 che già stavano pubblicando informazioni sui fornitori – chiedendo loro di adottare e dare attuazione all’Iniziativa per la Trasparenza. In quel momento molte aziende, tra le quali alcune che si riforniscono in paesi con persistenti violazioni dei diritti dei lavoratori, non avevano pubblicato alcuna informazione sui loro fornitori.
L’Iniziativa per la Trasparenza prende spunto dalle buone pratiche delle aziende globali nel settore dell’abbigliamento e stabilisce un requisito minimo, e non un limite massimo, per la trasparenza nella catena di fornitura. Chiede ai marchi di pubblicare importanti informazioni sui fornitori e sui loro subfornitori autorizzati. Queste informazioni contribuiscono all’affermazione dei diritti dei lavoratori, allo sviluppo delle pratiche di business responsabile e di applicazione della due diligence sui diritti umani. Infine stimola la creazione di un clima di fiducia tra i vari attori così come previsto dai Principi Guida dell’ONU su imprese e diritti umani.
Molti importanti investitori hanno iniziato a chiedere ai marchi di pubblicare informazioni sui loro fornitori. Recentemente, la Corporate Human Rights Benchmark, supportata da 85 investitori che rappresentano 5,3 trilioni di dollari in asset, ha inserito nelle schede di valutazione dei marchi la trasparenza della catena di fornitura, chiedendo loro di pubblicare almeno i nomi delle fabbriche che producono per loro.
“Dopo il Rana Plaza e gli altri disastri, i gruppi in difesa dei diritti umani, i sindacati e alcune aziende e investitori hanno capito quanto la trasparenza sia importante per prevenire gli abusi ed assicurare responsabilità” dichiara Ben Vanpeperstraete, coordinatore delle attività di lobby e advocacy della Clean Clothes Campaign. “Le aziende devono mettere in pratica la trasparenza per dimostrare che rispettano i diritti umani e garantiscono condizioni di lavoro dignitose”.
La trasparenza è uno strumento molto potente per promuovere la responsabilità di impresa verso i lavoratori del tessile lungo tutta la catena di fornitura, secondo la Coalizione. Permette alle organizzazioni ed ai lavoratori di avvertire le aziende riguardo agli abusi nella fabbriche fornitrici, e facilita il ricorso più veloce a meccanismi di reclamo per abusi dei diritti umani.
Delle 72 aziende contattate, 17 saranno perfettamente in linea con gli standard dell’iniziativa entro il 31 dicembre 2017.
Gli standard di molte altre aziende restano invece al di sotto: cinque hanno quasi raggiunto gli standard, 18 si stanno muovendo nella giusta direzione rivelando almeno i nomi e gli indirizzi delle fabbriche di confezionamento e sette stanno muovendo piccoli passi verso la pubblicazione di informazioni relative alla lor catena di fornitura – ad esempio, su una parte dei loro fornitori, o almeno i nomi in base ai Paesi, entro dicembre 2017.
Altre 25 aziende non pubblicano alcuna informazione sulla fabbriche che confezionano i loro prodotti. Queste aziende non hanno risposto oppure non si sono impegnate a pubblicare le informazioni richieste.
La Coalizione chiede alle aziende che non hanno ancora aderito all’Iniziativa di farlo entro dicembre e di impegnarsi attivamente per portare il settore verso una soglia minima di trasparenza nella catena di fornitura.
“Assicurare un livello minimo di trasparenza nelle catene di fornitura, come richiesto dall’iniziativa, darebbe un importante contributo agli sforzi per assicurare le responsabilità delle aziende” dichiara Judy Gearhart, executive director dell’International Labor Rights Forum. “Le aziende possono fare di più, ma dovrebbero quanto meno partire con questo passo basilare”.
Alcune aziende hanno dichiarato che rivelare le informazioni potrebbe svantaggiarle commercialmente. Ma questa affermazione è palesemente contraddetta dalla pubblicazione effettuata dalle altre aziende. Come ha dichiarato Esprit, una delle aziende che si è impegnata per la trasparenza: “Rivelare queste informazioni non è facile per molte aziende, ma è arrivato il momento di farlo”.
MATERIALI
 |
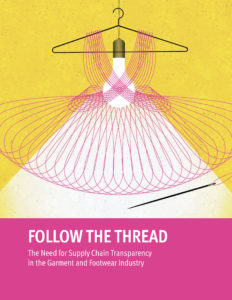 |
| SCARICA L’ESTRATTO (ITALIANO) | SCARICA IL REPORT COMPLETO (INGLESE) |
FIRMA LA PETIZIONE
INIZIATIVA PER LA TRASPARENZA
L’Iniziativa per la trasparenza mostra l’impegno dei marchi tessili e delle calzature per una maggiore trasparenza nella propria catena di fornitura.
L’impegno per una maggiore trasparenza rende possibile all’azienda stessa di collaborare con le società civile nell’identificare, valutare ed evitare potenziali o reali impatti negativi per i diritti umani. Questo è un passo fondamentale che rafforza la due diligence dell’azienda verso i diritti umani.
Ogni azienda che aderisce all’iniziativa si impegna quanto meno a mettere in atto, entro il 31 deicember 2017, i seguenti punti.
Pubblicare i siti produttivi
L’azienda pubblicherà a scadenze regolari ( ad esempio 2 volte l’anno) sul proprio sito internet una lista di tutti i siti dove vengono realizzati i propri prodotti. La lista dovrebbe fornire in Inglese le seguenti informazioni:
- Nome completo di tutte le unità di produzione e degli impianti di trasformazione autorizzati. 1
- Gli indirizzi dei siti
- La società madre dell’azienda in quel sito.2
- Tipologie di prodotti realizzati.3
- Numero di lavoratori per ogni sito.4
Le aziende pubblicheranno queste informazioni su un foglio elettronico o altro formato con funzioni di ricerca.
1 Gli impianti di trasformazione includono quelli che si occupano di stampa, ricamo, lavanderia e così via.
2 La società madre è un’azienda che ha una partecipazione di maggioranza o di controllo su una delle fabbriche inserite nell’elenco dei fornitori. Considerato che la responsabilità per la due diligence sui diritti umani nelle relazioni di subcontratto ricadono sui fornitori, la coalizione ha stabilito come limite minimo per la fornitura di questi dati il livello di azienda madre delle fabbriche di cut-make-trim. Se il fornitore è l’azienda madre della fabbrica comunicata, allora si prega di indicare se il fornitore stesso possieda o abbia una relazione contrattuale con la fabbrica in questione
3 Si prega di indicare la categoria generale: abbigliamento, calzature, tessili per la casa, accessori
4 Si prega di indicare se il luogo rientra in una delle seguenti categorie in base al numero dei lavoratori: meno di 1000 lavoratori; da 1001 a 5000 lavoratori; da 5001 a 10.000 lavoratori; più di 10.000 lavoratori
LE RISPOSTE DELLE AZIENDE
Aziende allineate alle richieste dell’ Impegno per la trasparenza
I marchi che avevano già pubblicato informazioni e si sono impegnate ad integrarle entro Dicembre 2017 così come chiesto dall’Iniziativa sono: adidas, C&A, Cotton On Group, Esprit, G-Star RAW, H&M Group, Hanesbrands, Levis, Lindex, Nike e Patagonia.
I marchi che non avevano pubblicato informazioni e si sono impegnate a farlo così come chiesto dall’Iniziativa sono: ASICS, ASOS, Clarks, New Look, Next e Pentland Brands. Questi marchi globali aiuteranno a fare un ulteriore passo per la promozione di uno standard minimo a livello di settore per la trasparenza della catena di fornitura.
John Lewis, Marks and Spencer, Tesco, Gap e Mountain Equipment Co-op aderiscono quasi interamente agli standard richiesti.
Nella giusta direzione
Coles, Columbia Sportswear, Disney, Hudson’s Bay Company, Kmart and Target Australia e Woolworths Australia già pubblicavano i nomi e gli indirizzi delle fabbriche fornitrici e non hanno preso impegni per le altre richieste. Puma e New Balance già pubblicavano i nomi e gli indirizzi delle fabbriche fornitrici e si sono impegnate ad aggiungere altri dettagli per avvicinarsi alle altre richieste avanzate con l’Iniziativa.
ALDI North e ALDI South, Arcadia Group, Benetton, Debenhams, LIDL, Tchibo, Under Armour e VF Corporation hanno iniziato a muoversi nella giusta direzione e hanno iniziato o inizieranno a pubblicare entro il 2017 almeno i nomi e gli indirizzi di tutte le fabbriche di confezionamento. Fast Retailing ha pubblicato i nomi e gli indirizzi della lista delle fabbriche principali del suo marchio UNIQLO nel 2017.
Piccoli passi verso la pubblicazione delle informazioni
Target USA aveva pubblicato in precedenza i nomi dei fornitori con i paesi di produzione, ma non si è assunta alcun altro impegno. Nel 2017 Mizuno, Abercrombie & Fitch, Loblaw e PVH Corporation si muoveranno per pubblicare i nomi dei fornitori, ma solo con il paese di produzione.
BESTSELLER e Decathlon hanno promesso di pubblicare alcune informazioni nel 2017 senza precisare quali.
Nessun impegno a pubblicare le informazioni
American Eagle Outfitters, Canadian Tire, Carrefour, Desigual, DICK’S Sporting Goods, Foot Locker, Hugo Boss, KiK, MANGO, Morrison’s, Primark, Sainsbury’s, The Children’s Place e Walmart non si sono impegnate a pubblicare nulla. Inditex si è rifiutata di pubblicare le informazioni, ma mette a disposizione di IndustriALL e dei suoi membri i dati come parte dell’attività di reporting stabilito dal Global Framework Agreement.
Armani, Carter’s, Forever 21, Matalan, Ralph Lauren Corporation, Rip Curl, River Island, Shop Direct, Sports Direct e Urban Outfitters non hanno risposto alla coalizione e non pubblicano alcuna informazione.
Marchi che hanno sottoscritto il Global Framework Agreement con IndustriALL e pubblicano alcune informazioni: H&M Group e Mizuno; Tchibo inizierà nel 2017.
Marchi che sono parte del Bangladesh Accord on Fire and Building Safety e pubblicano alcune informazioni: Stanno già pubblicando informazioni: adidas, C&A, Cotton On Group, Esprit, G-Star RAW, H&M Group, Kmart Australia, Lindex, Marks and Spencer, Puma, Target Australia e Woolworths
Hanno iniziato o inizieranno a pubblicare alcune informazioni nel 2017: Abercrombie & Fitch, ALDI North e ALDI South, BESTSELLER, Debenhams, Fast Retailing, John Lewis, New Look, Next, LIDL, Loblaw, PVH Corporation, Tchibo e Tesco.
Marchi che sono parte della German Partnership for Sustainable Textiles (il Textil Bündnis) e pubblicano alcune informazioni: Adidas, C&A, Esprit, H&M e Puma; altri come ALDI North e ALDI South, LIDL e Tchibo hanno iniziato o inizieranno nel 2017.
(2017) REPORT – Il vero costo delle nostre scarpe
La Campagna Abiti Puliti e Change your Shoes annunciano il lancio della nuova inchiesta “Il vero costo delle nostre scarpe: viaggio nelle filiere produttive di tre marchi globali delle calzature” realizzata dal Centro Nuovo Modello Di Sviluppo (CNMS) e FAIR.
Il rapporto descrive il viaggio compiuto lungo le filiere produttive di tre grandi marchi di calzature (Tod’s, GEOX e Prada), mostrando quanto questa industria sia ancora lontana dal rispettare i diritti umani e sindacali degli operai che confezionano le loro scarpe.
Tale basso livello di rispetto si fa sentire anche nel continente europeo che sta vivendo importanti fenomeni di rilocalizzazione. Questa è uno degli aspetti di novità che emerge dal rapporto. Si definisce reshoring e indica il trasferimento in direzione contraria delle attività produttive precedentemente delocalizzate in Asia (o altri luoghi “low cost”) soprattutto per l’abbassamento del costo del lavoro. L’aumento di produttività, unito a una politica di moderazione salariale, di maggiore flessibilità del lavoro, di maggiore libertà di licenziamento, di relazioni industriali soft affiancate da incentivi e sussidi per attrarre gli investimenti, sta rendendo di nuovo appetibile anche la vecchia Europa che presenta il vantaggio di una mano d’opera ad alta tradizione manifatturiera. Ad essere più interessati al fenomeno sono i paesi dell’Europa dell’Est con salari a volte più bassi di quelli asiatici.
Utilizzando oltre 11 milioni di euro messi a disposizione dal governo serbo, nel gennaio 2016 GEOX ha aperto un impianto di produzione a Vranje, in Serbia. Come descritto nel rapporto, durante l’estate del 2016 una serie di irregolarità sono state denunciate dalla stampa locale: condizioni sanitarie e di sicurezza insoddisfacenti, offese verbali ai lavoratori, forme di assunzione non regolari, straordinari eccessivi e altre violazioni alle norme sul lavoro. Grazie alla capacità di denuncia di alcuni lavoratori, alla pressione dei media e all’attività di sindacati e organizzazioni di attivisti per i diritti dei lavoratori, alcuni aspetti sono migliorati, ma ancora molto c’è da fare. Il video-documentario “In my shoes”, prodotto per Change Your Shoes da Sara Farolfi e Mario Poeta, raccoglie alcune di queste voci. Tuttavia, per consentire ai lavoratori di godere a pieno dei loro diritti, deve essere garantito e rafforzato un vero processo di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva, che includa un aumento negoziato dei salari per soddisfare il costo medio della vita.
Le reti di produzione globale sono strutturate per incoraggiare la corsa verso il basso e spesso favorire violazioni diffuse dei diritti dei lavoratori. Quando i tempi di consegna sono molto stretti e i prezzi pagati dai marchi talmente bassi da non permettere nemmeno di coprire i costi di produzione dei subfornitori, allora entriamo nel mondo oscuro dell’economia informale, popolato da aziende che cercano di risparmiare frodando i propri lavoratori, le autorità fiscali, e il sistema di sicurezza sociale. In questo contesto, è facile per le piccole imprese fallire, come è successo ad alcuni imprenditori che hanno lavorato per Tod’s e Prada.
Come conseguenza di queste relazioni inique vi è una crescente sproporzione tra prezzi e valore reale dei beni assorbita per la maggior dalla distribuzione e dal marchio (che si appropriano di circa il 60% del prezzo finale) lasciando le briciole agli altri attori della catena di fornitura. Questo accade soprattutto dove c’è più opacità, lontano dalla vista dei consumatori. L’inchiesta rivela come la maggior parte dei lavoratori e dei subappaltatori abbia paura di testimoniare, preferendo farlo nell’anonimato.
La presenza di cittadini e consumatori bene informati, di media indipendenti, di reti di solidarietà internazionali, sono condizioni fondamentali per ottenere dalle imprese comportamenti responsabili conformi alle tutele previste dalle leggi nazionali, dalle convenzioni internazionali e dai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP).
Campagna Abiti Puliti con Change your Shoes chiede ai marchi delle calzature (compresi Tod’s, Prada e GEOX) di garantire una totale trasparenza della loro catena di fornitura e il rispetto dei diritti umani e del lavoro fondamentali, compreso il pagamento di salari dignitosi; allo stesso tempo chiede ai governi nazionali e alle istituzioni europee di rafforzare i controlli sull’applicazione delle leggi sul lavoro, soprattutto nei segmenti ad alto rischio di violazione; obbligare le aziende a rendere trasparenti le loro catene di fornitura e a implementare un piano di due diligence per identificare, prevenire, ridurre e rendere conto degli impatti negativi delle loro operazioni sui diritti dei lavoratori lungo tutta la catena di fornitura.
Materiali
 |
 |
| SCARICA IL REPORT COMPLETO | SCARICA L’ESTRATTO |
Rapporto completo alta qualità
English Versions
The real cost of our shoes FULL REPORT
The real cost of our shoes FACTSHEET
Lavorare per GEOX nel 21° secolo – Il caso serbo
PER APPROFONDIRE
THE NEW YORK TIMES – Un viaggio nell’economia sommersa dell’Italia
REPUBBLICA – Il vero costo delle nostre scarpe: viaggio nelle filiere produttive delle calzature
REPUBBLICA – Il vero costo delle nostre scarpe: viaggio nelle filiere produttive delle calzature
LA STAMPA – Scarpe italiane, scarpe prodotte senza diritti e sostenibilità
COMUNE-INFO – Che calpestiamo con Geox, Tod’s e Prada?
AVVENIRE – Scarpe griffate. Quella filiera opaca che porta all’Est e torna in italia
IL MANIFESTO – Dietro il brand made in Italy: a Est la frontiera del profitto
OSSERVATORIO DIRITTI – Diritti umani sotto i piedi
Un nuovo rapporto della Clean Clothes Campaign rivela condizioni di grave sfruttamento nella produzione di abbigliamento e calzature “Made in Europe”
Un nuovo rapporto della Clean Clothes Campaign, Europe’s Sweatshops, documenta i salari da fame endemici e le dure condizioni di lavoro nell’industria tessile e calzaturiera dell’Est e Sud-Est Europa. Ad esempio, molti lavoratori in Ucraina, nonostante gli straordinari, guadagnano appena 89 euro al mese in un Paese in cui il salario dignitoso dovrebbe essere almeno 5 volte tanto. Tra i clienti di queste fabbriche ci sono marchi globali come Benetton, Esprit, GEOX, Triumph e Vera Moda.
Per questi marchi i Paesi dell’Est e Sud-Est Europa rappresentano paradisi per i bassi salari. Molti brand enfatizzano l’appartenenza al “Made in Europe”, suggerendo con questo concetto “condizioni di lavoro eque”. In realtà, molti dei 1,7 milioni di lavoratori e lavoratrici di queste regioni vivono in povertà, affrontano condizioni di lavoro pericolose, tra cui straordinari forzati, e si trovano in una situazione di indebitamento significativo.
Queste fabbriche di sfruttamento offrono lavoratori economici, anche se qualificati e professionali. Troppo spesso i salari mensili della maggior parte della forza lavoro femminile raggiungono appena la soglia del salario minimo legale, che varia dagli 89 euro in Ucraina ai 374 euro in Slovacchia. Ma il salario dignitoso, quello che permetterebbe a una famiglia di provvedere ai bisogni primari, dovrebbe essere quattro o cinque volte superiore e in Ucraina, ad esempio, questo vorrebbe dire guadagnare almeno 438 euro al mese.
I salari minimi legali in questi Paesi sono attualmente al di sotto delle loro rispettive soglie di povertà e dei livelli di sussistenza. Le conseguenze sono terribili. “A volte semplicemente non abbiamo niente da mangiare”, ha raccontato una lavoratrice ucraina. “I nostri salari bastano appena per pagare le bollette elettriche, dell’acqua e dei riscaldamenti” ha detto un’altra donna ungherese.
Le interviste a 110 lavoratrici e lavoratori di fabbriche di abbigliamento e calzature in Ungheria, Ucraina e Serbia hanno rivelato che molti di loro sono costretti ad effettuare straordinari per raggiungere i loro obiettivi di produzione. Ma nonostante questo, difficilmente riescono a guadagnare qualcosa in più del salario minimo.
Molti degli intervistati hanno raccontato di condizioni di lavoro pericolose come l’esposizione al calore o a sostanze chimiche tossiche, condizioni antigieniche, straordinari forzati illegali e non pagati e abusi da parte dei dirigenti. I lavoratori intervistati si sentono intimiditi e sotto costante minaccia di licenziamento o trasferimento.
Quando i lavoratori serbi chiedono perché durante la calda estate non c’è aria condizionata, perché l’accesso all’acqua potabile è limitato, perché sono costretti a lavorare di nuovo il sabato, la risposta è sempre la stessa: “Quella è la porta”
“Ci pare evidente che i marchi internazionali stiano approfittando in maniera sostanziosa di un sistema foraggiato da bassi salari e importanti incentivi governativi” dichiara Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign. “In Serbia, ad esempio, oltre ad ingenti sovvenzioni, le imprese estere ricevono aiuti indiretti come esenzione fiscale fino a per dieci anni, terreni a titolo quasi gratuito, infrastrutture e servizi. E nelle zone franche sono pure esentate dal pagamento delle utenze mentre i lavoratori fanno fatica a pagare le bollette della luce e dell’acqua, in continuo vertiginoso aumento” continua Deborah Lucchetti.
Le fabbriche citate nel rapporto producono tutte per importanti marchi globali: tra questi troviamo Benetton, Esprit, GEOX, Triumph e Vera Moda. La Campagna Abiti Puliti chiede ai marchi coinvolti di adeguare i salari corrisposti al livello dignitoso e di lavorare insieme ai loro fornitori per eliminare le condizioni di lavoro disumane e illegali documentate in questo rapporto.
MATERIALI
Schede paese
 Serbia (ITA) Serbia (ITA) |
 Ungheria (EN) Ungheria (EN) |
 Ucraina (EN) Ucraina (EN) |
Leggi anche
(2017) REPORT – Il vero costo delle nostre scarpe
Schede paese (2014)
Bosnia Erzegovina
Bulgaria
Croazia
Moldavia
Romania
Il divario tra il salario minimo legale e il salario dignitoso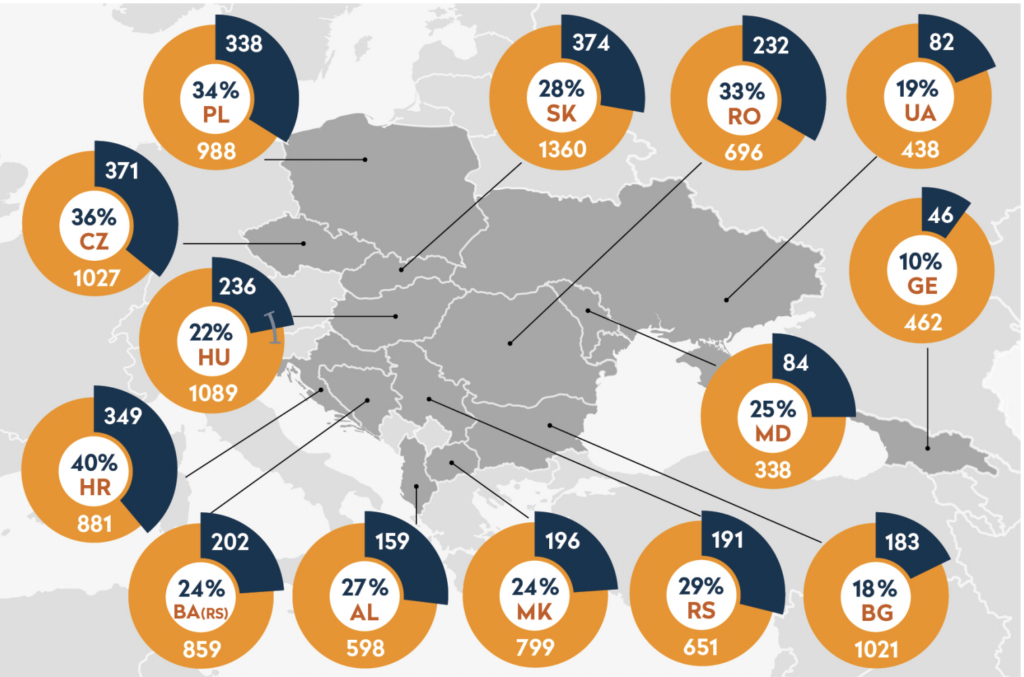
EVENTO - MADE IN ITALY - CNA Torino - 18 aprile 2017

ore 15.00 Saluti di benvenuto
- Nicola Scarlatelli Presidente CNA Torino
- Silvio Cattaneo Presidente CNA Federmoda Piemonte
- Vitaliano Alessio Stefanoni Responsabile CNA Federmoda Torino
- Giuseppina De Santis Assessore Regionale Attività Produttive
- Alberto Sacco Assessore alle Attività Produttive Comune di Torino
ore 15.30 Apertura lavori
- Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda
ore 15.45 Interventi
- “Il vero costo delle nostre scarpe”, Deborah Lucchetti (portavoce Campagna Abiti Puliti/Change Your Shoes); presentazione video della VII edizione della performance 13600HZ Concerto per Macchine per Cucire (progetto di ricerca artistica di Sara Conforti)
- “Economia del tessile sostenibile: la lana italiana” ed. Franco Angeli, Secondo Rolfo Direttore IRCrES-CNR, presentazione della ricerca sulla lana rustica
ore 16.30 Presentazione del progetto
- Guida “Consumo e diritti: sensibilizzare i giovani verso un consumo consapevole” a cura di Rossella Calabrò, Vice Presidente Nazionale CNA Federmoda
ore 16.50 Tavola rotonda
- Sen. Valeria Fedeli Ministra Istruzione Università e Ricerca
- Sonia Paoloni Segretaria Nazionale Filtcem Cgil
- Mario Siviero Segretario Nazionale Femca Cisl
- Flaminio Fasetti Segretario Regione Piemonte Uiltec Uil
- Benedetta Francesconi MiSE- DGPICPMI, Resp. Segretariato del PCN per le Linee guida OCSE
- Stefano Di Niola Responsabile Dipartimento Relazioni Sindacali CNA Nazionale
- Luca Marco Rinfreschi Presidente Nazionale CNA Federmoda
ore 18.15 Conclusioni
- Presidente Nazionale CNA Daniele Vaccarino
EVENTO - RI-VESTITI! La moda di fare un'altra economia - BOLOGNA - 8 E 9 APRILE 2017

La Campagna Abiti Puliti prenderà parte al Festival Terra Equa 2017: “Ri-Vestiti! La moda di fare un’altra economia”.
Saremo presenti sabato 8 aprile e domenica 9 aprile con l’evento “FASHION REVERSE – Sai cosa ti metti addosso?”, a cura di Sara Conforti e Deborah Lucchetti. Una lettura partecipata delle etichettte dei vestiti che indossiamo. Un workshop dedicato a coloro che desiderano saperne di più sui nostri abiti, scoprire di “che cosa sono fatti”, chi sono le persone che le producono.
Sabato 8 alle ore 18 sarà proiettato, presso lo spazio cinema “TRUE COST”, il documentario presentato al Festival di Cannes 2015 che racconta le storie elle persone che producono i nostri vestiti, l’impatto dell’industria della moda sul nostro mondoe qual’è il vero costo della maglietta da 10 euro che indossiamo.
Intervengono:
Linda Triggiani (C’è un mondo – Terra Equa)
David Cambioli (Altra Qualità)
Deborah Lucchetti (FAIR – Campagna Abiti Puliti)
Emanuele Giordana (giornalista, saggista e direttore di Lettera 22)
In collaborazione con “Tutti nello stesso piatto”, Festival internazionale di cinema e videodiversità.
Scopri il programma completo —-> http://
EVENTO – IL VERO COSTO DELLE NOSTRE SCARPE – GENOVA – 14 APRILE 2017

Ore 20.45 – 13600HZ Concerto per macchine per cucire VII Edizione
Arrivato alla sua sua VII edizione il progetto performativo 13600HZ Concerto per macchine per cucire (gia’ presentato precedentemente al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Artissima 21 / Zonarte, Teatro della Cavallerizza Reale di Torino e Palazzo Ducale Fondazione per la cultura di Genova) presenta il suo nuovo tabeau vivent Sistemi Periodici +[Ar]3d54s1 – Damnatio Memoriae creato site specific per la Campagna Change your Shoes / Abiti Puliti. (www.abitipuliti.org) Un lavoro corale creato attraverso il coinvolgimento del pubblico femminile in pratiche partecipate dedicate alla condivisione delle narrazioni di vita vissuta legate alla memoria delle proprie calzature d’affezione al fine di costruire un atto universale che dall’auto_rappresentazione apre la strada a nuove forme di esperienza collettiva attraverso il gesto e il suono. In collaborazione con:Francesca Cinalli (Coreografie/Drammaturgie) Paolo De Santis, Luca Morino, Pierluigi Pusole (sewing machines orchestra) Massimiliano Monnecchi (Fotografia e documentazione) Si ringraziano per la partecipazione ai workshop prepratori:
Francesca Albera, Simona Bartolami, Chiara Birattari, Beatrice Catanzaro, Maria Elisa Carzedda, Francesca Cecchi, Simona Ceccobelli, Paola Colasanto, Erika Crosetti, Ludovica Galloorsi, Claudia Gasparini, Elisa Nicosia, Zoe Romano.
Ore 21.20 – IN MY SHOES
Proiezione in anteprima del video sulla storia di lotta e emancipazione di un gruppo di operaie serbe, prodotto da

ORE 21.30 – IL VERO COSTO DELLE NOSTRE SCARPE
Public speaking con interventi di:
Luca Borzani (Fondazione Cultura Palazzo Ducale), Deborah Lucchetti (Fair / portavoce Campagna Abiti Puliti), Sara Conforti (artista/attivista. autrice di progetti per l’attivazione della partecipazione pubblica), Sara Farolfi (giornalista)
EVENTO - Il vero costo delle nostre scarpe - Torino - 8 marzo 2017

Ore 19.30 – 13600HZ Concerto per macchine per cucire VII Edizione
Arrivato alla sua sua VII edizione il progetto performativo 13600HZ Concerto per macchine per cucire (gia' presentato precedentemente al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Artissima 21 / Zonarte, Teatro della Cavallerizza Reale di Torino e Palazzo Ducale Fondazione per la cultura di Genova) presenta il suo nuovo tabeau vivent Sistemi Periodici +[Ar]3d54s1 - Damnatio Memoriae creato site specific per la Campagna Change your Shoes / Abiti Puliti. (www.abitipuliti.org) Un nuovo capitolo della ricerca artistica di Sara Conforti che approda ed accoglie il pubblico nella suggestiva cornice della storica Galleria Umberto I di Torino e realizzato attraverso 9 sessioni di ricerca condotte negli spazi del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea in collaborazione con la cittadinanza.Un lavoro corale creato attraverso il coinvolgimento del pubblico femminile in pratiche partecipate dedicate alla condivisione delle narrazioni di vita vissuta legate alla memoria delle proprie calzature d'affezione al fine di costruire un atto universale che dall'auto_rappresentazione apre la strada a nuove forme di esperienza collettiva attraverso il gesto e il suono. In collaborazione con:Francesca Cinalli (Coreografie/Drammaturgie) Paolo De Santis, Luca Morino, Pierluigi Pusole (sewing machines orchestra) Massimiliano Monnecchi (Fotografia e documentazione)
Ore 20.45 – IN MY SHOES
Proiezione in anteprima del video sulla storia di lotta e emancipazione di un gruppo di operaie serbe, prodotto da

ORE 21.00 – IL VERO COSTO DELLE NOSTRE SCARPE
Public speaking con interventi di:
Sergio Cofferati (europarlamentare del Gruppo Socialisti e Democratici), Deborah Lucchetti (Fair / portavoce Campagna Abiti Puliti), Sara Conforti (artista/attivista. autrice di progetti per l’attivazione della partecipazione pubblica), con la moderazione di Giorgia Marino, giornalista de La Stampa - Tuttogreen.
Evento - Le nuove schiavitù

Gruppo consiliare Si Toscana a Sinistra e Campagna Abiti puliti presentano
“LE NUOVE SCHIAVITÙ”
Auditorium Consiglio Regione Toscana – Via Cavour 4 - Firenze
28 gennaio 2017, ore 9,30-13
Collegamento in streaming/registrazione audio-video
Saluti del Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani
Le ragioni politiche di questo convegno
Tommaso Fattori - Capogruppo Si Toscana a Sinistra CRT
Nuove schiavitù nelle filiere globali dell’abbigliamento e delle calzature
Deborah Lucchetti (Fair/Campagna Abiti Puliti)
Il lavoro interinale ovvero la precarietà organizzata
Antonio Di Stasi – Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Politecnica delle Marche
Il lavoro nero e il caporalato come nuove forme di schiavitù
Roberto Iovino - Coordinatore Osservatorio Placido Rizzotto FLAI CGIL
COFFE BREAK equo-solidale
Presentazione videoinchiesta "Il caporalato nei vigneti toscani"
Jacopo Storni – giornalista
Precarietà e nero nel distretto di Santa Croce
Francesco Gesualdi - Centro Nuovo Modello di Sviluppo/ Campagna Abiti Puliti
Papa Demba - UIL TEC
(2016) REPORT - Il lavoro sul filo di una stringa
Il «made in Europe» è spesso considerato una garanzia di qualità e di buone condizioni di lavoro. Numerose inchieste realizzate nell’ambito del progetto Change Your Shoes hanno però rivelato un lato nascosto dell’industria calzaturiera, dalle concerie toscane fino alle fabbriche dell’Est Europa. Scarpe «italiane» o «tedesche» ma in realtà prodotte in fabbriche in Macedonia o Albania, dove decine di migliaia di operaie lavorano in condizioni scandalose e per salari spesso inferiori a quelli retribuiti in Cina. Dall’esame delle condizioni di lavoro in queste aziende possiamo concludere che l’esternalizzazione delle produzioni condotta dai marchi europei verso i paesi dell’Est Europa non si basa su processi di responsabilità e trasparenza. E non produce dignità e benessere per le lavoratrici che vivono in situazione di povertà e spesso di miseria.
Nel 2014 nel mondo sono state prodotte 24 miliardi di paia di scarpe. Benché la maggior parte provenga dall’Asia, il 23% delle scarpe di pelle, più costose, viene prodotto in paesi europei, fra i quali spicca l’Italia. È inoltre in Italia che avviene il processo di conciatura del 60% di tutto il cuoio prodotto nell’Unione Europea. Questo compito gravoso viene spesso affidato ai lavoratori immigrati, un fenomeno ben visibile nelle concerie intorno a Santa Croce, in Toscana, come racconta Una dura storia di cuoio, un’indagine che descrive la realtà di queste migliaia di lavoratori che quotidianamente maneggiano carichi pesanti e sostanze chimiche senza protezioni adeguate.
Non di rado le fasi più onerose della produzione vengono esternalizzate in paesi dell’Est Europa, consentendo così alle marche italiane e tedesche di trarre profitto dalla manodopera a basso costo e dai tempi di produzione più brevi. Con il rapporto Il lavoro sul filo di una stringa, curato da Public Eye e ENS, la campagna Change Your Shoes è entrata nelle fabbriche di sei paesi dell’Est Europa per raccontarne le difficili condizioni di lavoro. In Albania, Macedonia e Romania il salario minimo si situa fra i 140 e i 156 euro mensili, cifre inferiori a quelle previste in Cina. Per poter mantenere le proprie famiglie le operaie dovrebbero guadagnare da quattro a cinque volte tanto
Venendo pagate a cottimo, spesso le lavoratrici preferiscono poi rinunciare ai guanti o ad altro materiale di protezione contro le colle e le sostanze chimiche che devono maneggiare, così da poter lavorare più rapidamente. Similmente all’industria tessile, il settore calzaturiero è affetto da problemi strutturali che non si fermano di fronte alle frontiere europee.
La nostra indagine mostra anche che marche e distributori non si interessano abbastanza alle condizioni di lavoro nelle fabbriche in cui le scarpe vengono prodotte. Dalle interviste svolte e dai siti web delle aziende risulta che la produzione è realizzata interamente per conto di noti marchi e catene distributive che operano sui mercati dell’Unione Europea, fra questi Zara, Lowa, Deichmann, Ara, Geox, Bata, Leder & Schuh AG, Ecco. A tutti i marchi e distributori coinvolti chiediamo di assumersi le proprie responsabilità e di mettere in atto le misure necessarie affinché il rispetto dei diritti umani sia garantito nella totalità della loro catena di produzione. Soprattutto, che si impegnino perché agli operai ed alle operaie venga versato un salario dignitoso.
Materiali
 |
 |
| SCARICA IL REPORT COMPLETO | SCARICA IL FACTSHEET |
Leggi anche
Scarpe «made in Europe» e i salari da fame ai lavoratori dell’Est Repubblica
Salari da fame e sfruttamento. Il lato oscuro delle scarpe “made in Europe” Corriere della Sera
Le scarpe europee «prodotte all’Est da operai sfruttati» Avvenire
Scarpe ‘made in Europe’, ma con paghe da fame: “Le fabbriche dell’Est? Peggio che in Cina” Il Fatto Quotidiano
SCARPE «MADE IN EUROPE», SALARI DA FAME Valori
Scarpe made in Europe, salari da fame Sbilanciamoci
Diritti, Change Your Shoes denuncia: scarpe “made in Europe” ma salari da fame Help Consumatori
Scarpe ‘made in Europe’, salari da fame: nuovo report sul lavoro nell’Est Europa GONews
Scarpe made in Italy ed Europe: salari da fame nelle fabbriche in Macedonia, Albania e Romania GreenReport
Evento di presentazione
Alcune foto dell’evento “Il lavoro appeso a un filo – I diritti dei lavoratori nell’est Europa” che si è svolto presso l’Università di Padova. Un’occasione per riflettere sui processi produttivi e i fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’Est Europa alla luce del Report “Il lavoro sul filo di una stringa”
EVENTO: Il lavoro appeso a un filo - I diritti dei lavoratori nell'est Europa
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE / ORE 9.30 – 13.00
Università di Padova – Aula Magna, Dipartimento Fisppa
Via Cesarotti, 12 – Padova

ORE 9.00
Registrazione Partecipanti
ORE 9.30
Devi Sacchetto, Università di Padova
Introduce e modera il convegno
ORE 9.45
Deborah Lucchetti, Fair – Campagna Abiti Puliti
IL LAVORO SUL FILO DI UNA STRINGA
Il vero costo del lavoro nell’industria calzaturiera alla periferia produttiva d’Europa: Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Polonia, Romania e Slovacchia.
ORE 10.10
Giorgio Grappi, Università di Bologna
CONFLITTI LAVORATIVI LUNGO – LA CATENA DEL VALORE
La riorganizzazione logistica della produzione e le conseguenze sul lavoro.
ORE 10.45
Giulia Anita Bari, coordinatrice progetto Terragiusta Medici per i Diritti Umani
IMPORTARE IL LAVORO COME UNA COMMODITY
Come si erode la sicurezza sociale per i lavoratori meno tutelati e i migranti lungo le filiere globali dalle calzature all’agricoltura.
ORE 11.1O
Mario Iveković, Presidente Novi Sindikat (Serbia)
LE SFIDE PER IL SINDACATO INTERNAZIONALE
Quale solidarietà internazionale oggi fra lavoratori di diversi paesi di settori produttivi e servizi, e fra cittadini e migranti.
ORE 11.40
DOMANDE E DIBATTITO
ORE 12.10
PROSPETTIVE FUTURE
Ogni relatore condivide una proposta concreta: la cosa più importante da fare per ridare senso alla solidarietà internazionale e una speranza ai diritti lavorativi dei più vulnerabili.
Meng Han è stato giudicato colpevole e condannato a 1 anno e 9 mesi
Questa settimana l’attivista Meng Han è stato riconosciuto colpevole di “aver raggruppato una folla per disturbare l’ordine sociale” ed è stato condannato ad un 1 anno e 9 mesi di carcere. Dal momento che è già stato detenuto per 11 mesi, sarà rilasciato in 2 settembre 2017.
Condanniamo con forza questa sentenza. Meng Han si era impegnato per informare dei propri diritti i lavoratori e le lavoratrici di una fabbrica di calzature ed è già stato detenuto per mesi con contatti sporadici con un avvocato mentre la sua famiglia è stata ripetutamente molestata.
Chiediamo il rilascio immediato di Meng Han e la fine della repressione dei diritti dei lavoratori e della persecuzione degli attivisti e delle loro famiglie.
L’avvocato di Meng Han, Yan Xin, ha commentato così la sentenza: “Meng Han ha espresso alla corte la scelta di non ricorrere in appello. Tutto il processo è stato estremamente faticoso. Come difensore capisco la pressione che ha dovuto sostenere Meng Han e rispetto la sua scelta. Come avvocato però ho sostenuto indipendentemente il mio punto di vista, visto che per motivi soggettivi e oggettivi il fatto non costituisce un crimine, ma il tribunale non ha accolto la richiesta. Auguro a Meng Han e alla sua famiglia un felice e sereno futuro! “
Attivista cinese rischia l’ergastolo per aver sostenuto i lavoratori dell’industria delle calzature
Giovedì 3 e venerdì 4 novembre, l’attivista cinese per i diritti dei lavoratori Meng Han sarà processato dalla corte del distretto di Panyu nel sud della Cina. Meng Han è stato preso di mira dalle autorità cinesi dopo che l’uomo si era impegnato per informare dei propri diritti i lavoratori e le lavoratrici di una fabbrica che produceva calzature per marchi come Calvin Klein, Coach e Ralph Lauren. È accusato di “aver raggruppato una folla per disturbare l’ordine sociale” e rischia fino all’ergastolo.
Il 3 dicembre 2015 la polizia cinese ha eseguito una serie di retate a sorpresa nelle case e negli uffici di circa 50 attivisti e volontari appartenenti a gruppi impegnati nella difesa dei diritti dei lavoratori nella provincia di Guangdong.
Se da una parte gli arresti di Meng Han e degli altri attivisti sono chiaramente parte di una repressione generale nei confronti delle Ong che si battono per i diritti dei lavoratori in Cina, dall’altra questo improvviso giro di vite è riconducibile ad una specifica contesa presso la Lide Shoes Factory del distretto di Panyu, dove una serie di scioperi che hanno coinvolto più di 2500 lavoratori nel 2015 hanno portato ad una vittoria degli attivisti nella negoziazione con i datori di lavoro in tema di previdenza sociale, contributi per gli alloggi, straordinari e pagamenti delle ferie.
Mr Meng Han è in carcere da dicembre 2015. Da allora ha potuto avere qualche contatto con un avvocato solo sporadicamente, in violazione della legge cinese. Altri tre attivisti tra quelli arrestati sono stati processati alla fine di settembre 2016 e condannati a pene da 1 a 3 anni con sospensione condizionale. A quel punto, l’udienza per il caso di Meng Han è stata sospesa per ulteriori indagini.
Meng Han ha subito diverse intimidazioni durante la detenzione. Le autorità hanno esercitato pressioni affinché incriminasse uno dei suoi colleghi in cambio di una sentenza più accomodante. Anche la sua famiglia è stata vittima di intimidazioni: i suoi genitori sono stati costretti a trasferirsi dopo che dei teppisti non identificati hanno divelto la porta di casa con un’ascia.
Chiediamo ai marchi che si rifornivano presso la Lide Shoes Factory (Calvin Klein, Coach e Ralph Lauren) di assumersi le loro responsabilità e di intraprendere azioni adeguate affinché Meng Han e gli altri attivisti coinvolti vengano immediatamente rilasciati dalle autorità cinesi.
“Meng Han rischia di restare in prigione per anni solo per aver informato i lavoratori dei loro diritti. Se questi marchi credono nella libertà di associazione sindacale per i lavoratori che realizzano le loro scarpe, allora devono schierarsi dalla parte di Meng Han, mandando un chiaro messaggio alle autorità cinesi affinché l’attivista sia immediatamente e incondizionatamente rilasciato” dichiara Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti