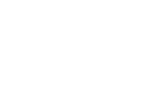Il 2 aprile, l’amministrazione Trump ha annunciato l’imposizione di pesanti tariffe commerciali a carico di paesi in tutto il mondo. Le alte percentuali imposte sulle importazioni statunitensi da nazioni produttrici di abbigliamento come Cambogia, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Lesotho e Vietnam comportano un impatto significativo sul settore, che sarà pesantemente colpito da queste misure. La rete della Clean Clothes Campaign invita le aziende di abbigliamento, statunitensi e internazionali, a «garantire che i costi di queste nuove politiche non vengano scaricati su coloro che meno possono permetterselo – le lavoratrici e i lavoratori – e ad assorbirli invece di trasferirli lungo la catena di approvvigionamento».
Evitare gli errori della pandemia
Le aziende della filiera dell’abbigliamento dovrebbero evitare di ripetere gli errori commessi durante la pandemia di Covid, quando le risposte impulsive delle multinazionali della moda alle avversità hanno dato priorità esclusivamente alla redditività, devastando finanziariamente milioni di lavoratori e lavoratrici che già percepivano salari di povertà. In molti dei Paesi in cui sono state annunciate tariffe elevate – come Cambogia, Sri Lanka e Bangladesh – i lavoratori sono già pagati al di sotto del livello di sussistenza e non hanno risparmi su cui contare. Ogni nuovo tentativo delle aziende di scaricare i costi sui lavoratori – abbassando i prezzi dei prodotti pagati ai fornitori, tagliando i salari, aumentando gli straordinari non pagati o mettendo a rischio i posti di lavoro con la delocalizzazione della produzione, li costringerà a ridurre i pasti e ad aumentare i debiti.
Guerra dei dazi: chi non deve assorbire i costi
Il settore dell’abbigliamento in questi paesi è dominato da grandi aziende statunitensi o attive a livello globale ricche di liquidità, come Victoria’s Secret (6,2 miliardi di dollari di fatturato nel 2024), Levi’s (6,4 miliardi di dollari), PVH (Calvin Klein, 8,7 miliardi di dollari), Gap (15,1 miliardi di dollari) o Nike (51,4 miliardi di dollari). Inoltre, molte fabbriche negli stati colpiti sono di proprietà di ricchi gruppi industriali che operano in tutto il Sud e Sud-Est asiatico, come Mas Holdings con sede in Sri Lanka ma attiva a livello globale, del valore di quasi 800 milioni di dollari. Qualsiasi costo aggiuntivo causato dalla politica tariffaria statunitense dovrebbe essere assorbito da queste aziende, anziché essere scaricato a valle della catena di approvvigionamento.
La responsabilità delle grandi aziende
Sono già visibili i primi segnali della tendenza a scaricare i costi lungo la catena di fornitura e ad abusare della situazione per tagliare le spese e ridurre i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Secondo quanto riferito dai media, diversi marchi ai vertici delle catene di approvvigionamento come Gap, Walmart e Levi’s, hanno già iniziato a chiedere una riduzione dei prezzi o a sollecitare i fornitori a sostenere l’onere delle tariffe nella loro interezza. Poiché i prezzi attuali pagati ai fornitori sono già insufficienti a garantire salari e condizioni di lavoro dignitose, è chiaro che il prezzo di questi sconti forzati alla fine sarà pagato dai lavoratori. Anche le federazioni dei datori di lavoro di diverse aziende produttrici di abbigliamento hanno già iniziato a minacciare ripercussioni, cadendo nella trappola di favorire la concorrenza regionale. Sotto la minaccia di una delocalizzazione dei posti di lavoro in altri paesi meno colpiti dalle tariffe, vengono proposti tagli ai salari e aumenti dell’orario di lavoro. È importante che i lavoratori dei paesi produttori di abbigliamento adottino un approccio condiviso per affrontare questo problema.
Diversi Paesi colpiti dalle tariffe, come Cambogia, Sri Lanka e Indonesia, hanno iniziato a contattare il governo Trump per negoziare condizioni migliori. In Sri Lanka è già stato formato un comitato ma tra le sue fila ci sono solo rappresentanti dei datori di lavoro e del governo. È fondamentale che i sindacati dei lavoratori dell’abbigliamento, in quanto principali rappresentanti di coloro che sono potenzialmente più colpiti dalle misure, partecipino al tavolo, soprattutto a fronte del fatto che gli imprenditori sono già coinvolti nella discussione.
Proposta di un fondo di garanzia
Dopo l’esperienza della pandemia Covid-19, durante la quale lavoratrici e lavoratori in tutto il mondo hanno perso il lavoro o non hanno ricevuto l’intero salario a causa delle scelte delle aziende che controllano la catena di fornitura, la fiducia dei lavoratori e dei loro sindacati nella possibilità che le aziende diano priorità al loro benessere è comprensibilmente bassa.
«La proposta di un fondo di garanzia sostenuta dai sindacati per assicurare ai lavoratori un indennizzo in caso di perdita del posto di lavoro in tempi di crisi è stata finora respinta dai marchi. È fondamentale che questa volta le lavoratrici e i lavoratori che già sopravvivono con salari miseri, non paghino il conto al posto di aziende che fanno profitti enormi e abbiano un posto al tavolo delle decisioni più importanti», ha dichiarato Deborah Lucchetti, coordinatrice nazionale della Campagna Abiti Puliti.