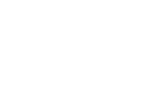Abbiamo partecipato alla stesura del Rapporto 2024 dell’associazione Slaves no more intitolato “Donne gravemente sfruttate. Il diritto di essere protagoniste” con un contributo sulla condizione delle lavoratrici nella filiera della logistica della moda.
Storie di donne che da una condizione di sfruttamento sono riuscite a emanciparsi, grazie alla determinazione nella difesa dei propri diritti e a una ritrovata consapevolezza di classe.
Attraverso le interviste alle divere protagoniste, Deborah Lucchetti ed Ersilia Monti hanno ricostruito e aggiornato la storia di due casi esemplari di sfruttamento, per una riflessione collettiva sulle strategie di lotte di successo.
Per la versione integrale del Rapporto, scrivere a: onlusslavesnomore@gmail.com
Donne che non hanno paura*. Dallo sfruttamento all’emancipazione nella logistica della moda
di Deborah Lucchetti ed Ersilia Monti
L’ultimo miglio
È il nome tecnico per l’ultimo viaggio delle merci verso le nostre case o verso i negozi delle città, la fase finale delle lunghe e articolate catene globali di fornitura che attraversano i paesi di produzione alle periferie del mondo per ritornare in Europa, uno tra i principali mercati di sbocco di tonnellate di merci prodotte ogni anno grazie allo sfruttamento di lavoro povero e di materie prime vergini. Nel caso della moda, parliamo di circa 24 milioni di paia di scarpe e 100 miliardi di capi di abbigliamento che vanno ad alimentare il consumo esasperato di beni non essenziali che finiscono rapidamente nelle discariche a cielo aperto del Sud globale, o inceneriti, dopo lunghi periodi di inutilizzo nei nostri armadi1.
L’ultimo miglio presenta significative sfide e criticità per riuscire a rispondere a consumatori sempre più esigenti, che pretendono di vedere soddisfatti i propri desideri entro le 24 ore, come promettono i giganti delle piattaforme digitali che hanno visto esplodere i loro fatturati dopo la pandemia. La logistica, in genere percepita come mera funzione tecnica per garantire il massimo soddisfacimento dei bisogni dei clienti-consumatori, innerva i nostri territori come il sistema arterioso attraversa il nostro corpo, garantendo la sopravvivenza del sistema economico, ma non necessariamente il benessere delle comunità e dell’ambiente.
Secondo alcuni dati, infatti, il 30% delle emissioni di CO2 e il 20% del traffico sono causati proprio dalle consegne dell’ultimo miglio che, con il boom dell’e-commerce, in crescita media dell’8% all’anno, rischiano di rendere le città sempre più invivibili e trafficate2.
La fase finale di consegna della merce coinvolge diversi attori, in una logica spinta di subappalto che favorisce una forte segmentazione e precarizzazione del mercato del lavoro: dalle cooperative che gestiscono i magazzini per conto dei colossi della logistica al servizio dei brand, ai trasportatori e fattorini che recapitano i pacchi nelle case o nei negozi, all’interno di spazi urbani in rapida trasformazione sempre più funzionali al commercio online e ai grandi hub logistici sperduti alle periferie dei grandi centri urbani3. Nella logistica, fase cruciale della catena di fornitura, convivono migliaia di lavoratori e lavoratrici con diverso status contrattuale, spinti a competere per la sopravvivenza da un regime di reclutamento su base etnica che utilizza il subappalto come strategia di sfruttamento dei lavoratori più vulnerabili, i migranti, e tra questi le donne, costretti ad accettare qualunque lavoro per mantenere il permesso di soggiorno. A differenza degli altri lavoratori precari, le donne migranti scontano una situazione di tripla vulnerabilità (status contrattuale, cittadinanza e genere), non potendo godere appieno dei diritti politici e civili nel paese in cui vivono e lavorano4.
Questo mercato del lavoro secondario, dove sono segregati i lavoratori più vulnerabili, senza strumenti, conoscenza delle leggi e dei loro diritti, rinforza divisioni e gerarchie interne ai processi lavorativi, utilizzate dal management per dividere e mettere in competizione i lavoratori.
Turni estenuanti, bassi salari, mancato rispetto dei diritti fondamentali e dei contratti collettivi sono la norma, specialmente nelle cooperative che fioriscono quale forma societaria prevalente ormai priva delle caratteristiche originarie di autogestione e partecipazione democratica da parte dei soci lavoratori. Nella logistica, in Italia, sono proprio le cooperative a fare da foglia di fico a un sistema fondato sulla esternalizzazione sistematica dei servizi per comprimere al massimo il costo del lavoro e ricercare il massimo beneficio fiscale. Nei negozi, snodo terminale della filiera di trasformazione, troviamo ancora prevalentemente donne, sfinite da ritmi e orari di lavoro estenuanti che spingono molte commesse a licenziarsi, anche senza avere prospettive. La vita delle commesse, sempre in vetrina sotto il controllo incrociato dei manager e dei clienti di cui devono compiacere ogni desiderio anche se le trattano come automi a loro totale servizio, è l’altra faccia dello sfruttamento annidato nell’ultimo miglio, dove tutto deve correre liscio, senza turbolenze e ritardi.
Lungi dall’essere mera funzione tecnica misurata attraverso indicatori di performance, la logistica in realtà si configura anche come spazio politico di sorveglianza e disciplina mento dei lavoratori, le cui potenziali rivendicazioni costituiscono una forte minaccia alla stabilità del sistema. La logistica, infatti, è uno dei punti della catena di fornitura più vulnerabili, costosi e difficili da gestire, per cui i grandi gruppi adottano apposite strategie preventive per scoraggiare l’organizzazione dei lavoratori. Lungo l’ultimo miglio si fronteggiano due vulnerabilità asimmetriche: da una parte Golia, con i giganti dell’industria che in questo tratto di gestione e passaggio obbligato delle merci prestano il fianco a potenziali azioni di disturbo e interruzioni di servizio non tollerate dal sistema; dall’altra Davide, con le lavoratrici più vulnerabili sotto costante ricatto, le outsider senza cittadinanza, segregate nell’ombra del mercato del lavoro secondario, che possono decidere di organizzarsi e inceppare il flusso, cambiando l’ordine del discorso. È la storia delle operaie impiegate nei magazzini italiani di due giganti della moda: parliamo del polo logistico di H&M a Stradella, in provincia di Pavia, e di quello di Yoox all’Interporto di Bologna. Due casi esemplari di cosa può accadere quando un gruppo di operaie, di cui molte migranti, prende coscienza dei propri diritti e decide che non è più tempo di tacere.
Viaggio nella logistica del lusso: il caso Yoox
«Loro ti assumono perché tu sei straniera. Sei arrivata da un paese che sei già sottomessa. Non conosci la legge. Non conosci i tuoi diritti. Sei collegata a un permesso di soggiorno»
(Amina, operaia immigrata sindacalizzata, magazzino Yoox. Interporto di Bologna).
«Siamo le operaie che lavorano da anni negli appalti Yoox, il colosso dell’e-commerce dell’abbigliamento, che nel mondo vende la sua immagine di azienda “sensibile”, che si cura dei bambini, della diversità e delle persone. Noi però lavoriamo dall’alba alla sera dietro i vetri scintillanti della grande sede dell’Interporto di Bologna. Siamo quasi tutte donne che lavorano per vivere e costruirsi un futuro, siamo madri che lavorano per dare un futuro ai propri figli e alle proprie figlie. Siamo tante e proveniamo da tutti i paesi del mondo, siamo
italiane e siamo migranti».
Inizia così l’appello lanciato dall’Assemblea donne del Coordinamento migranti di Bologna nel dicembre del 20205 a sostegno della lotta delle operaie della logistica di Yoox, il colosso di e-commerce specializzato nel lusso, nato nel 2000 dall’imprenditore italiano Federico Marchetti. Con una laurea alla Bocconi e un master alla Columbia University, Marchetti rientra a pieno titolo nella iconica retorica degli innovatori che dal garage scalano successo e mercati con l’idea giusta al momento giusto. Vendere le collezioni di lusso dell’anno precedente tramite e-commerce sembrava il business perfetto, un grande favore ai brand per fare fuori gli stock eccedenti mentre effettivamente si poteva alimentare la narrativa vincente della sostenibilità: contro l’idea di spreco e scarsa qualità della fast fashion, finalmente la possibilità di comprare il lusso con un click, prodotti cari certo, ma di tutt’altra qualità e durata6. È così che, grazie a ingenti capitali di rischio, nel 2000 a Bologna nasce Yoox, la tech company pensata per portare il lusso online quando ancora non esistevano i social. Un nome evocativo, che richiama significati particolari, secondo quanto dichiarato dallo stesso fondatore in un’intervista: i cromosomi femminile e maschile uniti alla doppia o, come il doppio zero del codice binario o il simbolo dell’infinito. Yoox cresce rapidamente, diventa ben presto una delle più forti digital company europee, nove anni dopo sbarca in borsa e continua la sua scalata fino al 2015, anno in cui si fonde con un altro colosso svizzero dell’e-commerce controllato dalla Compagnie financière Richemont. Nasce così Yoox Net-A-Porter (Ynet), che dal 2018 non sarà più quotata in borsa per il buon esito dell’offerta pubblica di acquisto lanciata proprio dal socio svizzero.
Nel 2021 Marchetti lascia la guida della multinazionale dai fatturati stellari7 dopo avere investito, a suo dire, in un modello di impresa focalizzato sul rispetto e sulla sostenibilità, con tanto di pacchi in cartone riciclato ed energia rinnovabile per gli edifici e i magazzini. In effetti, basta fare un salto sul sito per trovare le tracce di questo impegno etico e ambientalista. Se siete alla ricerca di prodotti di moda sostenibile, provate a cliccare su Yooxygen, nella categoria Better for people, dove Yoox ha selezionato prodotti e brand «dedicati a sostenere le comunità con cui lavorano in tutte le fasi della catena del valore […], che promuovono gli standard sociali più elevati e lavorano con Ong riconosciute a livello internazionale». Facendo un rapido test, però, il primo prodotto in offerta è una T-shirt di Adidas a 22 euro8, ciò che a un occhio più attento solleva almeno due problemi. Il primo è che non è affatto chiaro in virtù di quali criteri il prodotto sia stato selezionato nella categoria della sostenibilità. Il secondo, ancora più rilevante ai fini di questo racconto, riguarda il fatto che Adidas dal 2020 è uno dei principali target della campagna internazionale PayYourWorkers9. Nata durante la pandemia per denunciare il furto di milioni di dollari in salari e Tfr non pagati e comportamenti antisindacali ai danni delle lavoratrici impiegate nelle filiere dei principali marchi della moda internazionale, la campagna ha individuato Adidas tra i marchi più negligenti. Migliaia di lavoratori, con salari da fame già prima della crisi Covid-19 – in maggioranza donne, razzializzate e spesso migranti – sono stati licenziati o ulteriormente impoveriti a causa dei comportamenti commerciali sleali e irresponsabili dei marchi per cui producono abbigliamento e scarpe in Cambogia, Thailandia, Bangladesh, Sri Lanka, El Salvador, Indonesia, per citarne alcuni. Marchi che non hanno esitato a lasciare al loro destino migliaia di operaie impiegate dai loro fornitori, cui hanno tagliato ordini e prezzi di acquisto durante la crisi, compaiono sul sito di Yoox tra i campioni della responsabilità sociale. Quelle operaie attendono ancora giustizia. Le loro biografie e condizioni di lavoro, con le differenze di contesto, non sono così distanti da quelle delle operaie impiegate nella logistica di Yoox all’Interporto di Bologna: donne, migranti, madri sfruttate e costrette a lavorare in condizioni pessime, finché non hanno deciso di alzare la testa. Quella della lotta delle operaie dei magazzini della Yoox è una storia esemplare. La storia di un gruppo di donne, madri e migranti, che dopo anni di lavoro al freddo, senza riscaldamento e aria condizionata, con un bagno unico per donne e uomini, senza buoni pasto, livelli adeguati, diritto all’allattamento e con un salario massimo di 800 euro al mese per 9 ore al giorno, compresi i festivi non pagati, decidono di dire basta. La loro lotta comincia nel 2014, in prima linea all’inizio ci sono i colleghi uomini, che però poi se ne vanno a fronte di una cospicua buonuscita. I problemi invece restano e a un certo punto qualcosa cambia. «La prima che ha preso la maternità era una ragazza del S.I. Cobas. Lei è andata, tremava tutta, ha detto: “Io ho il diritto all’allattamento”. Era la prima. Poi mi sono svegliata anch’io», racconta Amina, una delle lavoratrici leader del S.I.Cobas10. Le operaie cominciano a prendere parola, rivendicano direttamente i propri diritti, non delegano più agli uomini e giorno dopo giorno si emancipano: «Abbiamo imparato tante cose. È la lotta che ci ha fatto imparare queste cose. Ecco perché loro non ci vogliono più adesso. Vogliono la nuova generazione. Vogliono uno che ha ancora 18 anni […]. Si prendono i nostri figli. Io adesso che sono diventata mamma, ho una figlia di 13 anni. Per me è come se prendono la mia bimba e la sfruttano. Per quello ti dico: io queste cose non le voglio, né per mia figlia, né per tua figlia, né per i figli di tutto il mondo», continua Amina.
La goccia che fa traboccare il vaso è l’imposizione dei turni nel pieno della pande mia che costringerebbe le operaie ad abbandonare i loro figli piccoli, senza possibilità di accompagnarli e andarli a prendere a scuola perché il primo turno comincia alle 5,30 e il secondo finisce alle 22,30. Già dal 2014 le operaie avevano organizzato scioperi e proteste contro molestie e trattamenti punitivi avvenuti all’interno dei magazzini, ma nel 2020, in piena pandemia, con il fallimento della cooperativa e il cambio dell’appalto, Yoox in accordo con la nuova azienda appaltatrice e il benestare di Cgil e Cisl, decide di «riformulare l’organizzazione del lavoro» non lasciando scelta. Adeguarsi o licenziarsi, rinunciando pure al sussidio di disoccupazione. Molte si licenziano, non riescono a conciliare i loro tempi di vita con il lavoro, ma un gruppo resiste e porta il problema dentro l’Assemblea donne del Coordinamento migranti di Bologna di cui alcune fanno parte. E così «il 25 novembre 2020, giornata nazionale contro la violenza sulle donne, un gruppo formato da 30 lavoratrici, madri e migranti della Yoox, insieme al sindacato di base S.I. Cobas, al Coordinamento migranti di Bologna e al sostegno del movimento femminista Non una di meno, inizia la protesta davanti ai cancelli di Yoox all’Interporto di Bologna. La lotta sindacale delle lavoratrici riesce a uscire dai cancelli dell’Interporto e viene diffusa sui giornali, in televisione e sui social network, a livello cittadino e nazionale. Dopo la prima settimana di picchetti, con conseguente blocco dei diversi magazzini, le lavoratrici, insieme al sindacato S.I. Cobas, al Coordinamento migranti e a Non una di meno, si trovano in presidio sotto la prefettura di Bologna»11. La lotta delle operaie Yoox arriva alle istituzioni locali con le quali le lavoratrici hanno sempre cercato di dialogare per chiedere un intervento pubblico a protezione dei loro diritti basilari. Le operaie però vengono screditate, le loro denunce sminuite e persino l’Ispettorato del lavoro, chiamato a intervenire su richiesta del Comune, non trova «nessun riscontro di gestione discriminatoria nella direzione dell’azienda di Lis Group»12, subentrata alla cooperativa Mr. Job. L’ultima delusione arriva l’8 marzo 2021. Mentre le operaie scioperano insieme a Non una di meno, i sindacati confederali siglano un accordo sulla genitorialità che le madri operaie in lotta ritengono del tutto insufficiente. Secondo l’accordo «chi avesse scelto di non licenziarsi e continuare a lavorare part-time si sarebbe vista il salario dimezzato, dovendo dipendere da mariti e compagni per mantenere la soglia minima della sussistenza con un salario e mezzo»13.
Solo a seguito del ricorso presentato dalla Consigliera di parità dell’Emilia- Romagna Sonia Alvisi, il 31 dicembre 2021, la giudice Chiara Zompì del Tribunale del lavoro di Bologna ha decretato la discriminatorietà della condotta di Lis Group Srl e ha ordinato «la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti delle discriminazioni accertate». Con la sentenza, il Tribunale del lavoro di Bologna riconosce che i turni imposti sono ingestibili e dice chiaramente che il turno centrale va ripristinato per tutte le lavoratrici con figli minori di 12 anni14. A Lis Group è quindi subentrata Geodis Italia Spa che ne ha assunto le dipendenti. Secondo quanto riscontrato pubblicamente, Geodis è stata posta in amministrazione controllata per frode fiscale, stipula di falsi contratti d’appalto e «sistematico sfruttamento di diverse migliaia di lavoratori»15. Un sistema di scatole cinesi che usa il subappalto per trarre il massimo profitto dall’impiego dei lavoratori più ricattabili: donne, operaie e migranti. Difficile non cogliere un’assonanza con le storie delle operaie tessili che confezionano i prodotti dei brand che Yoox promuove tra i campioni di responsabilità sociale sul suo sito di e-commerce. Il nuovo accordo siglato tra sindacati confederali e Geodis a gennaio 2024 16 dà la possibilità di fare il turno centrale solo alle mamme con figli sotto i tre anni e alle mamme single. Le operaie della Yoox hanno due mesi per riorganizzarsi e tornare a fare i turni. Si ritorna al punto di partenza, ma molte operaie nel frattempo si sono licenziate, le nuove assunte con contratti a termine hanno paura di parlare e del vecchio nucleo sindacalizzato sono rimaste in poche. Ma quel seme di resistenza che ha valicato i cancelli ha dato buoni frutti, come conclude Amina per questo articolo: «Io parlo per noi, per me, per le cose. Se loro non vogliono parlare, non vuol dire che gli piacciono le cose. Magari hanno paura, la prima volta è sempre difficile, anche per me era difficile. Magari arriva il loro giorno, perché ci sono quelle che non credevano che si sarebbero mai iscritte al nostro sindacato. Poi si sono iscritte…».
Viaggio nella logistica della fast fashion: il caso H&M
In un tempo non molto lontano, una lavoratrice nella filiera del colosso della fast fashion H&M così descriveva le sue condizioni lavoro: «Pensavo che la schiavitù fosse stata abolita due secoli fa!». La sua lettera aperta indirizzata nel 2018, in segno di solidarietà e vicinanza, alle operaie delle fabbriche sparse per il mondo che sfornano abiti con il marchio dell’azienda svedese, apriva una breccia in uno dei tanti fortini della logistica italiana. Nutriti di consumo di suolo agricolo, presidiati, videosorvegliati, molto simili per fisionomia, dimensioni e rigido controllo ai grandi impianti dell’industria delocalizzata, i capannoni della logistica, che costellano porzioni di territorio dell’Italia settentrionale, svolgono la funzione nevralgica di anello di congiunzione tra la produzione e la distribuzione delle merci. Quello che opera a Stradella, in provincia di Pavia, all’imbocco dell’autostrada Torino-Piacenza, è stato fino al periodo pre-pandemia il polo H&M più grande d’Europa, specializzato nelle vendite online con spedizioni destinate a una ventina di paesi. La gestione è di Gxo Logistics, azienda nata nel 2021 dallo scorporo dei servizi di logistica da quelli di trasporto del leader mondiale del settore, l’americana Xpo Logistics, presente nel sito dal 2014. Ma le maestranze, in maggioranza donne, cresciute da qualche decina fino a 700-800 unità nel periodo migliore, non sono dipendenti né di H&M né di Gxo. Ad assumerle è Easy Coop, cooperativa di servizi “specializzata in processi di terziarizzazione dei magazzini”, che gestisce il personale per conto di Xpo. Riproponendo anche in questo caso la logica che governa le filiere internazionali, quella dei subappalti a cascata, che rendono opachi i processi produttivi e facile agli investitori e ai committenti sfuggire alle proprie responsabilità quando si tratta di rapporti di lavoro.
Ritorniamo alla lettera di Paola17: «Donna sola, con due figli, sono abituata a lavorare sodo. Mai avrei immaginato però che H&M mi avrebbe stravolto la vita. Nell’enorme magazzino in cui lavoro, che all’epoca occupava 350 persone, per la maggior parte donne e stranieri, il turno iniziava alle 4,30 della mattina con nessuna certezza dell’orario di uscita. Un semplice sms, inviato la sera, fissava il tuo turno per il giorno dopo». Il lavoro è veloce e usurante: «Stavo in piedi per ore e ore scaricando senza sosta da un rullo le ceste per la cernita. Presto sono comparsi forti mal di schiena. Ho visto anche colleghe svenire per il caldo». Il lavoro cancella la vita privata: «Non avevo tempo nemmeno per una visita medica. Per non parlare della famiglia, degli amici o dello svago! In piedi dalle 3 del mattino riuscivo a malapena ad arrivare sveglia all’ora di cena».
Paola viene assunta come facchina il 1° giugno 2016 con un contratto a tempo determinato, come del resto l’80% dei colleghi in violazione delle leggi vigenti e del Ccnl. È una donna coraggiosa e combattiva, ne prende coscienza accettando di mettersi in gioco18: «Avevo preso servizio da 15 giorni, forse un mese. C’erano delle ragazze che preparavano un’assemblea sindacale. Non sapevo cosa fosse il sindacato e non ci sono andata, ma non ero tranquilla, in cuor mio sentivo di non aver fatto la cosa giusta. Poi a metà luglio mi presento la mattina per il turno delle 4 e davanti ai cancelli trovo un muro di persone con le bandiere del S.I. Cobas. È un giorno che non dimenticherò mai. Mi sono detta: hanno ragione, pazienza se non mi rinnovano il contratto. E mi sono unita allo sciopero». Paola diventerà una militante sindacale, parteciperà a numerose vertenze e ad altrettanti scioperi. Anche grazie a persone come lei la situazione migliora: calendarizzazione dei turni di lavoro, stabilizzazione dei tempi determinati, riposi, pause pagate, buoni pasto. La lotta sindacale del triennio 2016-2018 vede le donne in prima linea: «La gente non ha idea di cosa sia fare 16 ore di sciopero sotto la pioggia, con il sole, con la neve, con quelli che ti sputano addosso, con chi cerca di investirti. Ci sono stati momenti che abbiamo dovuto abbandonare di corsa il presidio perché eravamo in buona parte donne e la polizia stava per caricarci». La forza del sindacato di base nelle agitazioni della logistica è la solidarietà tra i magazzini, anche molto lontani: «Perché in un magazzino dove ci sono 30 iscritti, allo sciopero ne arrivano 200. Se c’era bisogno, si stava in presidio notte e giorno con le tende, anche le ragazze dormivano in tenda». Poi, prevedibilmente, arrivano le intimidazioni, le ritorsioni, la proprietà gioca la carta della paura con le denunce. Quella più clamorosa è presentata da Xpo nel 2018 contro il S.I. Cobas e ben 147 tra operaie e operai dell’impianto di Stradella per «danni patrimoniali e di immagine» causati dalle agitazioni sindacali nella misura di quasi 2 milioni di euro. Racconta Paola: «Xpo ha preso dei nomi a caso, dei 147 alcuni erano in malattia, altri non avevano mai partecipato agli scioperi». Il processo si concluderà nel 2021 con l’assoluzione di tutti i denunciati19, ma intanto si è insinuata la paura, gli scioperi sono sempre meno partecipati, cala il numero degli iscritti al sindacato. «In un magazzino con l’80% di lavoratori stranieri, ti ricattano con il rinnovo del permesso di soggiorno», continua Paola, «oppure il marito ti osteggia e tu non ti iscrivi più al sindacato». Presto arriva la misura più drastica, il taglio del personale. A metà novembre 2018 Xpo comunica la cessazione di 450 lavoratori assunti con contratti a tempo determinato in scadenza, tra questi ci sono iscritti al sindacato e persone che hanno partecipato agli scioperi. È in previsione per quell’anno l’apertura di un nuovo polo logistico in Polonia. Il frequente ricambio di personale, che il precariato e i licenziamenti rendono inevitabile, non facilita il consolidarsi di una memoria storica delle lotte sindacali a cui ispirarsi. È il cruccio di Paola: «Ci sono colleghi che non hanno la minima idea di quanto ci è costato ottenere i diritti di cui godono adesso. Pensano che sia sempre stato così. Vedo tanta apatia, poca voglia di mettersi in gioco».
L’intenzione di H&M di depotenziare il polo di Stradella in favore di due nuovi impianti esteri, localizzati in Spagna e in Portogallo, provoca un netto calo dei volumi di vendita, dapprima con la perdita di importanti paesi di sbocco come Austria e Svizzera, e più recentemente della Romania, paese che da solo contava il 30% dei volumi trattati. Le prospettive per il polo di Stradella sono tutt’altro che rosee. «Si prevede che chiuderemo l’anno con volumi dimezzati rispetto agli oltre 40 milioni di pezzi venduti il primo anno del Covid», dice Paola. «I magazzini in Spagna e Portogallo fanno il nostro stesso lavoro, ma la manodopera lì costa meno e a quanto ci risulta non sono sindacalizzati».
La fugace impennata di vendite durante il lockdown evoca in Paola ricordi sgradevoli: «Ci hanno classificato servizio essenziale perché rientravamo nel codice Ateco di supporto ai trasporti. Ce l’ho con la gente che ci ha inondato di ordini per cose inutilimentre qui rischiavamo il contagio. Non abbiamo mai chiuso, ma quelle tre ore in cui abbiamo incrociato le braccia perché non c’erano le mascherine ce le hanno detratte dallo stipendio».
La pandemia porta allo scoperto una crisi aziendale che covava da tempo. Stretta tra una concorrente dinamica che punta alla fascia alta come Zara e un marchio aggressivo che vende a prezzi stracciati come Shein (presente nel polo di Stradella da un anno con quasi mille dipendenti), H&M sembra incapace di rinnovarsi20. Avere puntato molto sui negozi fisici ed essere arrivata tardi sull’e-commerce la penalizza, mentre le prospettive di sviluppo non sono favorevoli. Ad aprile 2020, in pieno lockdown, l’azienda annuncia la chiusura di 8 negozi in tutta Italia, di cui 2 storici a Milano con 70 dipendenti. Le misure per l’emergenza pandemica vietano i licenziamenti, ma i trasferimenti imposti al personale subito dopo la ripresa delle attività economiche ne hanno tutto l’aspetto, tanto da far parlare i lavoratori di licenziamenti mascherati21. Il ricollocamento, comunicato con pochi giorni di preavviso, può riguardare infatti sedi distanti fino a 60 chilometri (più di 400 in un caso), e colpisce soprattutto le donne nei loro impegni di cura, in particolare le lavoratrici beneficiarie della legge 104 sull’assistenza a familiari disabili22.
A minare la credibilità di H&M ci sono anche le promesse che non ha mantenuto. Nel 2013 la multinazionale aveva dichiarato che entro 5 anni avrebbe garantito a 850.000 dipendenti dei suoi fornitori strategici un salario dignitoso. L’indagine condotta nel 2018 dalla Clean Clothes Campaign in 4 paesi produttori, nell’ambito della campagna TurnAroundH&M23, prova che nulla era nel frattempo cambiato: in India e in Turchia le paghe sono pari a un terzo e in Cambogia meno della metà della soglia stimata di salario dignitoso. In Bulgaria, paese dell’Unione europea, i lavoratori intervistati dichiarano di percepire un decimo di quanto servirebbe per condurre una vita dignitosa.
«È capitato di trovare nei capi biglietti con scritto “help”, altre frasi o numeri di telefono», riferiva nel novembre 2018 la delegata sindacale di un negozio H&M in un incontro tra delegati Filcams-Cgil e la Campagna abiti puliti in preparazione della settimana di mobilitazione a sostegno del salario dignitoso. Il primo e l’ultimo anello della catena produttiva della moda, la distribuzione, hanno in effetti molto in comune: orari di lavoro prolungati, anche nel fine settimana e nei festivi; difficoltà per il personale (80-90% donne) di conciliare i tempi di vita e di lavoro; intensi ritmi di lavoro; precariato con contratti a chiamata, di cui proprio H&M fa il maggior uso.
La pandemia ha rimescolato le carte aprendo scenari imprevisti. «Oggi il problema», dice Carla, commessa di un negozio Zara24, «sono i colleghi che si licenziano, spesso all’improvviso, anche senza avere prospettive, compresi madri e padri di famiglia». «Non ce la fanno più», commenta una funzionaria Filcams25. Una novità confermata da Paola: «Si trovano molti meno lavoratori. La mia cooperativa si è spinta fino a Bologna per cercare di integrare il personale in periodi di punta». Riconoscere il malessere dei dipendenti è il primo passo verso il cambiamento, anche per i clienti. «Siamo in balia della loro maleducazione, che l’azienda asseconda in tutti i modi, ed è aumentata dopo la pandemia», dice Carla. «Ci chiedono di “educarli”, ma non pongono regole. La mansione peggiore è il servizio ai camerini. Lì il cliente sente il via libera: porta dentro più capi che puoi, lascia il caos e quando esci butta tutto addosso alla commessa». «Lo slogan al tempo del Covid “Ne usciremo migliori” non ha funzionato», osserva la funzionaria Filcams, «il motto oggi è “Voglio tutto e subito”».
Conclusioni
Abbiamo visto in pratica che cosa significa lavorare nella logistica di alcuni grandi marchi della moda se si è donne, operaie e migranti. A loro è riservato il ruolo di lavoratrici di serie B dentro un mercato del lavoro duale, cioè che differenzia condizioni, salari e diritti a seconda della cittadinanza e del genere. Una ferrea divisione del lavoro che oppone gli insider, lavoratori tendenzialmente più protetti, impiegati nelle parti alte della filiera e rappresentati dai sindacati confederali tradizionali, agli outsider, lavoratori atipici, poco qualificati, sottopagati, in gran parte immigrati, impiegati nei subappalti e rappresentati prevalentemente dai sindacati di base. Di fatto è stato osservato che dagli anni Ottanta la conflittualità nel mondo del lavoro si è progressivamente spostata dai settori industriali ai servizi, secondo una logica di “terziarizzazione del conflitto industriale” che ha visto l’escalation di un variegato repertorio di azioni collettive: scioperi, sit-in, blocchi, proteste, assemblee aperte alla cittadinanza26. I sindacati di base hanno saputo meglio intercettare e rappresentare le istanze degli e delle invisibili, mettendo in campo strategie di lotta efficaci in grado di portare risultati tangibili ai lavoratori sfruttati dei magazzini, in prevalenza immigrati dal Nord Africa e dall’Asia. Come i casi che abbiamo analizzato mettono in evidenza, si possono estrapolare alcune componenti comuni che hanno contribuito al successo totale o parziale delle vertenze raccontate. La prima è legata alla capacità dei sindacati di base di organizzare forme di lotta efficaci in grado di mettere in difficoltà le controparti, agendo forme di conflittualità persistente,
radicale, e a volte coordinate tra lavoratori di diversi poli logistici. La seconda è legata all’estensione del conflitto ad altre parti della società che si sono mostrate solidali con le lavoratrici in lotta. È nella convergenza con componenti dei movimenti sociali, con le donne dei movimenti trans-femministi, gli studenti e gli attivisti delle Ong per i diritti umani che va cercata una delle chiavi del successo di queste vertenze, perché a un certo punto, come racconta Amina, l’operaia della Yoox: «La nostra voce è arrivata, grazie a voi, perché la consigliera regionale di parità non è che ci conosceva, capito? Lei ha letto qualcosa in Internet, di quelle donne. Ha visto le nostre foto, con le altre donne che erano lì di Non una di meno, con quelle del Coordinamento donne migranti.
Non è che eravamo solo noi»27. La voce delle donne in lotta per i loro diritti ha superato i cancelli dei poli logistici sperduti nell’hinterland del Nord Italia, ha raggiunto i media e raccolto il supporto di voci autorevoli della società civile, dell’accademia, dello spettacolo e delle istituzioni. Grazie a inedite alleanze e al lavoro organizzativo dei sindacati di base, le outsider hanno trasformato la loro vulnerabilità in forza collettiva, riconoscendo e agendo il loro potere posizionale. L’interazione tra un certo sindacalismo praticato nei movimenti sociali e il sindacalismo di base radicale ha consentito a queste vertenze di occupare nuovi spazi pubblici fisici e virtuali, dando voce alle invisibili. Vale certamente la pena soffermarsi sulle potenzialità del ruolo che possono assolvere le istituzioni quando svolgono con serietà il compito di proteggere i cittadini dai comportamenti abusivi e discriminatori derivanti dalla condotta delle imprese. Ci riferiamo in particolare ai consiglieri di parità i quali possono agire in giudizio su delega o in sostegno alle lavoratrici discriminate, esattamente come è successo a Bologna, dove il Tribunale del lavoro si è pronunciato a favore delle operaie immigrate, grazie all’impegno in prima linea della consigliera di Parità regionale. Volgendo lo sguardo all’Europa, proprio in questi giorni si sta concludendo il lungo e accidentato iter legislativo che porterà all’adozione della Direttiva sulla dovuta diligenza in materia di sostenibilità delle imprese. Si tratta di un accordo di compromesso, sicuramente non aderente alle iniziali aspettative della società civile che da decenni chiede al legislatore di intervenire per contenere lo strapotere delle multinazionali. Essa è però sicuramente un importante punto di partenza e strumento di sostegno a chi lotta per riequilibrare l’asimmetria di potere che regola le catene globali di fornitura. Una volta in vigore, imporrà alle imprese sopra una certa soglia dimensionale obblighi di vigilanza sulla catena del valore, dalla produzione alla distribuzione, per prevenire, mitigare e riparare eventuali impatti sui diritti umani e ambientali, con relative responsabilità e sanzioni in caso di violazione. La direttiva toccherà questioni cruciali quali la povertà salariale, le condizioni di lavoro pericolose e la discriminazione di genere, le pratiche commerciali abusive e sleali, oltre ai problemi ambientali.
Come i casi analizzati ci insegnano, nessun successo è destinato a durare, se non si conserva e nutre una forte capacità di organizzazione e mobilitazione collettiva, unitamente alla capacità di utilizzare le leggi e attivare le istituzioni preposte alla tutela dei lavoratori e delle comunità. Ecco dunque alcune finestre di opportunità che sarà bene conoscere e cogliere per contribuire a porre fine allo sfruttamento strutturale delle lavoratrici nella moda e non solo.
Poi c’è l’altra faccia della medaglia. Le storie raccontate mostrano anche i segnali di una crescente disaffezione al lavoro che sempre più lavoratrici e lavoratori preferiscono lasciare, anche senza alternative. Se il lavoro diventa solo competizione, sofferenza e avvilimento mentre ci ruba tutto il tempo di vita, anche la paura di perderlo a un certo punto viene meno. Si preferisce allora lasciare il campo, mettendo in atto meccanismi di sottrazione individuali e non organizzati, come atti estremi di liberazione28. Di fronte a un lavoro che è ormai prevalentemente violenza e sopraffazione non restano che due opzioni: organizzarsi o disertare.
* Il titolo scelto è ispirato all’Appello lanciato dall’Assemblea donne del Coordinamento migranti a sostegno dello sciopero delle lavoratrici Yoox. Le autrici ritengono che rappresenti perfettamente lo spirito dell’articolo.
1 Campagna abiti puliti, Il salario dignitoso è un diritto universale, 2022, https://www.abitipuliti.org/report/2022-report-il-salario-dignitoso-e-un-diritto-universale/.
2 https://www.fitconsulting.it/progetto-logistica-smart-verso-una-logistica-urbana-piu-efficiente-e-sostenibile/.
3 C. Benvegnù, B. Haidinger, D. Sacchetto, Restructuring labour relations and employment in the European logistics sector. Union’s responses to a segmented workforce, in V. Doellgast, N. Lillie, V. Pulignano (a cura di), Reconstructing solidarity. Labour unions, precarious work, and the politics of institutional change in Europe, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 83-103.
4 Ivi, pp. 83 ss.
5 Appello dell’Assemblea donne del Coordinamento migranti a sostegno dello sciopero delle lavoratrici Yoox, 9 dicembre 2020.
6 Intervista a Federico Marchetti, fondatore di Yoox, 30 ottobre 2023, https://lampoon.it/articolo/30/10/2023/federico-marchetti-avventure-innovatore-outsider-sostenibilita-yoox-origine-doppia-o-bill-gates-re-carlo-armani-recensione/.
7Nell’esercizio 2020-21 Yoox ha fatturato 944.231 milioni di euro (+10,6% su anno precedente), nel 2021-22 ha fatturato 1.453.154 miliardi di euro (+53,9% su anno precedente), nel 2022-23 ha fatturato 1.532.482 miliardi di euro (+5,5% su anno precedente). Il 23 agosto 2022 la Compagnie financière Richemont Sa ha ceduto il 50,7% delle azioni (quindi la maggioranza) alla piattaforma britannica Farfetch (il 47,5%) e a Symphony global (il 3,2%), quest’ultima è uno dei veicoli di investimento dell’uomo d’affari degli emirati, Mohamed Alabbar (bilancio 2023, p. 95).
8 Sezione Yoox denominata Yooxygen, come riportato sul sito: «L’area dedicata alla moda responsabile. Partecipa attivamente al cambiamento scegliendo brand e prodotti che promuovono un impatto sociale e ambientale», https://www.yoox.com/it/12650511VU/item#dept=xgnwmnclt&sts=SearchResult&co
d10=12650511VU&sizeId=10.
9 Sito internazionale della campagna PayYourWorkers. La campagna in Italia è coordinata dalla Campagna abiti puliti, https://www.payyourworkers.org/.
10 Intervista ad Amina (nome di fantasia), operaia immigrata sindacalizzata magazzino Yoox Interporto di Bologna, 6 febbraio 2024.
11 Intervista all’Assemblea donne del Coordinamento migranti, 2 febbraio 2024.
12 Ivi.
13 Ivi.
14 Intervista del 2 febbraio 2024 e dichiarazione dell’Assemblea donne del Coordinamento migranti, 8 gennaio 2022, https://www.coordinamentomigranti.org/2022/01/08/la-lotta-di-donne-operaie-e-migranti-sconfigge-la-yoox/.
15 Trasporto Europa, articolo online del 27 marzo 2023, https://www.trasportoeuropa.it/notizie/logistica/brt-e-geodis-vanno-in-amministrazione-giudiziaria/.
16 Accordo “Azioni positive” stipulato tra Geodis Cl Italia Spa e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti il 29 gennaio 2024.
17 Testo integrale della lettera in https://www.abitipuliti.org/wp-content/uploads/2018/11/Lettera-lavoratrice-polo-logistico-hm-Stradella-ita.pdf.
18 Intervista a Paola Sampino, lavoratrice della logistica di H&M, 13 luglio 2018; 9 febbraio 2024.
19 https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2021/06/22/news/la-logistica-chiedeva-i-danni-ma-i-sindacalisti-sono-assolti-1.40419452.
20 https://www.ilpost.it/2024/02/02/hm-crisi-dimissioni-ceo/; https://www.ilpost.it/2017/09/29/ci-troppi-negozi-hm/.
21 Lettera dei lavoratori trasferiti, https://www.facebook.com/AdlLombardia/posts/170527644511478; https://milanoinmovimento.com/movimenti/lavoratrici-e-lavoratori-hm-non-siamo-manichini-2.
22 Videoregistrazione lavoratori in presidio, https://youmedia.fanpage.it/video/aa/XwdYWuSwfYcFo31a?_ga=2.227962269.1880460127.1707240923-906380854.1704363963.
23 https://www.abitipuliti.org/report/paghe-da-fame-e-violazioni-nella-catena-di-hm/.
24 Intervista a Carla (nome di fantasia), commessa di Zara, 4 marzo 2024.
25 Intervista a funzionaria Filcams-Cgil, 12 marzo 2024.
26 K. Pilati, S. Perra, Trade unions and labour conflicts. Social movement and radical political unionism in France and Italy, in Italian Political Science, vol. 14, n. 3, 2020, pp. 167-187.
27 Intervista ad Amina (nome di fantasia), operaia immigrata sindacalizzata magazzino Yoox Interporto di Bologna, 6 febbraio 2024.
28 Intervista a Francesca Coin, in Pandora Rivista, 27 novembre 2023, https://www.pandorarivista.it/articoli/decifrare-le-grandi-dimissioni-intervista-a-francesca-coin/.
Bibliografia e sitografia
Aa.Vv., Carne da macello. Le lotte degli operai della logistica e il teorema repressivo contro il S.I. Cobas e le conquiste dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia, Red Star Press, Roma, 2017.
D. Bubbico, V. Redini, D. Sacchetto, I cieli e i gironi del lusso. Processi lavorativi e di valorizzazione nelle reti della moda, Guerini, Milano, 2017.
F. Coin, Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita, Einaudi, Torino, 2023.
A. Dordoni, Spre aperto. Lavorare su turni nella società dei servizi 24/7, Mimesis, Milano-Udine, 2019.
https://www.abitipuliti.org/
http://www.intotheblackbox.com/
https://www.transnational-strike.info/projects/east/em